L'edicola digitale delle riviste italiane di arte e cultura contemporanea
Juliet Anno 20 Numero 104 ottobre 2001
Biennale 2001
di Luciano Marucci e Valerio Deho'
La platea delle utopie/La collina del disonore
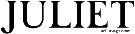
Art magazine
Adrian Paci
Maria Vinella
n. 173 giugno-luglio 2015
Case chiuse, corpi aperti
Roberto Borghi
n. 172 aprile-maggio 2015
Yang Xinguang e la materia
Sara Bortoletto
n. 171 febbraio-marzo 2015
Eugenio Re Rebaudengo
Giulia Bortoluzzi
n. 170 dicembre-gennaio 2015
Biennale Architecture
Gabriele Pitacco Marco Gnesda
n. 169 ottobre-novembre 2014
Biennale Marrakech
Emanuele Magri
n. 168 giugno-luglio 2014



La platea delle utopie.
Cara Venezia, dopo aver rinunciato alle solite interviste volanti della vernice per evitare distrazioni, mi solleciti un testo sulla tua Biennale. Ad essere sincero, a distanza di due mesi dall'apertura, non mi resta molto nella mente. Ci stiamo abituando a tutto e si riesce a memorizzare solo ciò che sa darci emozioni estreme. Per giunta, in questo momento - senza voler essere irriverente verso l'arte, né addentrarmi nella cronaca nera... - mi prendono di più certe problematiche che scuotono le coscienze. Con il clima sociale (e stagionale) che stiamo vivendo, parlare di mostre mi sembra quasi anacronistico ed è difficile potersi concentrare anche su avvenimenti importanti come il tuo, pur sempre estetici... Dopo che l'arte è stata liberata dalla schiavitù delle scuole e dei movimenti, dissertiamo volentieri della sua autonomia e non ci accorgiamo di vivere in stato di libertà condizionata... Comunque, ho scelto di fare questo mestiere anche per rifugiarmi nell'immaginario e sono condannato a criticare senza peraltro ricevere risposte gratificanti. Ecco allora alcune rapide impressioni e considerazioni sui tre frenetici e stancanti giorni dell'inaugurazione che, per affollamento, evocano le fiere dell'arte.
Ti premetto che stimo Szeemann come critico-organizzatore e persona animata da ideali; che, in genere, sono ben disposto nei confronti di quanti si impegnano (non solo per i soldi) nella concretizzazione di grandi progetti curatoriali.
Certamente questa 49esima edizione è concettualmente connessa a "dAPERTutto" di due anni fa e, per il largo uso delle nuove tecnologie, rappresenta uno sviluppo di Documenta X di Kassel.
Anche se manca un tema specifico e non vengono ufficializzate tendenze dominanti, il titolo "Platea dell'umanità" e la sua esemplificazione plastica, "Piattaforma del pensiero", lasciano individuare la filosofia che ha guidato il direttore.
Converrai che nel vasto percorso labirintico si incontra di tutto: Occidente e Oriente; realtà multietniche; creatività maschile e femminile senza gerarchie; esperienze manuali e multimediali; cinema; poesia; performance; luoghi del vissuto; mitologie individuali e opposte ideologie; problematiche femministe ed ecologiste, antropologiche e sociologiche; aspetti drammatici e ludici; agonismi; angosce e speranze della civiltà contemporanea che spesso vede calpestati i diritti umani.
Dunque, un panorama eterogeneo capace di stimolare una riflessione critica su chi siamo e dove stiamo andando, nell'arte e nel mondo.
Perseguire un obiettivo unitario in questa platea ba-belante non era facile e forse neanche auspicabile, dal momento che la creatività non segue regole rigide e la casualità fa parte dell'arte, oltre che del divenire della realtà. Senza contare che, in un sistema planetario, complesso e soggetto ai giochi di potere, molte cose possono sfuggire di mano...
Szeemann, avendo avuto un incarico pluriennale e altri suggestivi spazi, non ha resistito alla tentazione di allargare ulteriormente la manifestazione fuori dai Giardini, fino alla spaesante "Hollywood" palermitana di Cattelan. Ma non ha valutato che, per visitarla tutta con la necessaria calma e partecipare ai vari appuntamenti (oltre alle interminabili file all'Ufficio Stampa e ai padiglioni), occorrevano almeno dieci giorni. Tra l'altro, pur essendo migliorati i servizi, non è stato ancora affrontato il problema, apparentemente secondario, dei guardaroba (da tempo risolto a Kassel) per liberare i visitatori dalla croce dei cataloghi.
Va ricordato che il curatore, nel registrare l'esistente in ambito internazionale, ha operato una mediazione e auspicato un cambiamento per promuovere la coesistenza della diversità nella globalità, visto che le identità troppo radicate possono turbare la convivenza pacifica. L'assunto, seppure sacrosanto, si dimostra utopistico, almeno finché impererà il sistema capitalistico selvaggio con i suoi gruppi di potere che, per fini puramente speculativi, usano violenza ai singoli, alla collettività e all'ambiente.
Ai padiglioni è ancora evidente una certa diversità nazionale, ora meno accentuata nei paesi fino a qualche anno fa piuttosto 'arretrati': siamo ancora nel campo dell'osmosi culturale e degli arricchimenti linguistici.
Esemplari le partecipazioni della Germania con la casa-scultura del giovane Gregor Schneider; della Francia con i notturni 'giochi' di luci esistenziali di Pierre Huyghe; della Gran Bretagna con le conturbanti apparizioni di Mark Wallinger; degli Stati Uniti con il sincero psicodramma di Robert Gober.
All'Arsenale, invece, l'omologazione, a livello di tecniche espressive, era alquanto marcata con la massiccia presenza di foto, video-proiezioni e video-installazioni. Qui, per chi concepisce l'arte come movimento, le presenze erano sicuramente più vitali, anche se troppo somiglianti. Ad ogni modo i lavori erano ben diversi da quelli dei decenni passati, quando l'approccio al video era incerto, l'elaborazione informatica inesistente e la realtà virtuale incontrava forti resistenze. Fallita l'iniziale video-art (pressoché illegibile), con la crescita esponenziale delle tecnologie, si è capito che bisognava creare anche un più diretto rapporto tra opera e fruitore. Così siamo approdati al maxischermo, alla multimedialità e all'interattività, sconfinando nell'eccessiva spettacolarizzazione che può creare nostalgie per la tradizionale opera-mito. Purtroppo, molti artisti usano queste tecniche per ottenere un consenso basato più sull'originalità della forma che sui contenuti. In altre parole, c'è stato un adeguamento al sistema consumistico e alle sue tecniche comunicative-persuasive, all'immagine prodotta dagli stessi media, per cui sovente si cade nella banalità e in una sorta di nuovo accademismo. Questi mezzi, associati ai riti della quotidianità e al paesaggio urbano, affascinano senza richiedere riflessione..., mettendo a proprio agio i soggetti indifferenziati della nostra società e quanti la promuovono per trarne profitto.
Sul fronte opposto alle 'ricerche' impersonali si collocano gli artisti che cercano di ritrovare la loro individualità e di audodefinirsi. Alludo a quelli che sfruttano la corporeità, la sessualità, l'ideologia fino all'esasperata esibizione del privato. E, per questa strada implosiva, arrivano all'opera autoreferenziale, all'autoritratto, al suicidio..., ignorando la dialettica costruttiva con l'esterno.
A ristabilire un certo equilibrio... sopraggiungono i non allineati, gli artisti della denuncia, quelli che vengono etichettati come "sovversivi".
In questo incontro di esperienze contrastanti, è positivo constatare che l'arte cerca maggiori coinvolgimenti, contaminazioni disciplinari e pone al centro il destino dell'uomo, sia pure con una identità plurima.
Insomma, in questa Biennale si ha veramente l'impressione di trovarsi di fronte a un momento di passaggio dalla cultura di un secolo a quella di un altro, probabilmente cruciale per il futuro dell'uomo.
Tutto ciò, naturalmente, provoca l'allontanamento del gusto dall'arte più riservata legata allo specifico e dalle opere che richiedono tempi di lettura più lunghi.
Si spiega allora certo disinteresse per i dipinti (già ripudiati dai 'giudici' di Padre Pio), quasi monocromatici, di Gerhard Richter differenziati da sottili stratificazioni immateriali.
Cy Twombly, con i suoi grandi, raffinati acrilici, è riuscito a farsi notare, mettendo però a rischio la dimensione intima.
In un contesto simile pure le invenzioni al rallentatore di Bill Viola passavano quasi inosservate, nonostante egli stia andando oltre le intuizioni esibite nel 1995, che avevano generato tanti proseliti. Lo stesso valga per "Wall Piece", l'intrigante installazione video-sonora di Gary Hill.
Esemplare, secondo la logica di questa Biennale, la sequenza fotografica di Vanessa Breecroft sull'identità femminile, tra citazione pittorico-plastica e corporeità.
Altra luminosa... sorpresa Alessandra Tesi con le 'sue' metamorfiche proiezioni 'liquide'.
Restando in casa nostra, insufficiente anche se significativo, l'omaggio a Boetti, ancora da valorizzare appieno per la dadaistica leggerezza e la libertà nomadica.
Pure Rotella meritava di essere riproposto con più determinazione.
Riguardo ai premi, si sa che servono a 'giustificare' l'intera rassegna e a conciliare la qualità degli artisti arrivati con le innovazioni degli emergenti.
Quello a Serra era inevitabile anche per ringraziare chi ha sponsorizzato il trasferimento dell'imponente installazione.
Con Schneider sono state ricompensate le attese... di quanti non hanno voluto rinunciare ad avventurarsi nella sua "Dead House".
Soddisfacente lo 'special' alla brava Marisa Merz, con le sue visionarie testine femminili, intense, poetiche e così sobrie rispetto al gigantismo che ha toccato l'apice con il "Boy" di Ron Mueck e le mammelle speziate del brasiliano Ernesto Neto.
'Rappresentativo' il riconoscimento ai canadesi Janet Cardiff e George Bures Miller per la loro opera multisensoriale.
Ma su tutti il vero trionfatore è il mitico Beuys con la sua profonda e alta soggettività, maestro della nuova creatività in funzione della "social sculpture". "La fine del XX secolo" da lui 'preannunciata' proclama anche quella delle neoavanguardie...
E con questa nobile immagine simbolica che offusca tante altre, cara Venezia, io chiudo.
La Biennale, bella o brutta che sia, è sempre un tuo vanto; un evento straordinario che merita di essere vissuto; un appuntamento dove non vorresti incontrare nessuno e incontrare tutti. Perciò, arrivederci alla cinquantesima, sempre che, nel frattempo, la virtuale dittatura dei media globalizzanti non ci privi di questo piacere.
Nel frattempo Nedko Solakov, da moderno odisseo, continua per "A life" a far ri-dipingere metaforicamente la sua sala di "black et white". Che stia inconsapevolmente preparando l'ambiente ai veri restauratori della prossima edizione?
Luciano Marucci
La collina del disonore.
La "Piattaforma del pensiero" è una collinetta di colore porpora affiancata da muri verdi: sopra vi sono state deposte opere di vari artisti tra i quali lo svizzero Ettore Jelmolini, gli africani Semi Camara, Cheff Mwai, John Goba, il francese Auguste Rodin e altri. Inoltre si assiepano nell'esiguo spazio figure africane, maschere da ballo, un bodhisattva, sculture indiane, un quadro naif di uno scultore cubano, un elmetto da palombaro della Marina americana. La collinetta si vede subito, appena si entra nell'ex Padiglione Italia, già espropriato al nostro paese nel 1999 dallo stesso curatore di quest'anno: Harald Szeemann. In Italia abbiamo subito invasioni di tutti i tipi e sopravviveremo anche a questa. Ma la collinetta merita un ricordo solenne, perché se è questa la "Piattaforma del pensiero" che il direttore della Biennale consegna alla Storia, allora non la pensiamo come lui. Non è vero che tutto sia così banale, non è vero che il Terzo Millennio si annunci con una simbologia da bric à brac. Arte, souvenir, religione non sono ancora diventati sinonimi. Bella invece la metafora della collina. Su colline insignificanti come questa si sono perse e vinte le grandi battaglie, come sappiamo dalle mitiche epopee di guerra che il cinema e la letteratura hanno saputo ben raccontare. Ma ci vuole una posta in gioco, ci deve essere un senso di tragedia che aleggia nell'aria, altrimenti si tratta solo di una carina presa in giro.
Comunque, Mr. Szeemann ha chiamato la sua mostra la Platea dell'umanità, il che è già un passo avanti rispetto alla precedente edizione intitolata dAPERtutto. Il titolo merita una spiegazione, perché si tratta di una summa della contemporaneità. Il che equivale a dire, secondo le parole del curatore, "che oggi non si richiede più un'affermazione spasmodica della propria identità, ma si fa appello a ciò che di eterno c'è nell'uomo, sulla base del radicamento locale". Il nume tutelare di questa edizione è Joseph Beuys, come incitamento alla libertà, alla sua ricerca costante durante tutta la vita: è la creatività il capitale di cui abbiamo bisogno. L'opera scelta come simbolo è "La fine del XX secolo": ventuno pietre di basalto che ostruiscono la strada, che hanno bisogno del calore dell'arte per tornare a vivere, tracce di un magnetismo terrestre a cui dobbiamo ricongiungersi. E su Beuys siamo tutti d'accordo, come non esserlo?
Eppure, se partiamo dall'inizio dell'ex Padiglione Italia a rileggere questa Biennale, si possono fare delle piacevoli scoperte (tanto per essere gentili).
Le bandiere di Marco Neri sono un segno di fratellanza e uguaglianza: inno a tutte le nazioni senza distinzioni di ricchezza o peso nel sistema dell'arte internazionale e fanno pendant, guadagnandoci, con la collina del disonore di cui sopra. Tra le camere della morte di Lucilla Devlin, la testina di Marisa Merz spicca come una sopravvivenza di un passato di forma e poesia. Funziona perfettamente, si ritaglia con forza un ruolo, come i bassorilievi fumettistici di Eva Marisaldi, che sono frammenti di un contemporaneo non rassegnato a farsi consumare dal tempo. Straordinario è il lavoro del coreano Do-Ho Suh in cui milioni di pupazzini in plastica reggono un grande vetro che fa da pavimento alla stanza: il pubblico è obbligato a calpestare gli ominidi, che però non demordono e svolgono egregiamente la loro funzione sussidiaria. E se Nedko Solakov inscena una performance in cui due imbianchini si inseguono coprendo di bianco e di nero la parete che l'altro ha appena dipinto, Loris Cecchini gioca d'effetto, rappresentando il soffio vitale come un mantice che deforma le pareti di una stanza: sembra Mirabilandia con un estetica da disegno animato, con tutto il rispetto per Cartoonia.
Purtroppo gli omaggi ai grandi vecchi come Rotella e Twombly sono boomerang per gli artisti, che se non fossero ormai al di sopra delle beffe del destino artistico, non ne sarebbero contenti. Queste sale sono ridicole, bisogna capire perché le commemorazioni non funzionano alla Biennale. Forse non è il luogo giusto. Non si può fare una retrospettiva in mezzo al bailamme dell'arte attuale. Twombly ha portato delle opere recenti per posizionarsi nell'attualità, ma è chiaro che il pensiero (e il ricordo) del visitatore corre al passato. La presenza di Richter è ormai una costante, e non fa notizia. Per il resto uno splendido video di Gary Hill, apre sull'infinito mondo delle possibilità tecniche del mezzo, che inevitabilmente si schiudono all'Arsenale-Corderie.
Intanto ai giardini il percorso si snoda tra gruppi di tartarughe dorate lasciate lì da qualche buontempone (del gruppo Cracking Art) a guardare la video installazione di Lüthi presso il Padiglione svizzero in cui l'artista fa fitness per riprendersi da un attacco cardiaco. Mark Wallinger dai britannici ha presentato il suo "Ecce omo" fragile e antimonumentale da porre nella mitica Trafalgar Square e un video del 1997, piuttosto ripetitivo, in cui un cieco recita il vangelo di San Luca, mentre va a ritroso su di una scala mobile del Tube londinese. Robert Gober nel Padiglione USA racconta una vicenda tragicomica di delitti, attraverso prove, ritagli di giornale, in uno spazio in cui viene simulato un casuale allagamento (peraltro già risolto). Il risultato è quello previsto, che lo spettatore non capisce bene di che si tratta e avrebbe bisogno perlomeno di un opuscolo su come sopravvivere all'arte contemporanea. I giapponesi fanno della sociologia, smentendo l'assunto di Szeemann sui valori eterni dell'arte attuale, con simboli da fast food che cercano di diventare metafore dell'esistenza (forse già lo sono senza l'ausilio degli artisti). Bel cinema, quello realizzato da George Bures Miller e Janet Cardiff nel padiglione canadese, perché da un lato vi è una ricostruzione in scala di una sala cinematografica, dall'altro gli spettatori comunicano, involontariamente, attraverso le cuffie d'ascolto, le loro sensazioni. Il rapporto tra audio e immagini, subisce una sorta di straniamento. Gregor Schneider ha amplificato dall'interno il Padiglione tedesco, ricostruendo la sua abitazione con percorsi sorprendenti che costringono il visitatore a una performance non indifferente. In fondo ai giardini, accanto a uno stralunato padiglione austriaco, nel vecchio (e si vede) Padiglione Venezia, il Ministero per i Beni Culturali, ha organizzato una mostra del più grande artista italiano de secolo scorso, dopo Umberto Boccioni. Si parla di Alighiero Boetti. Mostra inutile e controproducente in quel contesto, ma che comunque manifesta la volontà del governo italiano di occuparsi di arte contemporanea e questo per il momento ci deve bastare.
Ron Mueck con un immenso bambino accovacciato e curioso di scrutare il pubblico entrante, ci dice, all'ingresso delle Corderie, che il futuro è già cominciato. Questi pupazzoni large size vanno molto, da alcuni anni e non distinguiamo più un artista da un altro. Non fa niente. Fanno molta impressione e questo sembra bastare. Il resto è video. Fino alla nausea, ma video.
Anche qui ci sono differenze sostanziali. Una star di "Apocalypse" come Cunningham si vede che sta bene di famiglia, perché produce dei video sofisticati e piuttosto pubblicitari. Un libanese, Anri Sala, ha filmato un vecchio poveretto che si addormenta in chiesa e fa fatica a rimanere seduto; titolo, "Duomo, uomo". Tutte queste le differenze? Ci sono anche alcuni documenti etnografici, molti valori riportati sulla terra qui e ora, molta voglia di ricordare genocidi e brutalità, emergono dai video di Fiona Tan e di Gianikian e Ricci Lucchi. E questa è una possibilità inesplorata di questa Biennale. Se nel Padiglione Italia le foto di Cristina Cordero, così straordinarie e vive nel loro bianco e nero, mettono in crisi tutto ciò che le sta intorno, alle Corderie il festival del cinema, vive di noie infinite. C'è una nostalgia di arte che vuole denunciare, che non vuole rassegnarsi a essere presa e lasciata come giochino per ricchi bambini.
Talvolta vi sono accelerazioni, e curiosità appagate, ma nel complesso la massa di videoarte ormai appiattisce la visione: tutto diventa uguale, anche perché si tende al cinematografico, come tempi, qualità e fruizione. Il fatto è che al cinema ci sono le poltrone e non dev'essere esattamente un obiettivo dell'arte contemporanea quello di rifare Hollywood. Nessuna durezza, nessuna asperità, nessun valore installativo, nessuna interazione. Tanto vale questi video scaricarli da Internet o vederseli a casa con una birra in mano.
Si può comprendere la sorpresa di trovarsi di fronte la stanza di Francesco Vezzoli, con l'ancora affascinante Vera Lehndorff, che ricama incessantemente il proprio volto. Tutto è perfetto e storicizzato. Gli oggetti richiamano la distanza da quegli anni settanta, in cui la modella era diventata un mito. Vezzoli ricostruisce filologicamente la trama del tempo. La bellezza di altre star, guarda dalle pareti. Il trucco viene deposto sulle tele con lavoro paziente. Vi è una dolce ossessione in questo lavoro, un'ossessione nel procedimento di elaborazione che corre affiancata all'azione dell'attrice. Però, accanto a lavori così intelligenti e ben realizzati, ci sono delle cadute verticali con stanzette piene di tampax o giungle di televisori che non trasmettono niente. Allora Sarenco l'Africano merita più di una menzione, perché si dichiara per quello che è ed è voluto diventare e perché ha reso la sua stanza un museo della sua Africa, con la collaborazione degli artisti che conosce da anni. Akpan in mezzo alle Corderie con una sua statua serenamente monumentale, è un re che distribuisce bacchettate ai ragazzini incolti e inesperti invitati a lasciare traccia delle loro cosucce. "Viva la differenza", ancora una volta, abbasso l'appiattimento in nome di qualcosa che nemmeno si conosce. I valori eterni sono borghesi, lo sapevano tutti quelli si sinistra dalla seconda metà dell'Ottocento in poi. Poi il Capitalismo trionfante ha fatto cambiare idea a tutti, anche a Szeemann. Non abbiamo fatto inutilmente la guerra ai "sacri e immutabili valori dell'arte", per dare credibilità agli artisti che cercano l'Eterno e vogliono solo incassare.
Allora, l'additio arsenalotta si arricchisce di spazi, sempre bellissimi ed emozionanti. Qui il curatore dimostra che sa essere un grande allestitore e distribuisce con leggerezza, pezzi da novanta che fanno bene al cuore. Finalmente Richard Serra alle Tese delle Vergini ci riporta all'emozione dell'arte, a quel misto di stupore e di religiosità a cui ci hanno abituato i grandi. E la semplicità, soprattutto. Un "rotolo" di ferro arrugginito del peso di 250 tonnellate ci accoglie in una spirale da cui non vorremmo più uscire. L'ondulazione destabilizza la percezione, non abbiamo tanti punti di riferimento, se non seguire il percorso tracciato dall'artista. Comunque il miracolo accade ancora con questi artisti. Accanto c'è un Papa schiacciato da un meteorite in una pozza di sangue, mentre un po' prima il Sister Project di Vanessa Beecroft conferma i dubbi su di un artista troppo legata al momento e alla moda (quella vera). Ancora una volta ritorna la sociologia, praticamente l'opposto di quanto raccontato dal curatore. Tra Serra e i nostri due alfieri quasi nazionali, c'è tutta l'insufficienza di questa Biennale, che voleva dire tutto e non dice niente.
"Non tutti saranno portati nel futuro" dice una scritta sull'installazione dei coniugi Kabakov, realizzata accanto al monstrum dell'artista americano: grande conclusione, Mr. Szeemann!
Valerio Dehò


