L'edicola digitale delle riviste italiane di arte e cultura contemporanea
Nero Anno 2 Numero 6 settembre 2005
Les reflexions dangereuses
di Luca Lo Pinto e Valerio Mannucci
luca&valerio > Jane Dowe > Marten Spangberg > Andrea Lissoni

free magazine
Ruins of exhibitions
n. 34 primavera 2014
Exercises in coherence
Amelia Rosselli
n. 33 inverno 2014
Ruins of exhibitions
n. 32 estate 2013
Ruins of exhibitions
n. 31 inverno 2013
Exercises in coherence
Dario Bellezza
n. 30 autunno 2012
Body Builders
Walter Siti
n. 29 primavera-estate 2012


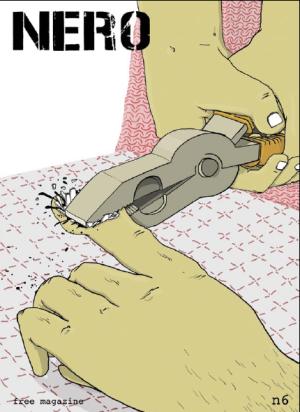
Come spesso avviene, le riflessioni più interessanti nascono dalle parole degli artisti stessi. Questo articolo ne è una conferma. L'idea, infatti, nasce da una discussione sul testo di un musicista, Terre Thaemlitz.* La sua lucida analisi, risalente al 1997, letta oggi è stata più che altro un punto di fuga, uno stimolo che ci ha spinto verso orizzonti più vasti, comprendenti anche la coreografia e l'arte visiva, mantenendo sempre come punto di riferimento le molteplici contraddizioni che sono alla base dei meccanismi di produzione e rappresentazione della cultura contemporanea.
Poi le cose sono andate avanti, e quelle che alla nostra vista si manifestavano come pure coincidenze, alla fine si sono trasformate in una serie di elementi molto diversi fra loro, ma incredibilmente compatibili, che viaggiavano ad uguale velocità e nella stessa indefinibile direzione. Così le contraddizioni "politicamente scorrette" di S. Zizek, alcune frasi di R. W. Fassbinder, i dubbi legati a quello che di solito andiamo a vedere, le teorie economico-sociologiche di Luc Boltanski, il senso di smarrimento di fronte alle convenzioni critiche date per assodate, tutte queste cose (ed anche altre) si sono andate a sovrapporre in una frenetica e confusa azione induttiva che ci ha portato a mettere sul tavolo delle questioni; e che, forse, solo a tratti si è "riprodotta" nel testo.
Quello che segue è l'editing di uno scambio di e-mail con tre personaggi che ritenevamo adatti ad una discussione del genere. Jane Dowe, musicista e giornalista, Marten Spangberg, coreografo e teorico della performatività e Andrea Lissoni, critico e curatore specializzato nei new media. Tre personaggi diversi, con differenti background, ma tutti pronti a guardare con attenzione quello che ci troviamo di fronte anche per il solo gusto di guardare.
Ho visto una bambina volare in cielo e le ho guardato sotto la gonna, come direbbe Gummo.
* "The Crisis of Post-Spectacle "Live" Contemporary Ambient Performance (Or... Why I Can't Get Paid to DJ A-structural Audio) - T. Thaemlitz - 1997
-------------------
luca&valerio > Jane Dowe > Marten Spangberg > Andrea Lissoni
luca&valerio > Al centro delle nostre riflessioni c'è l'idea di performance, di come essa sia per natura soggetta a delle costrizioni. Partiamo per esempio con il concetto di ripetizione delle performance. Nel mondo dell'arte contermporanea la performance è ancora legata all'idea di unicità. Sono rari i casi di artisti che ripetono una loro performance più volte (a parte il giovane Tino Sehgal, John Bock o Fabio Mauri, per esempio). In ambito musicale e teatrale invece il discorso è più evidente. Esistono dei veri e propri tour... Jacques Attali al proposito ha scritto: "The spectacle emerged in the eighteenth century, and, as music will show us later on, it is now perhaps an obsolete form of capitalism: the economy of representation has been replaced by that of repetition." In pratica è la richiesta di una performance a determinarne il valore culturale ed economico e non la sua unicità. Lo stesso Xavier Le Roy (coreografo) preferisce parlare di ripetizione e non di riproduzione quando parla del suo lavoro, perché ogni volta si crea qualcosa di nuovo e di diverso, ma è il primo ad ammettere che la ragione fondamentale è economica?Come si lega la necessità economica della ripetizione di una performance a quella artistica, ossia a quella del contenuto del lavoro?
Jane D. > E' indubbio che la ripetizione sia necessaria per il successo economico. Anche se stiamo parlando solo di economia culturale, la ripetizione è la formula per il maggior guadagno. Avendo lavorato a vari progetti sotto diversi nomi, mi sono accorta che questo stava diminuendo il mio potenziale. Inizialmente ho pensato che avrebbe semplicemente ridotto le mie probabilità di fama e di fortuna, ma poi vi si è scontrata anche la possibilità di praticare la mia arte, dal momento che senza il dovuto supporto solo certe pratiche artistiche sono possibili. Allo stesso modo, nelle performance da palco, uno è costretto a ripetere se stesso. altrimenti le opportunità di eseguire performance si riducono.
Marten S. > Per cominciare vorrei fare un appunto, o meglio, un commento un po' accademico. È interessante che cominciate la vostra domanda usando "con" (with) invece di "riguardo" (about) la ripetizione, che sarebbe stato più appropriato. Penso comunque che l'uso dell'espressione "con il concetto di ripetizione", forse in modo troppo aperto, racchiude un po' il senso del vostro giudizio. Il punto non è se ci sia o no la ripetizione, ma come e a che livello essa agisca.
Un altro aspetto di "con" riguardo la ripetizione si collega all'economia. Peggy Phelan, nel suo libro "Unmarked", parla dell'ontologia della performance affermando che la performance non può partecipare ad un'economia basata sulle rappresentazioni delle rappresentazioni. Le basi per una qualsiasi produzione artistica nel mondo occidentale sono semplicemente economiche ed è solo quando ci si rende conto che una cosa è semplice che essa diventa estremamente complessa.
All'interno di un'economia della rappresentazione della rappresentazione non è più rilevante che cosa "è" un'opera d'arte, né quello che vuole cercare di raffigurare e rappresentare, ma quello che fa, cosa "performa", come riesce a circolare in diversi tipi di economie. Evidentemente, nella nostra società, non c'è via di scampo da queste economie. Allo stesso modo, l'arte non può prendere una scorciatoia per fuggire dai suoi contesti, dai suoi padri fondatori: la democrazia moderna e l'economia capitalista. Questa è la caratteristica di lusso della società inclusiva post-Fordista, che, seguendo le orme di Foucault, nonostante la sua interessante idea di resistenza, implica che anche la cosidetta istituzione della critica sia sempre già incorporata. Ed è per questo che Foucalt, nel suo periodo maturo, focalizza l'attenzione sull'idea di governabilità che, in questo caso, vorrebbe dire incorporare la "situazione" dentro la critica.
Focault si sforza di mostrare come il moderno stato sovrano e la moderna autonomia individuale co-determinano lo sviluppo reciproco. La soluzione di Foucault, in qualche modo, emerge attaverso il passaggio, articolato nell' "Archeologia della conoscenza", da "quello che stato detto in quello che è stato detto" a "quello che può essere detto qui, ora e solo in queste specifiche circostanze". O, più semplicemente, finchè la critica sarà governata da certe gerarchie, la sua reale formulazione consoliderà l'agente governante, ma le arti possono creare contesti o situazioni che sono si affiliate all'agente governante, ma non per questo produttive.
Tutta l' arte è in qualche modo performativa ed è specificamente nel suo essere performativo che le pratiche artistiche oggi offrono potenzialità non di una critica, ma di quello che Irit Rogoff ha definito come criticità.
Peggy Phelan dice il giusto quando scrive che la performance non può partecipare alle economie della rappresentazione: la performance non può essere registrata o documentata perchè ciò che viene registrato non è la performance ma qualcos'altro. Quello che scrivo è un'altra cosa rispetto a quello che penso. La soluzione a questo dilemma è trasformare la documentazione, o la registrazione, in una performance secondaria, che può manifestarsi come una scrittura performativa..Un buon esempio è Tino Sehgal, il cui lavoro non mostra solamente una performance, ma è contaminando i suoi contesti fino al punto dove lo spettatore comincia a performare il contesto. Per esempio, quando il custode del museo sta eseguendo una piccola danza e dice allo spettatore che questo è un lavoro di Tino Sehgal e cosi via, questa azione è interessante rispetto al modo in cui rende ogni custode un'opera d'arte, una performance o, e forse questo è l'aspetto più interessante, una visibilità che non può essere ignorata. Quindi penso che la ripetizione cosi come è un problema per ogni produzione, soprattutto artistica, è anche l'opportunità per produrre sia una differenzazione che una "differentation", è sempre solo una questione di concettualizzare il risultato e essere sicuri che sia specifico alla sua configurazione produttiva.
Andrea L. > Questione complessa. Ho l'impressione che quello economico sia soprattutto un problema per chi lavora nelle performing arts in senso stretto, in particolare quando le sue creazioni sono dei 'fuori formato'. Questa è una categoria interessante. Perché se il fuori formato nell'ambito artistico-visivo è uno standard (a prescindere dalla riproducibilità/ripetitività) e quel che fa testo è la qualità dell¹pera in sé (la questione economica è in parte fuori gioco, è possibile che l'artista visivo riesca a vendere dei docu-fragments, come li chiama Barney), in ambito strettamente performativo il problema è sempre il contesto espositivo. A teatro? No, certamente, che sia danza o rappresentazione/messa in scena. E quindi chi lavora producendo - perché gli vengono così, in fondo è la sua ricerca - dei fuori formato, ha di fronte due vie: o rientra nello stage teatrale, nelle sue convenzioni, non solo architettoniche, e in quel mondo (anche economico) di appartenenza e di sussistenza (fatto di sbigliettamenti, borderò, siae e così via), ed è la via che mi pare scelgano, più o meno costretti, in molti, oppure svicola e sta fuori. Specie in Europa ha la fortuna di poter contare sulle strutture off, indipendenti, fondazioni, e sulla quantità di musei e centri d¹rte che, un pò per diversificare l'offerta, un pò perché è quel che di interessante succede e costa meno (vedi risposta successiva), aprono le porte a progetti performativi. Di qui il confronto, assai frequente, fra mondi di appartenenza e pratiche tra loro per tradizione e formazione distanti, come danza/teatro e arti visive. Buono l'esempio di Sehgal, che, dall¹sperienza proprio con Le Roy ha colto i punti chiave dell¹no e dell¹ltro sistema, approfittandone e, non a caso, mettendo in discussione la questione delle economie anche dal punto di vista dei contenuti (vedi l'intervento alla Biennale 2005, padiglione tedesco). Un punto è anche: e il pubblico? Quanto e come raccoglie. Soprattutto, si rende conto che è parte, non solo comportamentale, ma anche esistenziale, della questione in gioco? Sarebbe interessante che nascesse uno studio - come fu a suo tempo quello di Maurizio Lazzarato sul video - sulle pratiche performative lette in chiave sociologica, tenendo conto della trasformazione del lavoro e dei suo statuto nell¹ra postfordista. Carlo Antonelli intarprende una traiettoria interessante in questo senso nel testo che conoscete pubblicato in "Incursioni".
luca&valerio > Spostando il punto di vista possiamo individuare anche altri rischi, non necessariamente legati al lavoro specifico di un artista o al contenuto di un'opera in particolare, ma che riguardano invece lo sviluppo di un certo tipo di pratiche. T.Thaemlitz al proposito ha richiamato l'attenzione sul pericolo di forzare un certo tipo di pratiche 'nuove' all'interno di parametri culturali di vecchio stampo. Per esempio faceva riferimento alla necessità che si è venuta a creare negli ultimi anni, all'interno delle arti elettroniche, di reinserire l'elemento più superficialmente performativo laddove la performatività, intesa per esempio in senso esecutivo-virtuosistico, non aveva motivo di essere. Sottolineando soprattutto il fatto che tale inconscia necessità di adeguarsi ai vecchi canoni fosse in realtà pericolosa per il proseguire stesso di un genere d'espressione artistica come quello delle contemporanee arti immersive ed ambientali...
Jane D. > Concordo completamente, anche se credo che le prossime generazioni adotteranno eventualmente dei modelli ancora più nuovi. Se guardiamo ad un qualsiasi movimento rivoluzionario nelle arti, ci rendiamo conto che serve del tempo alle nuove idee per sostituire le vecchie. Nella musica l'uso della tecnica seriale non si è mai spostato dall'ambito accademico e, mentre erano ancora concentrati sulle loro strategie, i serialisti avevano allo stesso modo aperto nuove possibilità di esplorare il rumore, il suono e i processi che permeano quasi tutta la musica. Similmente queste idee che consideriamo potenzialmente nuove nelle arti digitali, potrebbero essere solo delle semplici vie d'uscita per la prossima generazione, le cui idee e pratiche vanno oltre la nostra immaginazione. Sono ottimista sul fatto che, anche se sembra che il nuovo stia retrocedendo verso il vecchio, esso sta allo stesso tempo 'negoziando' e liberandosi delle vecchie strutture.
Marten S. > Fortunatamente credo che l'arte funzioni come qualsiasi altro mercato o luogo di circolazione. L'arte e le sue opportunita' di produzione sono distribuite in alcuni territori, cosi', quando c'e' qualcosa di 'nuovo' (qualsiasi cosa vogliamo intendere con questa espressione) ci sono determinati fattori strategici, tattici, strutturali o convenzionali, che in ogni caso devono esser negoziati. Di conseguenza, quando si ragiona sulla necessita' di 'adattarsi' alle vecchie strutture, la questione è molto complessa perche' una cosa, per poter dire di esistere, ha realmente bisogno di adattarsi o almeno di rendersi riconoscibile ad un sistema. Una domanda riguardo le arti elettroniche potrebbe essere questa: se le arti elettroniche non venissero inscritte all'interno delle tradizioni istituzionalizzate, come potrebbero essere considerate arte? Se non lo fossero non guadagnerebbero spazio in molti dei territori in cui il suono e', per esempio, rappresentato. Attraverso l'inscrizione in determinati territori le arti elettroniche hanno guadagnato un posto fra quelli gia' riconosciuti, ma questo inserimento ha ovviamente implicato o favorito una de-territorializzazione del campo originale. Una semplice analogia potrebbe essere quella dello sviluppo della musica dance nel ventesimo secolo.
Forse Thaemlitz, in prima istanza, si riferisce alla performatività non rispetto alla rappresentazione o al rendersi visibile nella pratica artistica, ma al come le arti elettroniche abbiano sviluppato performatività differenti o almeno associate ad altri territori. La tendenza a muoversi entro territori esistenti implica l'accettazione delle ideologie che mettono in contatto i territori. Cosi', quando le arti elettroniche si muovono in cornici prestabilite, ciò che apprendono e' come devono farsi performative rispetto alla performativita' del territorio in questione, in relazione al gender, alla sessualita', all'etnicita', alla classe e cosi' via. Quando le arti elettroniche, ancora piu' evidentemente, si muovono nel campo del suono (questo in relazione a Thaemlitz), approvano implicitamente la performance eterosessuale maschile, cristiana, caucasica, della middle class. Credo che Thaemlitz si chieda perche' le arti elettroniche, come la produzione, dovrebbero minare gli ordini di rappresentazione conosciuti e quindi non intaccare di fatto l'egemonia, quando, invece, le arti elettorniche potrebbero avere un proprio luogo, dove diversi tipi di individui potrebbero agire? Riferendoci brevemente a Benjamin, quello che Thaemlitz ammette e' che, se tutti possono essere artisti, non tutti sono accettati, almeno non quando si va incontro all'aura dei territori e delle etichette.
Le necessarie ed emarginanti strategie che consistono nel crearsi una comunità, cioè nel creare un asse di eventi ricorrenti e quindi riconoscibili intorno ai quali un gruppo di individui produce un identità o un alleanza sono strategie che a loro volta producono nozioni di territorio. Un interno ed un esterno vengono stabiiti, o, in altre parole, viene posto un confine il cui attraversamento implica uno scambio di economia, un 'custom' (qui usato in riferimento alla nozione di territorio).
Le strategie artistiche e quelle che provocano un cambiamento usano, applicano, deviano, minano e attivano costantemente dei 'customs' di differente tipo.E' solo quando un antagonista è in grado di rilevare la posizione di una altra produzione che può avvenire una negoziazione. Questa posizione deve essere creata, e ,per essere vincente, deve essere creata al di fuori degli attuali 'customs'. E' solo da una situazione singolare che può emergere una tale creazione e, in essa, risiede la produzione di un possibile 'custom', che può essere interpretato da qualsiasi comunità e messo in questione sia in modo amichevole che ostile, sia inclusivo che restrittivo.
Ciò significa che non è l'efficienza di un'azione in sé ad essere importante, ma l'invocazione, l'invenzione e lo stabilizzarsi, o similmente il destabilizzarsi, dei "customs". Sono proprio le comunità esistenti, locali e globali, ad avere bisogno di inscrivere questi 'customs' in e su sé stessi. E' in questo passaggio dall'azione al 'custom', in qualsiasi senso, che si produce arte come qualcosa che provoca un cambiamento, che rende l'arte un evento.
La posizione dell'artista oggi forse non è quella di "produrre immagini di qualcosa", dato che ogni immagine funziona ancora come un'economia contenuta, ma di produrre situazioni, nelle quali un gruppo di persone (o di questioni) è coinvolto nella loro singolare molteplicità. E' così che la produzione artistica si allontana sia dalla tradizione estetica kantiana che dalla nozione strumentale dell'arte e si trasforma in una forza produttiva nella quale il pubblico è coinvolto in maniera attiva anche solo come spettatore, come un singolo nella moltitudine.
L'artista non è pertanto qualcuno che può (con successo) informare uno spettatore o una comunità, per introdurre qualcosa di estraneo, nuovo o unico, ma il suo compito dovrebbe essere quello di permettere allo spettatore di elaborare il suo coinvolgimento individuale, al fine di diventare uno "spettatore emancipato". Per tornare dunque alle arti elettroniche, è mia convinzione che gli obiettivi di oggi non consistano nel far parte o meno di certi territori, ma di confrontarsi continuamente con tutti quei territori di cui fa parte, rispetto anche al modo in cui questi territori attuano la performance in relazione alla distribuzione, alla proprietà, responsabilità.
Andrea L. > Sarebbe interessante capire cosa intende esattamente Thaemlitz con "arti immersive", comunque, quello che definite un rischio e che, dal vivo (sic) è senz'altro un paradosso (l'antico e ormai desueto live electronics), è probabilmente destinato, come spesso accade, a innestare una trasformazione. Restando nell'ambito della musica elettronica: la performatività sembrerebbe poter non aver senso di essere, e porto una testimonianza: non posso dimenticare, in occasione di Netmage 05, a Bologna, all'interno di un teatro, pur disesstato nella sua forma/funzione (gli schermi sospesi in obliquo dividevano lo spazio in due, il suono era diffuso come in due ambienti affiancati in un unico spazio, il pubblico poteva prendere posto oltre che in sala anche sul palco sedendosi o sdraiandosi, i musicisti 'suonavano' alla base del palco stesso), Phil Niblock assistere al suo stesso 'live' audio/video, con la sonorizzazione dei suoi straordinari film della serie 'The Movement of People Working', appoggiato al palco a braccia incrociate. Una scelta simbolica? La sera precedente la coppia di Staalplaat soundsystem era però decisamente in azione 'suonando' con microradio e automezzi giocattolo modificati nel live Yokomono?E, per fare esempi generalisti, qual è lo statuto di live come quelli di Matthew Herbert, Jamie Lidell, Leafcutter John e tanti altri ancora? O, ribaltando gli ambiti disciplinari, il paradigma di riferimento nel progetto Myriam Gourfink/Kaspar Toeplitz? La performatività esecutivo-virtuosistica è una necessità di adeguarsi a vecchi canoni? Il problema che sottoponete è davvero interessante, anche se in un certo senso suggerite di prescindere da questioni di lavori individuali (di 'poetiche' quindi, come le si chiamavano) e di contenuti. Il problema ricade dunque sui contesti, sui dispositivi di mediazione, sul frame espositivo più in generale (e questo punto è ottimamente illustrato da Marten Spangberg), quindi sui diffusori di sistema (il teatro, il museo, il centro d'arte, il festival di?). Ma non solo. Escludendo quindi la questione di poetica e di politica (anche se è lì che si gioca lo statuto, ma anche il discrimine critico per la valutazione del plusvalore di qualità di live di musicisti e coreografi come quelli sopraccitati), il problema ricade inoltre da un'altra parte, e cioè sull'evoluzione delle forme espressive stesse, artistiche. E qui ritorno al punto delle 'trasformazioni'. Ogni immissione, incrocio, comportamento performativo o altro, disegnerà ipotesi di nuovi territori. L'eventuale qualità sarà certificata dai dispositivi e/o sarà interna alla logica dell'opera, del percorso dei suoi autori. I comportamenti, perché umani, sono necessariamennte imprevedibili e questa imprevedibilità può generare nuove ed altre imprevedibili forme, forse anche, magari casualmente, linguaggi. Credo che il punto non sia la nascita di compromessi che possono poi rivelarsi pericolosi per un genere, o una disciplina. Al contrario, penso che quelli siano terreni da attraversare, frequentare, osservare, eventualmente sostenere, perché spesso generativi ed energetici. Il punto non sarà mai solo lo statuto di un linguaggio, ma, completamente d'accordo con Spangberg, "?to picture situations...". Con questo non è detto che qualcosa per forza avvenga nei processi ricombinatori, di appropriazione, di manipolazione e di intromissione di elementi apparentemente alieni, anzi? ma non si deve precludere o ostruire, semmai problematizzare. La qualità o l'efficacia (un parametro che ha a che fare con l'economia), toccherà poi, tutto sommato, anche al pubblico sancirla.
luca&valerio > Ci sembra inoltre evidente che, nell'ambito dei laptop set, laddove non si fossero escogitate nuove strategie di performatività, l'elemento discriminante, che determina la differenza tra riproduzione e performance, si riduca in fondo al concetto di presenza o assenza del musicista sul palco. Questo fenomeno potremmo ricondurlo, per associazione, alla richiesta sempre più crescente, nel mondo dell'arte, di invitare gli artisti a parlare, a tenere conferenze. Il mercato sembra quasi pagare più l'artista come "storyteller" (citando una frase di Cesare Pietroiusti) che come produttore di un'opera in senso tradizionale. Quali pensate siano le motivazioni alla base di tutto questo?
Jane D. > In parte il motivo potrebbe essere che il prodotto finito raramente è compreso del tutto. Per i più è solo suono fine a se stesso ed è scoraggiante, per la maggior parte delle persone, differenziare un laptop performer da un altro. Sono altri gli elementi significativi che diventano critici e alla fine è più un gioco di marketing che una sfida alla produzione migliore.
Marten S. > Bene, la risposta più breve (o immediata) è sicuramente che, se qualcuno può guadagnare dei soldi dall'immagine di un'artista, quel qualcuno non esiterà a farlo. La necessità dell'artista come storyteller è una joint venture (certamente non nuova) definita da diverse forze nel mondo dell'arte, che, oltretutto, non sembrano destinate a sparire. La maggior parte degli artisti che lavorano sulla diffusione dell' artista come eroe post-fordista, secondo me finiscono per essere abbastanza presuntuosi, consolidando la posizione data; cosi sia il processo che il risultato, seguendo Guy Debord, sono evidentemente inscritti nello spettacolo. Il costituirsi della performance nella presenza e nell' assenza, che rappresenta una tradizione molto forte nel teatro/performance e nella danza, è per me una via senza uscita, costruita su tradizioni filosofiche che fanno riferimento a quelli che potremmo i fondatori del soggetto (da Aristotele a Derrida). Penso che dobbiamo liberarci da queste questioni e cominciare a produrre "performance" contemporanea. Voglio dire, qual è il problema? Chi diavolo è interessato alle identità politiche, al corpo come testo, come spazio di violenza, di posizionamento sessuale o a quello che abbiamo? Lo stare sul palco, il ripetere gli spettacoli o no, di fronte a un pubblico che si pone semplicemente come pubblico sono cose passate. Il teatro, con la sua spazialità simbolica, è un dispositivo che è completamente in stallo, ma l'economia delle sovvenzioni (o dei sussidi) così come l'impero dei manager molto probabilmente non scompariranno. E questo è qualcosa che è valido anche nel mondo delle arte visive, dove Santiago Sierra consolida la performance come una presentazione alla quale, di conseguenza, posso solo rispondere 'Oh, ma questo è terribile. Come può un'artista fare cose del genere?' o 'Questo ragazzo rivela qualcosa di importante!' o finalmente la buona sensazione del diventare consapevole della mia posizione voyeuristica. Al contrario, il lavoro di artisti apparentemente distanti come Felix Gonzalez Torres, Tino Sehgal o anche Superflex produce situazioni di partecipazione alle quali lo spettatore può, e talvolta deve, rispondere con una performatività. Il tipo di artisti alla Sierra è ancora, e cito Bruce Nauman, "un rivelatore di verità mistiche" laddove il modello alla Torres provoca, invece, emancipazione attraverso l'attivazione dello spettatore. Sierra può solo essere spettacolare e appagante laddove Torres e soci possono essere stimolanti attraverso gesti comuni. Sierra, per questo, diventa il grande Ontologista contro la sua volontà e Torres, che potrebbe essere inteso come coinvolto in qualcosa di personale, diviene precisamente un'artista dell'emancipazione e della partecipazione.
In breve, non è l'abbondanza dei laptops nel mondo dell'arte ad essere interessante, ma come essi vengano utilizzati tutti allo stesso modo. Non mi preoccupa tanto che uno possa riprodurre suoni con un laptop piuttosto che con una chitarra, quanto quello che,attraverso la tecnologia dei computer portatili, può accadere, al suono nel suo significato più vasto. I recenti sviluppi nell'ambito del suono sono veramente sconvologenti, non per come suona, ma in relazione (prima di tutto) alle nozioni di distribuzione, proprietà e decentralizzazione. Secondo me troppe persone, che lavorano nel regno del suono, sono eccessivamente interessate a come suona e non a cosa fa o come funziona. Penso anche che il concetto della composizione possa cambiare radicalmente grazie alle nuove tecnologie (sia soft che hard).
Il suono è un ambito, ma io personalmente sono più interessato alla televisione. Non intendo la distribuzione della video art su internet ma piuttosto cosa possono provocare le nuove tecnologie portatili in relazione alla televisione, specialmente la televisione d'informazione. Se persone normali, per dire, possono produrre televisione e distribuirla attraverso canali aperti o su internet, quali implicazioni possono avere queste attività sul paesaggio egemonico della televisione convenzionale? Arte e televisione hanno, da una parte, una relazione molto stretta, ma, dall'altra, la TV-art mi sembra qualcosa da sviluppare successivamente. Vorrei fare una distinzione tra Tv-art e arte-TV: quando qualcosa appare come arte in televisione, la sua potenzialità critica è cancellata e può solamente finire in televisione perché la televisione ha bisogno di ottenere uno status o altro. Se uno, invece, considera la Tv-art cioè l'arte che opera con, ed attraverso, le convenzioni della televisione (ad esempio modelli di riferimento, formati, narrativa, performance senza il desiderio di mostrare nient'altro che la televisione), ci potrebbe essere un vasto territorio da esaminare in relazione a quello che è l'informazione e la comunicazione. Recentemente ho sentito di famiglie in Svezia, specialmente di origine araba, che filmano i loro matrimoni e comprano degli spazi su canali aperti trasmessi sul network del servizio pubblico, dove successivamente possono mandare materiale più o meno editato. Questo è straordinario nel senso di come si proponga qualcosa di totalmente diverso dalla tradizione delle televisioni nel mondo occidentale.
Per concludere, ci sono troppi laptops che vengono usati senza renderne complesso l'uso. I laptops sono lo strumento dei prossimi 10 o 100 anni e, come di norma non può essere escluso ma solo reso complesso.
Andrea L. > Varie. Relazionali, per quel che concerne curatori-artisti e per quanto riguarda l'ossessione dell'essere sempre in connessione e, formula paradossale, sul campo (paradossale perché raramente se ne riportano e interpretano i dati). Economiche. E' ovvio, con 1500 euro all inclusive ci si può permettere una presenza su cui non si può (o magari non si osa) investire per la produzione di un'opera. Naturalmente ci sono limpide eccezioni, istituzioni basate proprio sulla riflessione e il confronto, o lo storytelling come strategia laddove le istituzioni mancano o non vogliono (l'ottima stagione delle 'Generazioni delle immagini' a Milano, volute da Roberto Pinto e fondamentale enclave formativo nei tardi anni '90). Ma, a parte le ragioni di sistema: più poeticamente (chissà?), una voglia di confronto, una domanda/volontà di incontro del e con il pubblico, forse una necessità di avvicinamento, magari un tentativo di maggiore comprensione. E' interessante però. Al di là delle divulgazioni powerpoint standardizzate, prende forma una via dei racconti, una dimensione dell¹ralità che interroga e rimette in gioco la dittatura dell'immagine riprodotta, sempre e solo (necessariamente), da un punto di vista. Sono narrazioni che non aspettano altro che essere manipolate, reinterpretate, reinventate.
luca&valerio > Un altro caso particolare sul quale ci piacerebbe puntare per un attimo l'attenzione è quello della sound art. Escludendo qualsiasi volontà di definizione, ma intendendola secondo l'accezione comunemente diffusa (ossia considerando gli artisti, i lavori e le mostre che si richiamano a questa etichetta), è evidente che, nella maggior parte dei casi, sia rilevabile una quasi totale assenza di performatività. Soprattutto perchè, laddove fosse presente, sarebbe difficile distinguere una potenziale 'performance di sound art', dall'idea di musica sperimentale e ambientale o dalle moderne teorie di compozione ed escuzione musicale (Schaffaer, Berio, Cage come esempi più noti). Si tende quindi a legare il concetto di "sound art" soprattutto all'idea d'installazione, di interattività, di documentazione o narratività, per fare degli esempi. Rispetto a questa idea, la sound art non potrebbe configurarsi forse come una strategia specifica all'interno del panorama economico-culturale, piuttosto che un campo d'azione vasto e libero come abitualmente è inteso?
Jane D. > Penso che cosi come l'installazione, l'interattività, la documentazione e la narratività vincono sulla performance, il concetto inoltre si sta imponendo sulla composizione. Anche nel contesto di una galleria dovrebbe essere ancora possibile vedere il suono come un'azione basata sul tempo e non una semplice e statica esibizione mono-dimensionale del medium. Con questo mi sto riferendo alle installazioni etc. che possono diventare più noiose rispetto dopo l'impatto iniziale.
Marten S. > Credo di aver già risposto a questa domanda...ma se volete posso scrivere ancora!
Andrea L. > L'ssessione catalogatoria, la necessità della schedatura a tutti i costi, pratiche sempre un filo inquietanti, rassicurano e alimentano chi quel mondo osserva ed ha eventuale interesse a tenere in considerazione come potenzialmente attivabile strategia specifica all'interno del panorama economico-culturale. Ma più che di confini e definizioni si tratta forse di parlare di frontiere, per statuto permeabili, e di mappe aperte. Senza dimenticare l'identità certamente, quindi anche la storia e la formazione di chi dentro quei territori abita e fa naturalmente ricerca. Il rischio di schedare e fare categorie è che l'atteggiamento di ascolto della differenza è liquidato, preferendogli il generalismo, più confortante ma riduttivo; ci si ritrova poi ad una definizione di 'un genere' che viene accettato e condiviso, come è accaduto a suo tempo per esempio con la 'video-art'.
luca&valerio > Per chiudere volevamo sottolineare lo sviluppo crescente di gruppi di artisti, ma anche di curatori, critici o scrittori, che si riuniscono sotto un'identità collettiva. Se inizialmente questa scelta si poteva configurare come un tentativo di trasgredire, o criticare, l'idea predominante di individualità e d'autorialità nel sistema culturale, attualmente sembra aver perso efficacia finendo per essere assorbita dallo stesso sistema che intendeva criticare. Qual è la vostra idea a proposito di questa diffusa esigenza di collettività?
Jane D. > Penso sia semplicimente una risposta all'enorme quantità di contenuti che vengono prodotti. Forse l'unico modo di essere riconosciuti tra tutte le individualità è essere identificati come parte di un movimento, scena o tema. Per questo i collettivi sono abbastanza naturali sia per un riconoscimento immediato da parte degli altri membri sia per la risonanza crescente dovuta al ripetersi di più artisti che parlano con lo stesso linguaggio nei confronti del mondo esterno.
Marten S. > Per cominciare, ad esempio, è importante trattare propriamente la differenza tra modelli di management più o meno convenzionali e termini quali collaborazione e/o collettivo/collettività. Mi sembra di cattivo auspicio quando l'idea di collaborazione ed un semplice gruppo di lavoro vengono mischiati e confusi. Per quanto mi è dato di sapere, anche il regista e il coreografo più demonico, in qualche modo, collaborano. Un maestro di fronte alla sua orchestra sinfonica è comunque inscritto in una collaborazione, ancor di più quando ci sono degli elementi molto specifici. Se un gruppo o un collettivo desidera indicare la collaborazione come un' importante caratteristica del proprio lavoro, o del suo esser una specie di community, deve essere in grado almeno di sapere, e di poter definire, quale specifico elemento la collaborazione vuole enfatizzare. Se si vuole insistere sul fatto che è importante lavorare insieme, in modo che il risultato del lavoro possa essere lontano, o comunque possa deviare, dal concetto di autorialità, è mia convinzione che uno dovrebbe fermarsi immediatamente, visto che non riesco ad immaginare una situazione di lavoro che non sia costruita in base a concetti del genere, intesi sia in senso positivo che negativo. Sembra un paradosso politico iscritto in ogni collaborazione..Non ha forse la politica usato i procedimenti stessi legati all' uguaglianza ed alla libertà per trasformarsi nell'unico regno necessario a definire le nozioni di dominazione intra ed extra strutturale?
E' interessante notare che, all'interno del campo delle arti, la produzione di collaborazioni e collettivi si genera rispettando processi e apparenze che hanno solide coordinate spazio-temporali; le collaborazioni e i collettivi sono state cioè nient'altro che una deviazione superficiale dell'autorialità, attraverso la quale l'iniziatore, l'unità delegante, riceve una posizione ancora più forte di quella originale. Trent'anni dopo le arti sono ritornate al "processo". Citando, doppiando, onorando e deviando, con una completa discrepanza, gli eroi delle neo-avanguardie, riciclando l'estetica per rendere la collaborazione riconoscibile, facendo risorgere l'ideologia in modo più semplice, così da mascherare il fatto che non abbiamo niente da esprimere. E sembra che lo abbiano fatto in maniera tale da enfatizzare l'eterogeneità come un impacciato mezzo per scappare dal capitalismo maligno, come quello di fine anni '90.
Quale lavoro artistico non nasce attraverso uno o l'altro processo? Un lavoro concettuale estremo, si. Ma questo è qualcosa che non abbiamo più visto, specialmente nelle arti performative, dai tardi anni '60; considerando anche che un lavoro concettuale, al meno come è scritto nella Storia dell'arte, è basato su un protocollo e può quindi, a livello d'esposizione, non comprendere alcun processo o collezione d'esperienza dovuta alla rappresentazione del lavoro.
Quindi, non basta parlare di processo ma è necessario concettualizzare o, preferibilmente, parlare della sua concettualizzazione nella sua rappresentazione. Non importa se c'è qualche tentativo interdisciplinare che spesso suona grandioso a livello di applicazione ma che, nel momento della sua presentazione, di rado offre qualcosa di nuovo a livello d'ideologia o di conoscenza.
Sia per il processo che per l'interdisciplinarità, è imbarazzante realizzare che la propria manifestazione, come per la collaborazione, sembra essere stata formalizzata per includere solo il processo che precede il prodotto finito, senza considerare quasi mai l'inclusione di una cornice temporale o spaziale diversa. Quello che i lavori artistici orientati verso l'idea di processo devono fare è guardare ai problemi legati al concetto di proprietà.
Fino a che punto e in rispetto di quale meccanismo, i processi sono, o non sono, posseduti da qualcuno o da qualche entità? Un'attività, qualsiasi processo sia stato messo in moto, verrà presentata necessariamente da qualcuno (o da qualche entità) ed è quindi importante indicare non quale processo sia implicato, ma quale slittamento di proprietà sia provocata da questo processo, dovuto al mercato o all'ambiente. E', per esempio, risaputo che i performers sono inseriti nelle credit-list come co-creatori, ma è raro che ciò che questa affermazione implicherebbe faccia sorgere questioni legate alla proprietà dell'opera.
Anche a rischio di diventre tedioso voglio ancora sottolineare le questioni di responsabilità legate necessariamente al processo ed alla produzione...Mi sembra che la co-autorialità diminuisca le opportunità di resistenza, dubbio o errore a causa del fatto che entrambi, gli individui o le istituzioni coinvolte, corrono il pericolo di perdere la faccia, un elemento che la democrazia porta necesarriamente con sé. Il suo regime di codardia è esponenziale rispetto ad ogni consenso legittimato.
Infatti, i lavori orientati verso il processo che hanno prosperato negli ultimi dieci anni hanno contribuito in modo rilevante all'attuale clima conservatore. Può quindi un autore autonomo, dal canto suo, raggiungere un più alto grado di radicalismo, dal momento che 'un collaboratore' è legato proprio alla responsabilità che mette in questione? Qualcosa si deve fare, almeno per rendere veritiera una critica. L'intero insieme delle collaborazioni, processi, co.produzioni, co-autorialità, etc. sono l'opportunistica risposta delle arti ad una società del controllo.
Andrea L. > Non so se si possa parlare di uno sviluppo crescente di un'esigenza di collettività. Mi pare sia un atteggiamento diffuso e condiviso nel XX secolo. Senz'altro in ogni esperienza di forma collettiva o associativa accade che con la trasgressione dell'individualità, ammesso sia un indice di valore, si arrivi presto o tardi a fare i conti. Le collaborazioni, le aperture, le affinità elettive (queste sì, mediate anche dal mondo della musica, più o meno pop - dai featuring hip hop o r'nb ai progetti nell'elettronica indie -), mi paiono un tratto interessante e specifico degli ultimi tempi. Laddove l'individualità è un bene comune e la sigla del collettivo è un cognome possibile, una forma di rappresentazione di un territorio, di un'identità e non un brand tout court. Si aprono intorno a label musicali, etichette o realtà produttive cinematografiche (il caso di Anna Sanders), team curatoriali interdisciplinari basati sul confronto, l¹nterpretazione e la diffusione delle forme e delle ricerche (è il caso di Xing in Italia), magazine che poi arrivano a (ri)produrre immaginario (come Nero, o Purple Magazine, ma anche The Wire, Butt e tanti altri ancora), pratiche (come è stato con il live media e prima il vj-iing), e sono spesso figlie di coincidenze, incontri, amicizie, passioni. Nazioni aliene, territori aperti e provvisori del presente (ben esemplificati forse da The Land), che masticano, mescolano, digeriscono e sputano gli immaginari che disegnano la nostra piccola e grande quotidianità.


