L'edicola digitale delle riviste italiane di arte e cultura contemporanea
Millepiani/Urban Anno 2011 Numero 3 2011
Neuro Habitat
Ubaldo Fadini
Senza nome e senza storia
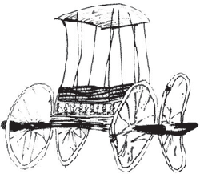
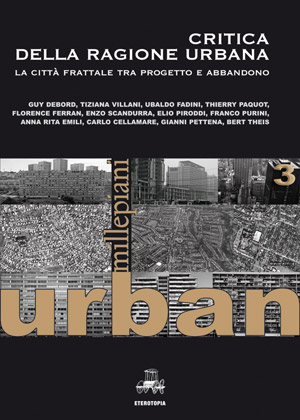
premessa 5
ANALISI
Guy Debord
Introduzione a una critica della geografia urbana 9
Tiziana Villani
Organologia dell’abitare 17
Ubaldo Fadini
Neuro Habitat
29
Thierry Paquot
Salvare la Terra per salvare la città 43
Florence Ferran
Visibilità del progetto urbano
tra comunicazione e cultura dello sguardo 55
LINEE DI RICERCA
Enzo Scandurra
Il Principe e l’urbanista 67
Elio Piroddi
Il pianeta urbano 83
Franco Purini
La città dal sociale al culturale 101
Anna Rita Emili
La crisi del progetto urbano 109
Carlo Cellamare
Pratiche urbane, progett-azione e produzione
di “pubblico” in epoca di capitalismo avanzato 121
ESPRESSIONI URBANE
Gianni Pettena
Design, arte ambientale, architettura:
interrelazioni contemporanee 137
Bert Theis
Christoph Schäfer:
L’artista e la città-fabbrica neoliberale 153
recensioni
PREMESSA
Interrogarsi sul progetto, sul senso del progettare della città, significa porre il problema non solo dei saperi disciplinari direttamente chiamati in causa, ma anche del modo di pensare, immaginare e creare gli spazi dell’abitare odierno. Ma di quale città intendiamo parlare? Quello che è possibile dire im-mediatamente è che alla città-immagine è da opporre un’idea del tessuto/territorio urbano come spazio di incontro (ed eventualmente anche di scontro) di immaginari di diverso segno, di esperienze variegate, di sogni e ricordi, di vaneggiamenti e acquisizioni cognitive, affettive, emotive. L’articolazione dell’urbano, seppur con tendenze che a livello globale possono essere interpretate nel segno di un unico e tumultuoso processo di trasformazione, è appunto estremamente complessa e diversificata. Eppure due riflessioni sembrano essere singolarmente latitanti sia nei dibattiti specialistici che in quelli un po’più generici, a maglie larghe, per così dire: il confronto materiale con i luoghi, lo statuto delle committenze sia pubbliche che private. I saperi tecnici rischiano così di limitare la necessaria importanza della creazione dei progetti su scala ambientale e quelli più teoretici corrono il pericolo di rinchiudersi in una sorta di metanarrazione degli eventi.
La trasformazione della destinazione d’uso dei territori sfugge così ad ogni intento di produzione di spazi volti a soddisfare le esigenze di vita sia in termini di edificazione, spazio pubblico, sia di accesso, comunicazione, ecc. Questa tendenza ha a che fare con le nuove dinamiche dell’economia odierna in cui i flussi finanziari e più in generale, la finanziarizzazione dei movimenti di capitale, generano spostamenti di popolazione, lavoro, risorse ed altro secondo gerarchie estremamente mobili che agiscono sui territori in modo disastroso provocando densificazioni, inurbamenti, gentrificazione del tutto labili. Se la tendenza all’inurbamento globale appare certa, lo stesso non si può dire dei luoghi in cui questo processo si declina, essendo lo stesso molto fluido e veloce nelle sue configurazioni.
Proprio per questo motivo abbiamo sempre più bisogno di ripensare il senso del progetto, ossia dobbiamo essere in grado di misurarne la portata nella sua più autentica necessità, che è quella che mette al primo posto le condizioni dell’abitare non solo dei singoli soggetti, ma delle società; società in transito, differenziate culturalmente, in complesso rapporto con istituzioni spesso distanti e sclerotizzate.
L’insieme degli interventi qui proposti considera questo approccio in relazione alle domande sempre più urgenti che provengono da realtà troppo a lungo dimenticate o mistificate. Non solo periferie dunque, ma l’insieme di quelle condizioni di vita che chiamano in causa strutture, lavoro, luoghi del consumo, spazi museificati o securizzati che compongono, come ben osserva Matthew Gandhi, la matrice frattale dell’urbanesimo del presente.
RETRO COPERTINA
La città del nostro tempo è sempre più una città senza progetto, o meglio una città in cui proliferano caotiche occupazioni di spazio unitamente a grattacieli e soprattutto centri commerciali, disney city disegnate come monadi nel deserto.
Lo spazio pubblico nella tarda modernità dell’Occidente si presenta come
spazio critico, assediato e precario al contempo, in cui spesso gli attori paiono
intervenire perseguendo la logica del frammento. Città frattali la cui vocazione è sempre più determinata dall’insicurezza e dall’imperio del consumo. Stazioni, ospedali, scuole, interi quartieri sono chiamati ad accogliere ipermercati,
negozi, caffè, ecc. al fine di intrecciare sempre più strettamente e
totalitariamente il senso dell’abitare con la mercificazione delle esistenze.
A quest’urbanesimo esploso non possono rispondere né le gated communities, né mirabolanti grattacieli “brandizzati”, la cementificazione assedia queste nuove eterotopie malinconiche e ci pone dinnanzi al compito urgente di
ripensare la creazione di ambiente, l’impronta ecologica, il valore d’uso.
La sottrazione costante di spazio pubblico non si traduce unicamente in una
privatizzazione dello spazio stesso, quanto in un depotenziamento di vita dei singoli e delle società.
Immaginare una nuova pratica di senso è necessario e possibile, ed è questo che gli interventi qui raccolti intendono iniziare a fare: aprire nuove prospettive di ricerca e lavoro facendo i conti senza riserve, con lo stato attuale delle cose.
La dérive: superamento dell’arte o opera d’arte?
Anselm Jappe
n. 5 2013
Resistenze urbane creatrici passando per l’Internazionale Situazionista
Chris Younès
n. 4 2012
Tre alfabeti o l'urbanista postmoderno
Leonie Sandercock
n. 2 2010
Metamorfosi dell'urbano
Tiziana Villani
n. 1

Abbellimento strategico Isola Art Center
Milano, 2009

Tumbleweeds, 1972

Spiral Jetty, 1970
Questo testo nasce da un incontro con alcune storie di Miguel A. Martin, il noto e originalissimo disegnatore spagnolo di Brian the Brain (tra l’altro…). In particolare, trovo stimolante la storia di Neuro Habitat. Cronache dell’isolazionismo, che di-segna un personaggio privo di nome, meglio: il cui nome si confonde con “un sussurro nel buio”, con “un rumore nascosto nella radiazione di fondo dell’universo”. Un personaggio che vive in una condizione di isolamento radicale, all’interno di una stanza, privo di storia, di tempo, di memoria, al di là di alcune chiamate registrate da una segreteria telefonica (la madre…, alcune amiche…): si tratta di un isolazionista radicale che si rapporta abitualmente ad un unico essere vivente, un anaconda, e ad un cagnolino robot, ordinato in rete nei materiali che lo costituiscono e che sono stati diligentemente e correttamente assemblati. Il suo contesto di esistenza, la sua Umwelt (che cor-risponde alla Welt, al mondo che si dà e che forse gli viene dato), è formato da pochi elementi: uno schermo gigantesco, una consolle per videogiochi, un computer, il cibo a domicilio portato da un fattorino “mascherato” ( il cui volto è nascosto da una maschera anti-gas), a cui si rapporta, con soldi e ricevute, passati sotto la porta, riuscendo così ad evitare sguardi, parole, qualsiasi – anche ovvio – contatto fisico. Pure la dimensione sessuale è registrata sul piano del virtuale e comunque non le viene concessa, al di là del dovuto (in pagamento), alcun credito.(1)
L’isolazionismo radicale è una teoria della posizionalità assai complessa, rispetto alla quale si può configurare un approccio di analisi che si serve, in prima battuta, di alcune riflessioni di E. Borgna, contenute nel suo recente La solitudine dell’anima, incentrate proprio sul tema della scelta dello stare soli, individuata come condizione di pensiero e di agire intimamente critico. Lo psichiatra distingue tra solitudine e isolamento, laddove la prima si presenta comunque come una tonalità emotiva contraddistinta da una volontà di separazione – provvisoria, temporanea – dal mondo delle persone e delle cose, con la sua trama di percorsi delineati/ordinati di esperienza: si sceglie di essere soli per riferirsi a delle risorse di natura “interiore”, in primo luogo l’immaginazione come matrice di relazionalità, per poi appunto, così sostenuti/supportati, riaprire al tempo che ci ri-guarda, con i suoi compiti, le sue aspettative e le sue occasioni.(2)
Rispetto alla solitudine, che vale come una condizione di sospensione del tempo a favore di un tempo differente, l’isolamento si “presenta” come volontà di “assenza”, come manifestazione di un contro-tempo (meglio sarebbe dire: anti-tempo) che favorisce dinamiche di fuga, di fuori-uscita da un complesso di ruoli e di funzioni che fa presa, si “attacca” (attacca), sulla “realtà” dei processi di soggettivazione. Ponendomi sulla scia di alcune considerazioni di G. Deleuze, mi verrebbe da dire che l’isolazionismo radicale non si limita a mettere in scena il motivo del “pensare” in solitudine (quando si pensa, si è “soli”), ma aggiunge a tale tema quello della necessità di agire sempre, in ogni caso, in solitudine (relativa). Per chiarire già da ora la mia “posizione”, dichiaro subito la mia simpatia per forme di isolazionismo “moderato”, per non cadere vittima di trabocchetti di pato-logicizzazione vittimista/“complottista”, in effetti: paranoico-ossessivi, dell’esistere, che riconoscono cioè il vantaggio dell’isolamento, in prima approssimazione (come movimento iniziale), all’interno però di reti di relazionalità, comunque rivestite/riformulate (incessantemente).
Riprendendo le suggestive analisi di Borgna, non si può fare a meno di rilevare come esse insistano su una immagine della solitudine come silenziosa possibilità di certificazione di una ricchezza di malinconie, angosce, speranze (una dimensione di fertile problematicità, rappresentabile come tacita), che non aspetta altro che di tradursi in positiva relazione con il mondo, con gli altri e le cose. Alla significatività di tale dimensione cor-risponderebbe l’insignificanza (della volontà) dell’isolamento, con il suo inevitabile e consequenziale mutismo, espressivo di una distanza affermata come insuperabile dagli altri, a cui non vale assolutamente la pena trasmettere emozioni e pensieri. L’isolamento storditamente egocentrico, la desertificazione emotiva, l’indifferenza nei confronti di tutto ciò che stimola sentimenti di solidarietà (per non parlare dell’amore), accompagnati da una “idolatria dell’io, del corpo, della bellezza” che, ben si esprime nella richiesta di una “minimalizzazione” del volto: “Voglio un appuntamento per una modifica facciale: gli occhi più piccoli e allungati e l’eliminazione del padiglione auricolare”, (3) sono effettivamente il segno chiaro della metamorfosi odierna della “nostra” dimensione esistenziale in un senso solamente negativo, oppure rinviano ad un tra-passo identitario, ovviamente mostruoso, che mette a valore anche l’isolamento, la solitudine radicale, difficilmente vivibile? Insomma, vorrei prendere un po’ più sul serio l’aforisma pascaliano che sottolinea il derivare dell’infelicità umana dall’incapacità di starsene da soli: aggiungerei con “l’anima in pace”, cioè disposta a ben ricevere ciò che di solito inquieta, bussando alla porta, come futuro “prossimo”. Un’altra osservazione di contorno alle “cronache dell’isolazionismo”, che concentra gli apparenti “ritardi mentali” su una “vita interna aliena” che gela il sangue e costringe a “fare i conti”, può stimolare una riflessione che punta non tanto a mettere in evidenza i processi di de-socializzazione e de-motivazione (de-emozionalizzazione) propri dell’era del digitale, soprattutto nelle sue espressioni a livello “social network”, che coinvolgono in larga misura adolescenti addestrati a far fronte rapidamente all’assenza di risorse preziose di relazionalità produttiva, bensì ad individuare gli elementi di criticità di una comunicazione intesa come “trasmissione e propagazione di un’informazione”.
Quest’ultima citazione è riferibile ad un testo di Deleuze su Che cos’è l’atto di creazione?, sul quale vorrei soffermarmi, innanzitutto perché consente di chiarire alcune delle ragioni che stanno alla base della mia attenzione al “Neuro Habitat” e poi perché rilancia un motivo-chiave di un pensiero risolutamente contrario alla pretesa di trovare matrici di “corretto” impegno etico-politico, di impatto cioè “solidale”. Prima di arrivare al “motivo-chiave”, si tratta di richiamare una definizione di informazione che la comprende come “un insieme di parole d’ordine”. Scrive Deleuze: “Quando venite informati, vi dicono ciò che si presume che voi dobbiate credere. In altri termini, informare vuol dire far circolare una parola d’ordine. Le dichiarazioni di polizia sono chiamate a giusto titoli comunicati. Ci vengono comunicate delle informazioni, ci dicono ciò che si presume che possiamo, dobbiamo o siamo tenuti a credere. Nemmeno a credere ma a fare come se credessimo. È questa l’informazione, la comunicazione e, senza queste parole d’ordine e la loro trasmissione, non ci sarebbe l’informazione, né comunicazione. Il che equivale a dire che l’informazione è proprio il sistema del controllo. È evidente e oggi ci riguarda particolarmente”.(4)
Le “parole d’ordine” sono strettamente imparentate, a mio parere, con i “comandi” di E. Canetti e quindi toccano la seconda delle due “dinamiche” indicate nel titolo della grande opera pubblicata nel 1960: Massa e potere (ma si potrebbero “saltare” i riferimenti “colti” per arrivare direttamente a Comunicazione e potere, di M. Castells). Gli “ordini” sono delle “spine”, che si conficcano nella “carne” di coloro che li ricevono, provocando una spinta immediata ad estrarle e ad indirizzarle altrimenti, verso soggetti differenti, “comunicandole” loro, realizzando così una sorta di “comunione” nel senso dell’offesa e della trasmissione/propagazione delle violenze e delle ferite. Ora ciò che Deleuze rileva è un tradursi dell’informazione (forse un suo inevitabile tra-dirsi oppure un truffare quello che la determina nella sua parzialità/revocabilità?) nel “sistema controllato delle parole d’ordine diffuse in una data società”. Rispetto a tale “sistema” è possibile pensare ad un contro-informare effettivo che non può che valere che come “atto di resistenza”. Ma cosa resiste? Se si continua con la lettura di Che cos’è l’atto di creazione?, si vede come sia l’arte, che “ha qualcosa a che fare con l’informazione e con la comunicazione solo in quanto atto di resistenza”, anche se essa “non è l’unica cosa a resistere”. Ma è proprio rispetto all’arte che Deleuze ricorda A. Malraux, in modo tale da riferire il suo “detto” anche alle altre “cose” che resistono: l’autore di La condizione umana afferma infatti che l’arte è ciò che resiste alla morte e allora si potrebbe anche sostenere che tutti gli atti di parola, di pensiero, di vita sono pratiche di resistenza, di lotta/combattimento contro le ri-partizioni devastanti, costitutivamente “reattive” e portate quasi “naturalmente” all’estremo della mortificazione, dei poteri. In breve, la resistenza alla morte è propria dell’opera d’arte e della lotta degli uomini. Per riflettere ancora su tali forme, che rinviano alla possibilità concreta di una contrapposizione netta alle “monete del potere”, alle minacce di morte, in un qualche “senso” (per riprendere ancora Canetti), ripiego su una linea di ricerca che Deleuze sviluppa proprio in un confronto diretto con Foucault. La costellazione di testi di cui mi servo è quella composta da Desiderio e piacere, Che cos’è l’atto di creazione?, Che cos’è un dispositivo?, composti in periodi diversi: il primo nel ’77, gli altri due negli ultimi anni Ottanta. Da tale costellazione estraggo una “dominante”, a cui Deleuze è particolarmente interessato, quella dello svilupparsi (!) della società cosiddetta “disciplinare” in vera e propria “società del controllo”, fatta oggetto di un esercizio mobile di pensiero, di un “pensare in termini di linee mobili”, l’unico per il quale valga la pena impegnare energie fisiche, mentali, psico-sociali. In Desiderio e piacere si trova una illuminante definizione del potere – “(…) è una affezione del desiderio” – che ce lo restituisce anche nella sua “natura” di possibile spazio positivo di soddisfazione delle “tendenze” che ci attraversano e che sembrano “naturalmente” nostre. Il desiderio non è mai “naturale, è invece un (mostruoso…) ibrido “natural-artificiale”, un “concatenamento” di “agenzie” e fattori vari che (auto)media i suoi sviluppi, che certo possono anche assumere una “piega” ossessivo-paranoica, rigidamente identitaria (“fissista”). La pragmatica del potere delineata da Foucault nei primi anni Settanta è “all’altezza dei tempi”, ideologicamente predisposti alla “truffa” del neoliberismo (nelle sue diverse versioni: da quella (pseudo) anarchica alla celebrazione dell’ordine “automatico” del mercato, dalla veste “americana” a quella “tedesca”), e Deleuze è portato a prestarvi la giusta, ben proporzionata, attenzione nel momento in cui appare irrinunciabile sbrigare il compito di una riformulazione d’attacco dei saperi delle eventuali linee di resistenza. È in questa direzione che si cerca di pensare in termini di linee mobili, di traduzione parziale anche delle elaborazioni più sofisticate delle “tendenze”, “alla” Melville (per così dire…), ma ciò che più interessa qui è riprendere un’osservazione di Che cos’è un dispositivo? che presenta il quadro delle società moderne in una forma che mi sembra opportuno riproporre, sulla base di una idea del nostro appartenere a dispositivi (di potere) che consentono di distinguere “ciò che siamo” (“ciò che già non siamo più”, vale a dire la “storia”) e ciò che stiamo diventando, cioè la “parte dell’attuale”. In questo senso vale l’identificazione della storia con l’archivio (“il disegno di ciò che siamo e cessiamo di essere”), mentre dell’attuale bisogna dire che esso è “l’abbozzo di ciò che diventiamo”: allora la storia appare come “ciò che ancora ci separa da noi stessi, mentre l’attuale è questo Altro con cui già coincidiamo”: tale quadro di società non è semplicisticamente raffigurabile attraverso la lettura della società moderna come complesso di dispositivi disciplinari di fatto opposti ai tradizionali dispositivi di sovranità. Foucault è molto più sottile di come lo presentino molti dei suoi interpreti: “(…) le discipline descritte da Foucault sono la storia di ciò che a poco a poco cessiamo di essere, e la nostra attualità si disegna in disposizioni di controllo aperto e continuo, molto diverse dalle recenti discipline chiuse. Foucault è d’accordo con William S. Burroughs, che ci preannuncia un avvenire controllato piuttosto che disciplinato. La questione non è di sapere se è peggio. Perché anche noi facciamo appello a produzioni di soggettività capaci di resistere a questo nuovo dominio e molto diverse da quelle che si esercitavano precedentemente contro le discipline. Una nuova luce, nuove enunciazioni, una nuova potenza, nuove forme di soggettivazione? In ogni dispositivo dobbiamo districare le linee del passato recente e quelle dell’immediato futuro: la parte dell’archivio e quella dell’attuale, la parte della storia e quella del divenire, la parte dell’analitica e quella della diagnosi”.(5)
Non è sufficiente porsi/proporsi criticamente in modo “indisciplinato”. Ci vuole altro nel quadro delle società moderne, laddove Foucault insegna il valore imprescindibile del servirsi della storia a vantaggio – contro il tempo dato – di un “tempo a venire”. Acutamente Deleuze mette in relazione il nuovo o l’attuale, nell’ottica foucaultiana, con l’inattuale, l’intempestivo, in senso nietzscheano, proprio nel momento in cui si insiste sul protagonismo del divenire “che si biforca con la storia”, stimolando una “diagnosi che sostituisce l’analisi seguendo altre strade”. È ancora un richiamo all’attenzione, allo stare attenti rispetto “all’ignoto che bussa alla porta”, a caratterizzare il testo deleuziano, che ripropone un “passo” decisivo di L’archeologia del sapere, che sembra proprio introdurre ad una comprensione dell’operare di Foucault come risultato di una combinazione particolarmente felice della determinazione precisa dell’archivio (con strumenti storici originali) con la componente diagnostica, sbilanciata sulle dominanti di creatività e di attualizzazione che delineano il nostro “oggi”, scompigliandolo/scompaginandolo. Il “passo” in questione, assai “lungo” a dire il vero, è il seguente: “L’analisi dell’archivio comporta dunque una regione privilegiata, che è al tempo stesso vicina a noi, ma differente dalla nostra attualità ed è il bordo che circonda il nostro presente, che lo sovrasta e lo indica nella sua alterità; è ciò che sta fuori di noi e ci delimita. La descrizione dell’archivio sviluppa le sue possibilità (e la padronanza delle sue possibilità) a partire dai discorsi che hanno appena cessato di essere nostri; la sua soglia di esistenza è instaurata dalla frattura che ci separa da ciò che non possiamo più dire, e da ciò che cade fuori della nostra pratica discorsiva; incomincia con l’esterno del nostro linguaggio; il suo luogo è lo scarto delle nostre pratiche discorsive. In questo senso vale come nostra diagnosi. Non perché ci permetta di fare il quadro dei nostri tratti distintivi e di tracciare in anticipo la figura che avremo in futuro. Ma ci distacca dalle nostre continuità; dissipa quella identità temporale in cui amiamo contemplarci per scongiurare le fratture della storia; spezza il filo delle teleologie trascendentali; e laddove il pensiero antropologico interrogava l’essere dell’uomo o la sua soggettività, essa fa brillare l’altro e l’esterno. Così intesa, la diagnosi non stabilisce la costatazione della nostra identità mediante il meccanismo delle distinzioni. Stabilisce che noi siamo differenza, che la nostra ragione è la differenza dei discorsi, la nostra storia la differenza dei tempi, il nostro io la differenza delle maschere”.(6)
Tutto ciò stabilisce la parzialità di ciò che siamo, accompagnando quello che appare essere il “nostro” di-segno con dinamiche di attualizzazione (di divenire) che stanno insieme agli “strati”, alle “sedimentazioni” . I dispositivi si definiscono anche attraverso la novità, l’originalità, che essi esprimono, il che indica anche la loro possibile trasformazione: meglio, il loro trasformarsi “a vantaggio di un dispositivo futuro” – in tale prospettiva sono soprattutto le linee di soggettivazione, portate a fuggire le “prese” delle dimensioni del sapere e del potere, a presentarsi come “particolarmente adatte a tracciare percorsi di creazione”, in grado di provocare la “rottura” dei vecchi dispositivi.
Tra parentesi, ma in modo da riaffermare le distanze segnalate in apertura di questo mio testo: la “mossa” della sottrazione, del sottrarsi in direzione dell’avvenire, è ciò che ritrovo, in forme estremizzate, nelle “cronache” di Neuro-Habitat, laddove si articola una linea di soggettivazione assolutamente anomala, con percorsi di creatività destinati certamente ad abortire, ma che segnalano in ogni caso un moto di resistenza che sembra andare al di là della formula moderna per eccellenza di contestazione, quella del “preferirei di no” del Bartleby melvilliano.(7)
Qui si tratta di fuori-uscire da qualsiasi contesto di comunicazione, dal pregiudizio del “non si può non comunicare”, nel momento in cui alla comunicazione è riferito l’assillo dell’ordinare a tutti i costi, del lancio incessante dei comandi. L’isolazionista radicale costituisce un personaggio artistico, una figura rilevante, a cui si può guardare con interesse proprio perché rappresenta un blocco dell’informazione (del sistema controllato delle parole d’ordine in un determinata società) che consente di preparare la controinformazione a fare effettivamente qualcosa, a farla diventare un atto di resistenza vero e proprio (altrimenti vale l’osservazione di Deleuze che la controinformazione, in quanto tale, “non è mai stata sufficiente per riuscire a fare qualcosa”).
Ritornerò sull’importanza di ciò che non contiene, nel senso sopra riportato (del “controllo”), la pur minima informazione. Adesso mi pare opportuno riprendere in mano ancora un po’ il filo del ragionamento deleuziano sull’analisi dell’amico Michel a proposito delle società di sovranità e di quelle disciplinari. Queste ultime sono contraddistinte dalla realizzazione di luoghi di internamento (prigioni, scuole, officine ecc.) e molte pagine di Foucault restituiscono con straordinario acume il bisogno specifico di tali luoghi che pervadeva le società disciplinari. Ma Foucault non si è limitato ad assolvere semplicemente al compito comunque delicato della descrizione minuziosa degli assetti e delle configurazioni specifiche di tali società. L’autore di Sorvegliare e punire non ha mai pensato, a parere di Deleuze, che le società disciplinari fossero l’ultima parola, fossero cioè “eterne”: la sua idea era anzi quella che si stesse entrando in un tipo diverso di società, segnato ancora dall’emergenza di resti/residui delle società disciplinari, per il quale si propone, come già sottolineato, la formula, coniata da Burroughs, della “società di controllo”. Si deve poter cogliere la novità delle pratiche di coloro che affermano di pensare oggi al nostro “bene”, che non necessitano più soltanto di luoghi di internamento. Dice Deleuze (nel 1987!): “Le prigioni, le scuole, gli ospedali sono già oggetto di discussioni continue. Non è meglio dispensare le cure a domicilio? Probabilmente è questo il futuro. Le officine, le fabbriche scricchiolano in ogni punto. No sarebbero meglio i regimi in subappalto e il lavoro a domicilio? Non ci sono altri mezzi per punire la gente al posto della prigione? Le società di controllo non passeranno più per i luoghi di internamento. Nemmeno per la scuola. Bisogna stare attenti ai temi che stanno nascendo, che si svilupperanno nei prossimi quaranta o cinquant’anni e che ci spiegano quanto sarebbe straordinario mettere insieme scuola e professione. Sarà interessante sapere come cambierà l’identità della scuola e della professione con la formazione permanente, che è il nostro avvenire e che non comporterà più necessariamente la concentrazione degli scolari in un luogo internamento. Un controllo non è un disciplina. Con un’autostrada non si rinchiude nessuno ma costruendo autostrade si moltiplicano i mezzi di controllo. Non dico che sia questo l’unico scopo dell’autostrada ma la gente può girare all’infinito e ‘liberamente’ senza essere affatto rinchiusa, pur essendo perfettamente controllata. È questo il nostro futuro”.(7)
Ho toccato il motivo del Bartleby melvilliano, a proposito di un “precedente” straordinario di possibile atto di resistenza all’imporsi dell’informazione come sistema controllato delle parole d’ordine propagate all’interna di una certa società (sempre a Bartleby si sarebbe dovuta riferire, è opportuno ricordarlo, la sesta lezione a Harvard, quella “mancante”, di I. Calvino dedicata alla “Consistency”). Ciò che conta del motto/moto di resistenza, caro allo stesso Deleuze, può essere rinviato alla lettura del personaggio concettuale dell’idiota (a cui affido la sorte benigna del Neuro-Habitat), così come viene sviluppato dallo stesso Deleuze, insieme a F. Guattari, in Che cos’è la filosofia?. Si tratta, com’è noto, per ciò che concerne i personaggi concettuali, di “attitudini del pensiero” che si vedono e si sviluppano attraverso un piano che scorre in un “io” che non è più io, nel senso che il filosofo è finalmente mera parzialità, “l’involucro del suo principale personaggio concettuale e di tutti gli altri, che sono gli intercessori, i veri soggetti della sua filosofia”.(8)
L’idiota è appunto un personaggio concettuale e qui interessa come “potenza del concetto”, diversa dalla “potenza dell’affetto e del percetto”, che riguarda propriamente la figura estetica. La differenza va ben considerata (e possibilmente trattenuta), ma si deve insistere sul fatto che la filosofia e l’arte comunque “pensano”, in modo diverso (“ritagliano il caos e l’affrontano”), e così spesso passano, nelle due entità che le individuano, l’una nell’altra, “in un divenire che le trascina entrambe, in un’intensità che le condetermina”.
Proprio in apertura del terzo capitolo di Che cos’è la filosofia? (nell’“Esempio V”) si presenta una riflessione che conduce alla rilevazione di una differenza tra due tipi di idiota, il “vecchio” e il “nuovo”. Punto di partenza è il “cogito” di Descartes, che rinvia a “qualcos’altro”, che “effettivamente c’è, qualcosa di assai misterioso che appare a tratti, o che traspare, che sembra avere un’esistenza sfumata, a metà strada tra il concetto e il piano preconcettuale, e che vaga dall’uno all’altro”.(9)
Ciò che esiste al di fuori del concetto e del piano di immanenza è appunto l’idiota, colui “che dice Io, che lancia il cogito, ma che detiene anche i presupposti soggettivi o che traccia il piano”, che si manifesta come “pensatore privato”, in alternativa al “professore pubblico” (“scolastico”), che “non smette di rinviare ai concetti insegnati (l’uomo animale razionale)”: l’idiota forma concetti (“io penso”!) con “le forze innate che ciascuno di per sé possiede di diritto”. In virtù della “luce naturale” è possibile infine pensare veramente da soli. Deleuze e Guattari delineano così questo strano personaggio concettuale e si chiedono da dove provenga: da un ambito cristiano? Si pensi in effetti a S. Agostino, alla sua reattività critica nei confronti dell’organizzazione data della Chiesa, oppure a Cusano, che conferisce pieno valore al personaggio dell’idiota. Per afferrare meglio tale risorsa di pensiero, è però opportuno portare l’attenzione su un altro contesto, “ancora cristiano”, come quello russo, che ci mostra il diventare slavo dell’idiota, il suo restare un personaggio privato, accompagnato da una significativa trasformazione della sua singolarità, che rende ancora diversa l’opposizione tra il pensatore privato e il professore pubblico. Il rinvio è ovviamente a Dostoevskij, letto da Chestov, laddove appare possibile individuare tutto ciò che distingue il nuovo idiota dal vecchio. Quest’ultimo “voleva delle evidenze alle quali sarebbe arrivato da solo: nell’attesa avrebbe dubitato di tutto, anche che 3+2=5; avrebbe messo in dubbio tutte le verità della Natura. Il nuovo Idiota non vuole nessuna evidenza, non si ‘rassegnerà’ mai al fatto che 3+2=5, vuole l’assurdo; non è più la stessa immagine del pensiero. Il vecchio idiota voleva il vero, ma il nuovo vuole fare dell’assurdo la massima potenza del pensiero, ossia creare. Il vecchio idiota voleva rendere conto solo alla ragione, ma il nuovo idiota, più vicino a Giobbe che a Socrate, vuole che egli si renda conto di ‘ogni vittima della Storia’; non si tratta degli stessi concetti. Egli non accetterà mai la verità della Storia. Il vecchio idiota voleva rendersi conto da solo di ciò che era o non era comprensibile, razionale o non razionale, perduto o salvato, ma il nuovo idiota vuole che gli si restituisca quanto è andato perduto, l’incomprensibile, l’assurdo. Di certo non è lo stesso personaggio, c’è stata una mutazione. Purtuttavia, un filo tenue unisce i due idioti, come se il primo dovesse ora perdere la ragione perché il secondo ritrovi ciò che l’altro aveva precedentemente perduto acquisendola. Forse Descartes è impazzito in Russia”.(10)
Da quest’altro lungo “passo”, ciò che ritaglio è la sottolineatura del fatto che il nuovo idiota vuole l’assurdo, vuole cioè recuperare ciò che è stato perso con l’affermazione del valore primario dell’evidenza, quella a cui ci richiama la vicenda “fumettistica” dell’isolazionista radicale, che la percepisce come quadro di civiltà intimamente connesso con un determinato sistema controllato di parole d’ordine. Potrei anche dirlo diversamente: se ogni concetto ha una storia, quello di “assurdo”, che attraversa il Novecento a cavallo di Kafka e di Beckett (tra gli altri), rinvia oggi in maniera incisiva anche al mondo di-segnato da Martin, che ce lo presenta – tale concetto – combinato/fuso/con-fuso con componenti di altri concetti e quindi di diversi problemi e piani. Ma cosa fa effettivamente il ragazzo senza nome? Sembra quasi che faccia fuori la possibilità di considerare differentemente il campo percettivo, meglio: che faccia fuori il possibile all’interno del campo percettivo. Ma le cose non stanno propriamente così: transizioni, diversioni/inversioni sono comunque richieste (“voglio un appuntamento per una modifica facciale: gli occhi più piccoli e allungati. Eliminazione del padiglione auricolare”). Si tratta qui di un tentativo di ri-uscita di una esistenza che si confronta con gli altri, certamente, ma forse per farla finita con loro (con tutto ciò che essi portano, con la loro “storia”), per non ricadere all’interno di una “serie”, collocandosi cioè al limite di essa, sulla soglia dell’esaurimento (ci dice qualcosa qui l’ “esausto” di Beckett, ripreso da Deleuze?), dell’ammutolimento, del venir meno, del fare a meno di sé (realizzare il “meno” in sé). Insomma, bisogna affrancarsi anche dal dire: il Neuro-Habitat dell’isolazionista radicale diffida radicalmente di coloro che ripropongono la dimensione (quella urbana, of course…) di una qualche possibilità di esercizio della parresia, su cui rifletteva l’ultimo Foucault e su cui è intervenuta con intelligenza critica Tiziana Villani.(11)
Un franco dire, filosoficamente riferito ad una trasformazione dell’urbano non mediatizzata unicamente in senso pato-logico, è ciò su cui precipita l’interdetto (meglio sarebbe “dire”: l’intra-detto ridotto al limite, una sorta di soliloquio di accompagnamento) dell’isolazionista che assolutamente non preferisce…, arrivando ad affermare l’inutilità di giocare parole vere, ragionevoli, agonistiche in qualsiasi campo di discussione (senza mettere in gioco quello “politico”, della polis…). Contro i poteri non vale abbastanza l’esercizio di parola (“credo che su di me non ci sia molto da dire, in effetti”) anche perché, ricordiamolo, “il potere è una affezione del desiderio”, per Deleuze), pure nobilitato performativamente: a ciò va comunque aggiunto con forza la parola dell’esercizio, la sua pratica, la con-ricerca dell’ibrido naturalculturale, l’individuazione “minimale” di spazi qualunque e però determinati, con i loro specifici tempi (che l’artista Martin disegno con quelle immagini “estreme” che raffigurano un esaurimento, soprattutto quello del possibile, per citare ancora Deleuze, ripresentato dalle varie figure che attraversano il Neuro-Habitat).
Ancora qui “l’esaurimento è un processo creativo” (G. Bompiani): non ci stanca dunque, non si tenta cioè di finire, di arrivare ad una qualche fine (reale). Non si deve neppure vedere in tutto questo la semplice riaffermazione, all’interno di uno scenario urbano stra-volto (o “esploso”), di una sorta di narcisismo autoreferenziale (spacciato come arma “finale”, strumento di auto-difesa, sotto veste sacrificale, di una identità soggettiva “piegata/piagata”, resa monca dai terribili impatti con un “mondo vivente”). Forse è in questa direzione (soltanto in tale direzione) che va ripresa la possibilità concreta di una azione di verità (che vuole l’assurdo contro il primato dell’evidenza), pensata da Foucault – così riassume incisivamente Villani – “come tecnica di affermazione di una persuasione non comunicativa” e come “agente nel senso di un riconoscimento di tutte quelle alterità, virtualità che intendono essere espresse, ma che vengono distrutte al solo loro annunciarsi per l’evidente crisi che producono nelle maglie delle società di controllo”.(12)
Rispetto alla soggettività che in questi termini torna in questione, con il di-segno delle sue posture, non bisogna allora smettere di portare l’attenzione alle dinamiche di affezione (“tendenze di affezione”: così ancora Villani), con quella loro potenza che residua incessantemente relazionalità e rende problematico un investimento emotivo “minimo” unicamente rivolto al mondo reificato: “Infatti, se il narcisismo può essere considerato come la patologia del nostro tempo che prolifera nella perdita di senso del mondo vivente, occorre comprendere come questo avvenga in ragione del depotenziamento e disconoscimento delle tendenze di affezione. I processi di individuazione considerano la rifunzionalizzazione ‘organologica’ (Stiegler) intervenuta nel tempo della tecnica, ma ne spostano l’attenzione verso la costruzione ambientale di potenza dove la soddisfazione degli ‘istinti’ (Deleuze), è espressione di senso, ossia liberazione di un sensibile capace di azione e di reinvenzione delle esistenze”.(13)
Su questa base di terminologia filosofica “ipermoderna”, il Neuro-Habitat, rivestito anche dalle forme particolari di una sensibilità critica all’altezza dei tempi delle nuove alienazioni (così come la si poteva ritrovare, in apertura degli anni Sessanta del secolo scorso in alcune opere cinematografiche di M. Antonioni), non può che richiamare un’epoca come la nostra, quella dell’affermazione delle “passioni tristi”, che trova una esemplificazione assai significativa nel fenomeno “Hikimori”, che riguarda centinaia di migliaia di giovani giapponesi che vivono per lunghi periodi di tempo in una condizione di radicale isolamento all’interno delle loro piccole “camere”, rifugio e prigione insieme, equipaggiate elettronicamente in modo tale da assicurare una connessione con il fuori il più possibile asettica, an-estetica. Ecco, è proprio l’an-estetico che si presenta come una compensazione illusoria di una difficoltà a vivere, a riconquistare fiducia e rispetto. Per rispondere a tutto questo, per far veramente sentire l’angoscia e l’impotenza di fondo del Neuro-Habitat, per riflettere sul serio sul senso della solitudine “odierna”, per andare oltre la “bolla” informazionale (e “formativa”) dentro la quale rimaniamo imprigionati, per ritrovare rispetto e dignità (compito straordinariamente complesso di un pensiero che si voglia sociale e politico), l’unico modo sembra ormai essere quello – nell’urbano come condizione esistenziale ormai prevalente, maggioritaria – di dedicarsi “banalmente” alla “banalità del lavoro” (S. Bologna), a quella che contrassegna sempre più vistosamente le moltitudini del lavoro postfordista.
Questo testo è pensato soprattutto per Guido e Giovanni.
Note
1. Cfr. Martin M. A., Neuro Habitat. Cronache dell’isolazionismo, tr. a cura di A. Trabacchini, Roma, Coniglio, 2008.
2. Cfr. l’intervista di L. Sica ad E. Borgna, La solitudine come rifugio ai tempi del social network, in “la Repubblica” del 19.01.2011, p.56. Il rinvio è a E. Borgna, La solitudine dell’anima, Milano, Feltrinelli, 2011.
3. Martin M. A., Neuro Habitat. Cronache dell’isolazionismo, cit., p.74.
4. Deleuze G., Che cos’è l’atto di creazione?, in G. D., Due regimi di folli e altri scritti. Testi e interviste 1975-1995, edizione italiana e tr. a cura di D. Borca, introduzione di P. A. Rovatti, Torino, Einaudi, 2010, pp.263-264.
5. Deleuze G., Che cos’è un dispositivo?, in G. D., Due regimi di folli e altri scritti, cit., p.285.
6. Foucault M., L’archeologia del sapere, tr. di G. Bugliolo, Milano, Rizzoli, 1971, pp.175-176.
7. Deleuze G., Che cos’è l’atto di creazione?, cit., pp.264-265.
8. Deleuze G.– Guattari F., Che cos’è la filosofia?, tr. di A. De Lorenzis, a cura di C. Arcuri, Torino, Einaudi, 1996, p.53.
9. Ivi, p.51.
10. Ivi, p.52.
11. Cfr. Villani T., Metamorfosi dell’urbano. Istituzioni e diritti della nuova Polis, in “Millepiani/Urban”, n.1, Milano, Eterotopia, 2009, pp.55-68.
12. Villani T., Divenire della tecnica e processi di singolarizzazione, in “Millepiani”, n.36, Milano, Eterotopia, 2010, p.67.
13. Ivi, p.68.


