L'edicola digitale delle riviste italiane di arte e cultura contemporanea
Millepiani Anno 20 Numero 40 novembre 2013
La macchina del senso
Nicola Lonzi
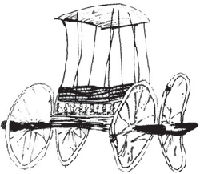
Filosofia, estetica e politica

• Premessa 5
• Daniela Cappelleto
Introduzione a
Francis Bacon and the Brutality of facts 9
• Francis Bacon
Francis Bacon and the Brutality of facts 13
• Tiziana Villani
La carne, la macchina e i processi
di assoggettamento: Figure di Francis Bacon 43
• Ubaldo Fadini
Figure e territori 55
• Daniela Cappelletto
Le stanze di Francis Bacon 71
• Félix Guattari
Dagli anni d’inverno all’ecosofia 77
• Claudia Landolfi
Controllo e discontinuità
della “materia informazionale”
nella tecnologia digitale 87
• Ben Matsas
Le singolarità utopiche
di una rivoluzione istituzionale 103
• Rosella Corda
Pedagogia del concetto 135
• Nicola Lonzi
La macchina del senso 147
• Alessio Kolioulis
La libertà ai tempi del controllo 159
• Davide Calenda-Joe Cullen
Aspettando la metro a Dalston Junction 167
• Filippo Domenicali
Biopolitica ed ecologia 175
• Andrea Cagioni
Rendita, accumulazione
e nuovi processi di valorizzazione nel web 2.0 185
• Silverio Zanobetti
La città pensa in me 195
• Paolo Vignola
Il consumo della creatività 213
artefacts
• Tiziana Villani
ArteFacts: laboratorio di ricerca artistica 233
• Paul D. Miller
Data Aesthetics 235
• Recensioni & schede di lettura 243
PREMESSA millepiani 40
Questo volume segna il ventesimo anno di articolazione di un percorso di ricerca condiviso con diversi amici e in scambio continuo con tutti coloro hanno seguito, sollecitato, interrogato le nostre modalità di indagine.
Gli autori e gli artisti che a vario titolo hanno segnato la nostra singolare storia si iscrivono in un orizzonte di pensiero che non si è limitato soltanto a decifrare il presente, quanto a rilevarne le zone critiche nell’intento di aprire piani di espressione più liberi.
La filosofia era ed è per noi l’ambito privilegiato di questa interrogazione. L’esercizio della filosofia ci ha permesso di sviluppare uno stile nei modi e nelle forme attraverso le quali abbiamo via via individuato gli snodi concettuali che più ci premevano e che con tenacia e rigore continuiamo ad approfondire.
Lo stile è quello proprio di un procedere insieme, nel rispetto e nel riconoscimento delle singolarità che aspirano a mettere in comune le differenti posizioni e vie di ricerca.
In questo numero abbiamo predisposto una cartografia di concetti sui quali da tempo lavoriamo: i corpi vivi e in tensione storicamente determinata, l’agire creativo nell’età del venir meno della retorica dell’alterità, le trasformazioni macchiniche del tempo digitale, le istituzioni di soddisfazione possibile. Non a caso compaiono due importanti interviste: quella di Francis Bacon, rilasciata a David Sylvester nel 1984, e quella di Félix Guattari, realizzata presso la televisione greca, nel 1992, che ci appare quasi come un ultimo lascito di grande potenza teorica. In queste interviste, pur molto diverse tra loro, emerge un intento comune, che ci preme rimarcare: quello del superamento possibile dello stato delle cose, a partire da una tensione che sfugge alle catture di un sociale apparentemente opaco, poiché intravede territori esistenziali originali e innovativi, di più decisa e appunto radicale soddisfazione possibile.
Tutti gli interventi, come ormai accade negli ultimi anni della nostra attività, hanno sviluppato questa tensione complessiva e si sono quindi predisposti secondo uno schema di effettuazione della potenza di un pensare insieme, alla luce anche degli “insegnamenti” - dei “segni” che consideriamo ancora oggi ineludibili – dei nostri “classici” di riferimento (con particolare attenzione qui a Spinoza).
Un’ultima annotazione: l’ambiente di ricerca di “Millepiani” non ama la polemica o l’eccesso di discussione (con le sue ovvie patologie, come ha più volte sottolineato Gilles Deleuze) nei confronti di altre modalità di indagine che tentano di ritrovare l’agire filosofico: esso si vuole semplicemente diverso e in ogni modo assai distante rispetto a quelle tecniche di storicizzazione e di comunicazione, sotto veste di rilancio di parole d’ordine, che sono le vere nemiche dello stile e delle pratiche di elaborazione innovativa del pensiero filosofico.
Quarta di copertina millepiani 40
La filosofia necessita di cartografie: concettuali, ambientali, amicali. Nei vent’anni di storia di “Millepiani” abbiamo cercato di delineare percorsi di pensiero critico in uscita, per così dire, dal Novecento, interpellando però di quest'ultimo alcune delle voci per noi ineludibili: Gilles Deleuze e Fèlix Guattari, Michel Foucault, Walter Benjamin, Paul Virilio, tra gli altri, e artisti che da Francis Bacon al nuovo attivismo creativo, come nel caso di Ernest Pignon-Ernest o Banksy, hanno saputo fare i conti con le lacerazioni del presente.
In particolare, questo volume si interroga su quel tempo delle macchine ipercomplesse in cui fattori discorsivi quali l’economia, la comunicazione, la costruzione delle identità convergono nel tentativo di produrre forme di governo che impediscano la creazione di visioni differenti del sociale e dei soggetti coinvolti.
Le cartografie filosofiche sono sempre scritture del desiderio e della sua potenza, veri e propri esercizi che coniugano la ricerca teorica con le disposizioni aperte, minori, plurali inventive delle soggettività.
Il tempo delle macchine ipercomplesse è il nostro tempo, un tempo di trasformazioni spesso difficili, ma non per questo meno interessanti dal punto di vista dei territori esistenziali che si possono aprire. Le vite si possono qui nuovamente pensare – questa è la nostra scommessa – in termini di soddisfazione sempre più diffusa, di società, di amicizia e capacità di sottrazione da forme di dominio inevitabilmente escludenti e violente. A questa interrogazione del nostro tempo siamo chiamati attraverso una radicale messa in discussione dei modelli di vita che ci sono proposti, e che continuiamo a non considerare come gli unici possibili.
FRANCIS BACON, FÉLIX GUATTARI, ANDREA CAGIONI, DAVIDE CALENDA,
DANIELA CAPPELLETTO, ROSELLA CORDA, JOE CULLEN, FILIPPO DOMENICALI,
UBALDO FADINI, ALESSIO KOLIOULIS, CLAUDIA LANDOLFI, NICOLA LONZI,
BEN MATSAS, PAUL D. MILLER, PAOLO VIGNOLA, TIZIANA VILLANI, SILVERIO ZANOBETTI
Recensioni a cura di: Ubaldo Fadini, Afroditi Koukoutsaki-Marios Emmanuelidis, Domenico Vertone, Tiziana Villani
Ontologia e praxis istituzionale
Ben Matsas
n. 39 novembre 2012
L'uscita dal futuro
Tiziana Villani
n. 37 novembre 2011
Deep Ecology ed ecosofia
Silvano Cacciari
n. 36 novembre 2010
Il Fuori della Filosofia. Crisi di senso, vero dire e umorismo
Tiziana Villani e Ubaldo Ladini
n. 35 novembre 2009
Cittadinanza radicale nella repubblica della tecnologia
Darin Barney
n. 34 ottobre 2008
Anarchismo borghese e democrazie autoritarie
Felix Stalder
n. 33 gennaio 2008



Il senso, il desiderio e il corpo formano una massa indistinguibile. Se ci si ferma a pensare con calma ad ognuno di questi oggetti, non si riesce a distinguere i contorni che separano l’uno dall’altro.
Questa è una delle conseguenze che trapelano da una certa lettura dell’Ethica (1) di Spinoza, nella quale l’uomo viene definito, nella propria essenza, come Affetto, sia in quanto Corpo, che in quanto Mente. Corpo, mente, senso, significato, emozione: se guardati dalla prospettiva del desiderio o affetto, tutti questi piani appaiono allora come un unico piano in continuo movimento(2).
In tale prospettiva dicevamo, l’uomo è inteso come senso, affetto e meccanismo. Tre aspetti di un’unica materia desiderante, di un’unica macchina di senso.
Una volta che l’uomo sia inteso come materia desiderante, dobbiamo guardare per prima cosa al suo corpo per comprendere come esso produce significato, sempre nel contatto con altri corpi e nella manipolazione effettiva e concreta in cui sono coinvolti i suoi desideri.
Dire che il senso è legato al desiderio significa sostenere che esso è legato alle sue dimensioni di aumento e diminuzione, il senso esattamente come il desiderio può aumentare e diminuire, esso fa esattamente ciò che fa il desiderio, inteso qui come la radice dell’affettività.
Il senso è implicato nel desiderio e nella sua non-indifferenza all’accadere, nella sua caratteristica di essere “provato” e “sentito” nel corpo e come corpo.
Ciò significa anche che il senso non è affatto appannaggio della parola e del linguaggio.
Vale semmai il contrario, il senso stesso risulta impensabile senza il desiderio, vale a dire che il senso e il significato chiamano in causa la significatività, ossia la caratteristica di non essere indifferenti o, detto altrimenti, il fatto che il desiderio sia per sua natura orientato. Il desiderio è orientato, è sforzo di accrescere la propria potenza di agire e pensare, e tale accrescimento è vissuto come gioia.
La legge del desiderio
Ma come avviene tale accrescimento? Come si riproduce il desiderio? Il desiderio si riproduce sempre manipolando, sempre come corpo. Sia nel pensiero, che nell’azione fisica, è il corpo in gioco, il corpo sul quale scorrono suoni muti di parole che chiamiamo pensiero, il corpo che lavora seduto, il corpo che fissa uno schermo, il corpo che corre e mangia, che articola suoni, che produce immagini oniriche. La materia desiderante che è il nostro corpo vivente si riproduce senza sosta manipolando ciò ha a disposizione, qualsiasi cosa abbia a disposizione, esso manipola gli oggetti che incontra seguendo la legge inevitabile della gioia, che è impegnata ad accrescere se stessa.
Il corpo manipola e si muove, sente e prova le proprie azioni e i loro effetti come gioie e tristezze, ossia come vissuti dotati di senso e organizzati nel corpo che li apprende. È così che al tempo stesso il corpo impara e diviene capace manipolando, apprende a parlare, a scrivere, a camminare ed andare in bicicletta, apprende a relazionarsi e a lavorare, il corpo si forgia come desiderio, senso e materia, la macchina desiderante si costituisce funzionando e riproducendosi, secondo le sue leggi, nel mondo reale in cui vive ed opera.
Il corpo in azione dunque implica il senso, non solo nel linguaggio, nella manipolazione di grafemi e fonemi, ma in qualsiasi sua disposizione, in ogni suo gesto, la significatività è all’opera.
La parola è fragile
Tra i tanti oggetti che il nostro corpo desiderante manipola, il segno linguistico non è affatto uno degli strumenti più potenti di senso a sua disposizione, la parola rispetto ad altri oggetti non ha un gran potere affettivo. Il significato, il senso più forte si dischiude nel rapporto con altri corpi viventi, il cui potere di affettarci è enorme. È attraverso gli altri corpi viventi che possiamo compiere degli scatti in avanti, delle transizioni o degli aumenti stabili di forza.
La macchina del corpo vivente funziona come un dispositivo affettivo, nelle sue dimensioni di produzione di senso e di produzione pratico-corporea, l’affetto è la chiave, è il perno sul quale e nel quale tutto ruota e la leva più potente sono gli altri corpi desideranti.
Più l’affetto può esprimersi, più si può rafforzare, nel rapporto con gli altri corpi, più il significato che produciamo e che proviamo sarà forte, perché le due cose, ancora una volta, sono una sola.
Ma non si tratta affatto di un processo spontaneo, poiché la nostra condizione di esseri finiti è esposta a continui limiti, nei quali il nostro affetto trova i suoi ostacoli e diviene tristezza, condizione di minore potenza e capacità espressiva.
Il saggio, nella visione spinoziana, non è colui che non prova tristezza ma colui che tratta la tristezza come qualcosa di naturale, e dunque anche come una risorsa, poiché la tristezza è una forma della gioia, ossia dell’affetto che ci caratterizza.
La tristezza è naturale tanto quanto la gioia e tutti i nostri affetti. Questa considerazione della tristezza(3) forse è uno dei più importanti insegnamenti di Spinoza, ma una volta detto questo non abbiamo fatto neanche un passo in avanti nella direzione del rafforzamento dell’affetto e della nostra potenza di agire e di senso.
Il senso non è qualcosa come un sapere che basta conoscere, come si conosce il senso di una parola o di una frase. Il sapere reale, il senso reale di questa conoscenza, è qualcosa che si guadagna col tempo, percorrendo strade difficili, con costanza e determinazione, con l’esercizio ripetuto che scolpisce il sapere nel corpo. Se così non fosse non sarebbe tanto difficile quanto raro imboccare questa via, aggiunge Spinoza proprio al termine, nell’ultima riga del lungo viaggio dell’Ethica(4).
Il corpo è particolarmente lento ad apprendere, ma ciò che apprende viene trattenuto con estrema forza. Una volta appreso, si scorda difficilmente come andare in bicicletta, suonare uno strumento, leggere, scrivere e naturalmente riflettere. Si scorda difficilmente poiché apprenderlo è stato molto faticoso, il corpo e il nostro affetto hanno appreso le proprie potenzialità col tempo, l’esperienza e l’esercizio, con l’affetto per una buona guida, che ci ha amato e che abbiamo amato, con la teoria che diventa senso e significato nella pratica del corpo e delle sue capacità affettive, emotive, dei suoi desideri.
La terra del desiderio
La parola libertà, quando parliamo dell’uomo, contiene un inganno, un accento negativo, un senso di onnipotenza. Sembra molto più adatta alla nostra condizione la parola crescita o transizione, nel senso di aumento della propria potenza, delle proprie capacità affettive, del senso. Che tale crescita sia legata anche alla dimensione collettiva, alle strutture e relazioni sociali che ci coinvolgono, non è un ideale astratto, ma la concreta realtà del nostro desiderio.
Come abbiamo detto infatti, tra tutte le cose che cadono a tiro del desiderio, tra tutte le cose che entrano a far parte dei suoi meccanismi di produzione, gli altri corpi viventi e desideranti sono le più potenti.
Non esiste nulla che possa assomigliare a una liberazione umana, per quanto il termine sia davvero poco adatto a descrivere il processo reale della crescita dell’uomo nella concretezza dei suoi desideri materiali, nulla dicevamo, che non passi per l’esercizio del corpo e dell’affetto. Nell’esercizio la macchina del senso, il corpo vivente, apprende manipolando.
Manipolando segni, lettere e suoni, penne e gessi, movimenti del corpo, ripetuti moltissime volte, con lo sforzo di migliorare. In tali manipolazioni che compiamo senza sosta, si dischiude il senso che produciamo e si forma il nostro corpo vivente, i nostri desideri si costituiscono e strutturano in blocchi emotivi, in complessi legni che si stratificano col tempo, come meccanismi che funzionano sopra altri meccanismi.
La macchina del senso funziona con oggetti di tutti i tipi, ma i segni, gli artefatti, i suoni che utilizziamo rimangono uno strumento, ciò che conta è quello che accade alla macchina desiderante, sono le transizioni stabili del suo desiderio.
Se il fine diviene la macchina stessa, se la macchina si esercita per migliorare se stessa e non solo le sue performance, allora l’esercizio diviene esercizio di libertà, nel senso di crescita e rafforzamento della gioia e del senso.
Se non si comprende il fine dell’esercizio, si costruiscono macchine ipertrofiche, dispositivi incatenati a un ruolo, a un posto, a una regola, a una convenzione, a un’istituzione, dispositivi privi di autonomia, dispositivi tristi, perché si sono esercitati a superare la tristezza e il limite, non ad utilizzarlo come caratteristica della propria natura.
Nelle nostre variegate relazioni col mondo e con le altre persone, i limiti sono forse il punto centrale dal quale far partire la riflessione e l’esercizio, poiché i nostri limiti sono la prima cosa che incontriamo, sono anche i nostri contorni, ciò che definisce la nostra figura, separandola dal resto, nella sua finitezza, concretezza e parzialità. Siamo presso di noi soprattutto nei limiti che ci contraddistinguono ed i limiti vanno a braccetto con le tristezze.
I limiti sono la concretezza, la realtà, la condizione del nostro corpo finito nel tempo e nello spazio. La libertà che non si confronta col limite è irreale, è fuga, è copertura, è ciò che propongono il mercato moderno e i suoi mercanti. La libertà di non crescere passo per passo, la libertà di arrivare senza affrontare la fatica della strada che abbiamo di fronte, come se percorrerla o meno fosse indifferente, questa libertà giova a chi la vende, è il business principale delle società spettacolarizzate, è la moneta brillante e irreale con la quale i vari conquistatori comprano la terra dei nostri desideri, ossia i nostri corpi e il loro asservimento, quello sì, tanto ingenuo quanto reale.
La terra del desiderio è dura come la terra del contadino, i nostri corpi hanno la durezza delle leggi di natura, sono da sempre un campo di lotta quotidiana per il desiderio, un campo che non resta mai immobile, esposto al gelo ed alla secchezza, una natura che solo con grande fatica e amore darà i suoi frutti.
Le tristezze sono gioia
Come già accennato, nella riflessione spinoziana che stiamo tentando di seguire, paradossalmente le tristezze sono dinamiche di gioia, nel senso che la tristezza indica il fatto che la nostra gioia sia diminuita, limitata, incontri dei limiti e degli ostacoli, trasformandosi in sentimenti di odio, rabbia, frustrazione, impotenza.
Ma ciò che è all’opera in questi sentimenti, lo sforzo che vi è implicato rimane sforzo di gioia, ossia sforzo di superare l’ostacolo.
I sentimenti sono naturali come tutto in una natura intesa come piano di immanenza, superficie che si estende ovunuqe arrivi il nostro orizzonte, i sentimenti non sono né buoni né cattivi, e ciò a cui portano, le strategie corporee che mettono in moto, saranno le più diverse, a seconda della nostra condizione concreta e della forza del nostro desiderio.
É rispetto a tali strategie che l’esercizio diviene fondamentale, poiché non è affatto scontato che le strategie del bambino si tramutino in quelle dell’adulto, così come non è raro che, seguendo la parabola del corpo, quelle del vecchio finiscano per assomigliare a quelle del bambino, esattamente come il suo corpo non più autosufficiente.
Ciò che conta per la nostra riflessione è comprendere come il senso sia legato alle dimensioni del desiderio o affettività, vale a dire alla gioia e alla tristezza, all’aumento e alla diminuzione di potenza del corpo.
Né buona, né cattiva
La storia, come le vicende individuali, riproduce dinamiche che sono le nostre, le dinamiche affettive.
La vita e la produzione umana sono affettive, nel senso in cui identifichiamo l’affetto col desiderio, senza ridurre quest’ultimo solo a cupidità specifiche, ma trattandolo come la radice dell’affettività, il nome e il concetto col quale designare la dimensione oggettiva di una forza soggettiva, né buona, né cattiva, ma meccanicamente, ossia indifferentemente funzionante come non-indifferenza, provata nel corpo.
Una macchina di non-indifferenza, una macchina che funziona come tutte le altre macchine, fa ciò che fa e basta. E ciò che fa è non essere indifferente, desiderare, nel mondo concreto, nel quale trova i suoi limiti e le sue crescite, sempre attraverso la manipolazione concreta del corpo, seguendo le ineluttabili leggi della gioia.
Il nostro corpo produce ed è attivo in ogni momento, indipendentemente da noi, da ciò che vorremmo, da ciò che non vorremmo, il corpo è una macchina sempre attiva, sempre in movimento, da quando nasce a quando muore, il corpo funziona, in qualsiasi modo lo faccia.
Questa caratteristica dell’affetto calza a pennello con una caratteristica della macchina o meccanismo, ciò che funziona o non funziona, indifferentemente. La macchina fa quello che deve fare, ciò per cui è stata progettata, non sbaglia, non ha meriti, semplicemente funziona. Se è rotta non fa quello che deve fare e ancora una volta questo è il suo funzionamento corretto.
Allo stesso modo il desiderio, funziona, fin dalla nascita, taglia e cuce e schiaccia e urla e ricerca e allontana, apprende e disapprende, seguendo le sue leggi.
A differenza delle nostre macchine, la macchina che siamo noi però è una macchina di non indifferenza, è una macchina che prova e sente, che produce desiderando. É una macchina che lavora indifferentemente come produzione non-indifferente, produzione di gioia, produzione di desiderio.
L’umiliazione come macchina.
La cosa più simile al fato sono proprio i desideri, perché riproducono spirali di gioia o tristezza. Il fato è negativo per definizione, è fatale, poiché è privo di consapevolezza e di senso, il fato ha la tristezza della debolezza di senso per chi ne è macchina(5).
E tutti naturalmente incontriamo, nel corso della vita, i nostri momenti di fatalità.
La fatalità edipica di questa catena metamorfica che riproduce esattamente ciò che voleva evitare (“vedo il meglio e lo approvo ma seguo il peggio”) è legata alle dinamiche emotive della gioia. Ossia alla radice della produttività umana, al desiderio vissuto, che è sempre sforzo di incrementare la gioia.
La tristezza è il desiderio vissuto di gioia, quando esso si trova di fronte a degli ostacoli e la sua forza diminuisce, la tristezza rimane paradossalmente una forma di gioia, ossia di sforzo di superare gli ostacoli, di riprodurre la gioia. In questa riproduzione impotente si annida il senso circolare della fatalità.
Per sfuggire al ricordo di essere stati vittime ad esempio, diverremmo carnefici, riproducendo le condizioni che ci renderanno ancora una volta vittime. Le tristezze generano spesso delle fughe e fuggendo riproduciamo proprio ciò da cui fuggiamo, come fanno spesso i popoli esiliati o le fazioni offese, incapaci di accettare la loro condizione, ricercando un eden che non è mai esistito realmente, al quale sono costretti da passioni inculcate da generazioni, da parole di cui non sanno più il significato.
Quando non siamo capaci di accettare ciò che ci è successo, quando la tristezza non offre scampo, quando il mondo non offre rifugi, quando siamo attraversati da parole di cui non conosciamo il vero significato, la fatalità di queste fughe diviene una triste realtà, il desiderio ha prodotto, si è armato, si è rafforzato e ha speso tutte le sue energie per riprodurre ancora una volta la propria triste storia, il proprio fato.
Il desiderio non smette mai di funzionare, non rinuncia mai e se non ha scampo, fa sempre l’unica cosa che gli sembra possibile.
È triste vedere popoli e persone che riproducono il loro destino, la loro ferita di bambini, a spese di altri, ma soprattutto proprie. È una delle dinamiche umane che più ferisce il nostro mondo, perché innesca altre spirali, senza facili strade alternative.
La dinamica della vittima è fortissima, ovunque offese alla propria dignità, ovunque umiliazioni, ovunque gli amici si trasformano in nemici, gli affetti in odi, gli amori in pericoli. Solo la vittima si sente umiliata. L’umiliazione non è qualcosa che si può fare ad un’altra persona, non è soltanto una tristezza o una passività, è ciò che la vittima produce fuggendo.
Chi trasforma i dolori sofferti in umiliazione è pronto a diventare carnefice, prima di tutto di se stesso, è una persona che porta in sé la fatalità.
E ancora, è triste vedere quante persone e quanti popoli cerchino affetto e stima, amore e riconoscimento e riproducano invece la propria solitudine e umiliazione, spesso a spese di altri.
Queste produzioni di desiderio concrete influenzano la vita reale delle persone, delle nazioni, delle generazioni.
E se il desiderio produce tutto questo, è con lui che dobbiamo fare i conti, col desiderio concreto, reale, perché il desiderio non ha nulla di buono, né di cattivo, c’è, funziona e come macchina, fa quello che deve fare e basta.
Ciò che vuole l’umiliato semplicemente non esiste, non c’è mai stato nella realtà. L’umiliato lotta per un passato che non è mai esistito.
L’umiliato non può godere della realtà attuale, dunque non vede alcuna soluzione alternativa e fa l’unica cosa che può fare, funziona e basta, come macchina di tristezza.
Queste macchine hanno una sola speranza, perdere clamorosamente la propria battaglia, senza essere annientate ed avere l’opportunità di ripartire da una tristezza concreta, reale.
Le macchine di gioia
Le macchine che costruiscono spirali gioiose, riproducono per quanto possono sentimenti di gioia, desideri che aumentano di potenza, di consapevolezza, di capacità. Che caratteristiche hanno queste macchine?
La cosa forse più importante è che queste macchine sanno utilizzare la tristezza, ne hanno appreso in qualche modo la naturalità, hanno imparato a non trattarla come un “vizio di natura”, a non disprezzarla, fuggirla, deriderla né in se stessi, né negli altri. La tristezza, hanno appreso, è il loro desiderio stesso, quando esso viene ostacolato e diventa più debole, sforzo gioioso vissuto come tristezza, sofferenza e solitudine.
La tristezza è lo sforzo di aumentare la propria potenza di agire quando esso venga ostacolato, la tristezza è una risorsa, traccia un contorno, segnala un ostacolo, un limite, una discrepanza tra ciò che vogliamo e ciò che è. La tristezza è connaturata al nostro stato più della gioia, nel senso che la gioia richiede uno sforzo superiore e al limite un esercizio di lunga durata, un esercizio trattenuto nel corpo, scavato nelle sue emozioni con la ripetizione. La gioia è cosa difficile da rendere stabile e duratura, non è certo questa la nostra condizione iniziale, la gioia è una conquista sempre ardua, la tristezza invece rappresenta la condizione reale del nostro stato finito, infinitamente superato dalle altre cause in natura.
La frase di Ovidio, cara a Spinoza, non è realistica, “Vedo il meglio e lo approvo, ma seguo il peggio”, e di conseguenza la condizione di gioia non è affatto il suo contrario, non è “Vedo il meglio e lo approvo e perciò lo seguo”. Desidero stabilmente con gioia e utilizzo la tristezza senza fuggirla col disprezzo o la derisione.
Mi alleno per arrivare a questo risultato, con l’esercizio del mio corpo che desidera, mi alleno a rafforzare la gioia, a renderla stabile di fronte alle inevitabili tristezze portate dal mio stato. Per fare ciò occorre riconoscere il proprio stato finito, fare i conti con i limiti inevitabili e guardare se stessi e le cose dalla più alta prospettiva storica possibile, al limite, dice Spinoza, sotto una specie di eternità.
La nostra prospettiva non è affatto così ampia all’inizio, allargarla realmente, cioè nei sentimenti, richiede esercizio e ripetizione, affetto e non solo parole.
La gioia di cui si parla è quindi legata alla stabilità, alla comprensione, ossia alla capacità di dare senso, all’autonomia, ossia al potere reale del corpo. Tutte queste caratteristiche denotano una gioia, sempre esposta, sempre soggetta a transizioni negative, ma più potente, quella che, sempre al limite, Spinoza arriva a chiamare beatitudine.
Vedo il meglio e lo approvo ma seguo il peggio
Una produzione di significato basata quasi esclusivamente sulla parola e sul segno linguistico non è sufficiente, a ciò è legato forse ad uno degli aspetti peggiori manifestato dalle società occidentali e non solo, la promozione del mito di una macchina indifferente, ossia di una macchina senza passioni tristi, un’irreale macchina priva del limite tra volere e potere, tra vedere il meglio e approvarlo e avere la forza e il desiderio necessario per perseguirlo.
Le pratiche corporee legate al linguaggio sono solo alcune delle pratiche di senso che possiamo istituire, ve ne sono molte altre, tante quante sono le pratiche che può produrre un corpo, poiché ogni pratica corporea è una pratica di senso.
Enunciare un desiderio, come quello di seguire il meglio non significa avere la forza necessaria per seguirlo, per non arrendersi di fronte alle difficoltà, per non seguire altri desideri, la parola non basta, il suono che dischiude il senso non è mai sufficiente per il corpo, per quanto sia importante, esso è fragile.
La parola, lasciata da sola, è debole. La parola, soprattutto, enuncia intenti e precetti che non corrispondono affatto ai desideri reali e li trasforma in regole di vita prive di presupposti affettivi concreti. La parola, se la si ritiene libera e potente, finisce per portarci a disprezzare o anche solo a deridere la natura umana.
L’uomo non si libera né nelle parole, né nel pensiero, perché non è dalle idee che è oppresso in primo luogo. Ci si libera, per quanto sarebbe più onesto parlare di crescita più che di liberazione, solo con l’esercizio, con la pratica concreta e ripetuta, che coinvolge il corpo e le sue relazioni materiali, ossia i suoi desideri concreti nel mondo e nelle relazioni effettive in cui è coinvolto.
Si fantasticano libertà ideali per coprire l’oppressione quotidiana, le proprie relazioni impotenti e frustranti, le proprie incapacità affettive, nel mondo in cui realmente viviamo.
Con operazioni di cosmesi intellettuale copriamo i sentimenti più semplici e infantili, le nostre bizze e i nostri sensi di colpa, la nostra incapacità ad accettarli per quel che sono, ad accettare il limite che ci separa dall’ideale che ci eravamo posti per noi stessi di fronte agli altri.
Ma il saggio, ci dice Spinoza, sa affrontare le tristezze, riconoscendo in esse quella forza affettiva positiva che esse, come tutti i sentimenti, contengono, essendo sempre delle reazioni volte ad accrescere la propria potenza, le tristezze vanno seguite, non negate.
Seguire una tristezza significa non fuggirla, non negarla, non rimuoverla, ma farla lavorare, restandole vicino e non facendo di tutto per “cambiare sentimento”. I sentimenti, che sono la nostra natura, funzionano, non sono né buoni, né cattivi, non vanno mai negati o repressi, i sentimenti vanno ascoltati, perché essi conducono sempre a una qualche forma di gioia.
Ben poco merito, ben poca colpa
Questi sono alcuni degli esiti cui conduce la strada di lettura che abbiamo intrapreso nell’opera spinoziana, viaggiando appresso ai concetti macchina, meccanismo, corpo desiderante, uomo come affetto, tristezza come gioia, affetto come gioia intenta al proprio incremento, natura come piano di immanenza, macchina come indifferenza, significato come significatività, sentimenti come meccanismi di non-indifferenza, saggezza come riconoscimento della naturalità della tristezza e della gioia, ecc...
E se infine dovessimo indicare il punto in cui tutti questi sentieri giungono ad incontrarsi, o almeno uno dei punti di incontro che ci sta più a cuore, non avremmo dubbi ad indicarlo nel riconoscimento della naturalità dei nostri sentimenti.
“C’è ben poco merito nella virtù e ben poca colpa nell’errore, basta spostarsi nel tempo e nella storia per vedere i valori trasformarsi in disvalori e viceversa”.(6)
Questa è l’alternativa ai mille modi con i quali l’uomo nei secoli ha deriso e disprezzato la propria natura e quella degli altri uomini. Questa è la base di un materialismo reale, realmente ateo e realmente amoroso per sé e per gli altri. É la condizione minima per poter intraprendere un processo di crescita, che è l’unico senso reale, per l’uomo reale, della parola libertà.
In fondo, solo un modo un po’ più vicino alla nostra sensibilità di dire esattamente quello che Spinoza diceva nella seconda metà del 1600:
“La maggior parte di coloro che hanno scritto sugli affetti e sul modo di vivere degli uomini danno l’impressione di trattare non di cose naturali che seguiono le comuni leggi della natura, ma di cose che sono al di fuori della natura. Sembra anzi che concepiscano l’omo nella natura come un dominio all’interno di un dominio. Credono, infatti, che l’uomo turbi l’ordine della natura più che seguirlo e che abbia un potere assoluto sulle proprie azioni e che non sia determinato da altro che da se stesso. Attribuiscono, inoltre, la causa dell’impotenza e dell’incostanza umane non alla comune potenza della natura, ma a non so qual vizio della natura umana, che pertanto piangono, deridono, disprezzano o, il che avviene per lo più, detestano”.(7)
NOTE:
1. Spinoza B., Ethica more geometrico demonstrata, Roma 1988, Editori Riuniti.
2. Mille, in effetti, non appare più un numero così grande per definire l'uomo, ma ogni epoca ed ogni generazione avrà il suo ordine di grandezza per definire ciò che considera vasto, enorme e complesso da distendere nell'immanenza di un'unica superficie.
3. La tristezza di cui parla Spinoza nell'Ethica non va confusa con un sentimento particolare di malinconia o depressione. Spinoza intende la tristezza come uno dei due possibili stati dell'affettività umana, come la condizione emotiva che si genera quando il nostro desiderio incontra dei limiti di qualsiasi sorta e viene depotenziato nel suo sforzo di accrescere la gioia. In tal senso anche la tristezza rimane un desiderio, dunque uno sforzo di accrescere la gioia, ma lo fa cercando di allontanare, distruggere, eliminare o fuggire (sotto la forma di odio, rabbia, disprezzo, depressione, malinconia, ecc...) l'origine del depotenziamento, il limite che ha trovato dinanzi a sé. Al contrario, la gioia avvicina, protegge, mantiene, custodisce e si appropria del suo oggetto. Gioia e Tristezza non sono altro che due forme, solo apparentemente opposte, di un unico desiderio di accrescere la gioia e la propria potenza.
4. Niente di simile ad una liberazione improvvisa, imboccare questa via nella vita richiede invece tempo e grande fatica: “La via che ho mostrato […], pur se appare molto difficile, può tuttavia essere trovata. E d'altra parte deve essere difficile, ciò che si trova così raramente. Come potrebbe accadere, infatti, che, se la salvezza fosse a portata di mano e potesse essere trovata senza grande fatica, venisse trascurata quasi da tutti? Ma tutte le cose eccellenti sono tanto difficili quanto rare”. Spinoza B., Ethica. More geometrico demonstrata, V, Prop XLII, Schol.
5. Al fato, contrariamente al destino, non ci si può che adeguare, perché è una parola detta dall'alto, è una parola di cui non si conosce il significato e dunque non la si può contrastare, né forgiare.
6. Fabrizio De André, concerto al Teatro Brancaccio, 1998.
7. Spinoza B., Ethica more geometrico demonstrata, Praef. Terza Parte, Roma 1988, Editori Riuniti, p. 171.

