Paesaggi del cuore e della mente
dal 16/11/2007 al 30/12/2007
Segnalato da
Andrea Boyer
Massimo Catellani
Giancarlo Davoli
Riccardo Negri
Fulvio Rinaldi
Alberto Agazzani
16/11/2007
Paesaggi del cuore e della mente
Galleria Primo Stato, Reggio Emilia
Cinque pittori e cinque modi d'intendere il paesaggio. Opere di: Andrea Boyer, Massimo Catellani, Giancarlo Davoli, Riccardo Negri, Fulvio Rinaldi. A cura di Alberto Agazzani.
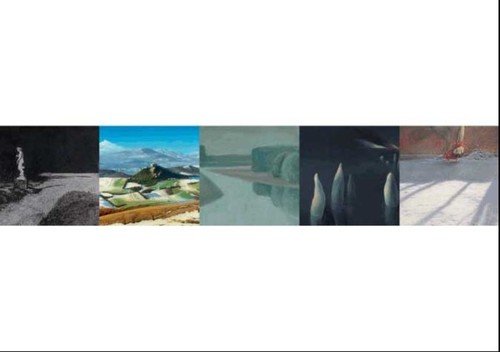
a cura di Alberto Agazzani
inque pittori, Cinque “generazioni” pittoriche, Cinque modi d’intendere il paesaggio. Cinque aspetti della figurazione contemporanea che riassumono un intero universo poetico, scelte rigorose in nome di un fare arte che non ha mai inteso né intende scendere a facili compromessi con alcuno degli escamotages di cui trabocca la nostra contemporaneità. L’arte in definitiva è fondamentalmente questo: un susseguirsi ininterrotto di forme e d’immagini che ci accompagnano dagli albori della nostra civiltà; emozioni, sentimenti, stati d’animo che acquistano forma e colore, sempre diversi, sempre diversamente uguali a loro stessi. Come uguale a se stesso è l’uomo. Ciò che cambia, si evolve (o a volte involve, almeno così ci appare nella vicinanza del presente), muta in continuazione è la nostra sensibilità, il nostro modo di vedere e percepire la realtà degli eventi e, di conseguenza, di rappresentarla. L’uomo è sempre lui, drammaticamente uguale a se stesso, con i suoi ancestrali vizi e le sue divine virtù. Non cambia, e la storia, così ciclica e così ricorrente, ce lo dimostra ad ogni capitolo. Chi cambia è l’artista, colui al quale è affidato il compito d’indagare il mondo con un occhio straordinario, con una sensibilità mobile e mai quieta, con una mano in grado di catturare e imprigionare in una pennellata di colore un’intera gamma sentimentale ed emozionale.
Nel novero della pittura cosiddetta di “genere”, desueta quanto felicemente reazionaria oggidì, il Paesaggio occupa un posto d’assoluto protagonista. Basti pensare alla moda (e come tale sfinita e sfinente nella sua monotona ripetitività) del cosiddetto “paesaggio urbano”, con la pletora di pittori e pittorucoli preoccupati solo di replicare ad nauseam il soggetto fortunato di turno. O a tutti coloro che hanno riposto in questa o quell’architettura industriale (e non) la “fortuna” di una pittura, chiamiamola così, senza fantasia, senza vita, senza emozione, ancora solo e sempre preoccupata di sé stessa, oltre che, ovviamente, del mercato. Decoratori senza testa e senza cuore, talenti mancati, bambini prodigio, forse, dei quali, nel migliore dei casi, non rimane più né l’uno né l’altro. E la lista sarebbe penosamente lunga.
Dall’altra parte della barricata, di contro, esistono i Pittori, coloro, cioè, che sono riusciti a far coincidere la loro vita con la loro arte, incuranti di tutto ciò che li allontana dal loro silenzioso (ma spesso assordante) mondo. Sono pittori per i quali non esistono riviste patinate, circoli esclusivi o palcoscenici scintillanti. Non esiste quel mondo, tanto falso quanto vacuo, semplicemente perché non interessa loro, consci come sono di quanto prezioso sia il loro “dono” e di quanto facile sia perderlo irrimediabilmente per le vie pericolose e perverse del successo e della fama. Anche qui l’elenco dei “dispersi” sarebbe lungo e penoso. (Sono lì, ancora davanti ai nostri occhi. Guardiamo, dei “dispersi”, i quadri di ieri e quelli di oggi. Guardiamo l’opera piena di entusiasmo, di speranza e di vita degli esordi e confrontiamola con gli insopportabili epigoni d’oggi, pieni di tutto, ma non di vita, non di espressività, non di Pittura. Oggetti commerciali, decorativi, insulsi nella loro triste ripetitività, vuota e vana. Ad ognuno di noi la prova fondamentale in foro coscientiae. E in quello del proprio occhio)
Già: coscienza. Ed etica, mi viene da aggiungere. Due ingredienti fondamentali nel fare arte, posti tra cervello e cuore, mi verrebbe da dire. Fare arte significa anche avere la coscienza della propria missione e del talento che è stato donato per adempiere a quello scopo. Il talento in pittura, si sa, è una qualità del tutto inutile se non è asservita ad un’espressività. Lo ricorda con grande saggezza il grande Alberto Sughi in un’intervista con l’altrettanto grande Sergio Zavoli: “Il talento è uno strumento prezioso per chi ha qualcosa da dire; è un dono naturale inutile, a volte dannoso, quando non diventa espressività, ma solo virtuosismo.”
Il paesaggio della memoria.
Giancarlo Davoli è un pittore di cui non si ha traccia. Schivo, silenzioso, timido, egli si avvicina alla pittura con la spontanea semplicità di chi non ha nulla da dimostrare se non la sua ricchezza e generosità d’animo. Davoli ha coltivato un’idea di pittura per tutta la vita, visitando i grandi musei, avvicinando i grandi capolavori della pittura di ogni tempo e luogo, studiando i grandi e piccoli maestri, dagli antichi ai contemporanei. Curioso e instancabile, mosso dal bisogno di conoscere e sapere. E finalmente del fare. Il suo approdo alla pittura è stato graduale, non una folgorazione giovanile. Piuttosto un bisogno della maturità, coltivato ed inseguito per tanti anni. La pittura di Davoli si caratterizza per un approccio formale di grande rigore, che riassume e condensa, attraverso una sensibilità acutissima, tutto quell’universo poetico e stilistico al quale si è sentito e si sente affine, quell’”eredità” che non dobbiamo, non possiamo dissipare”, per dirla ancora con le parole di Alberto Sughi. Ecco allora una pittura nella quale la realtà si trasfigura in luogo mentale ed emozionale: le forme si fanno colore e materia, ordinate secondo un’impaginazione mai casuale, anzi severa e a tratti “antica” nella scansione dei piani, nelle prospettive, nel susseguirsi degli elementi. Nessun naturalismo, dunque, bensì impressioni meditate. Emerge la lezione di tutto un Novecento dipinto: da Carrà a Sironi, da Bonnard a Morandi, da Balthus a Mattioli fino ai limiti dell’informale, il tutto illuminato dall’importante lezione di Carlo Bazzani, di cui Davoli è stato allievo, e di tutta quella gloriosa tradizione paesaggistica reggiana che trova in Remo Tamagnini e Gino Gandini due riferimenti, poetico e stilistici, ineludibili.
Il paesaggio del sentimento.
Pochi pittori conoscono come Fulvio Rinaldi il colore delle emozioni e dei ricordi. Nature morte, figure o, come in questo caso, paesaggi vengono creati con il silenzio e l’emozione di un antico maestro, aggiornando continuamente lo sguardo sull’anima segreta delle immagini e della realtà, senza indulgere mai alla decorazione o all’illustrazione, ma lasciando bisbigliare ombre e luci, oggetti, scorci, vedute. In Rinaldi il senso del tempo si ferma in una dimensione fuori da qualunque realismo, lontano da una figurazione compiaciuta o d’effetto. Non a caso tra i suoi riferimenti pittorici figurano Pietro Annigoni e Gianfranco Ferroni, diversi cantori della medesima inquietudine e degli stessi, segreti moti dell’anima. La sintesi fra i due maestri è compiuta da Rinaldi attraverso il colore e il magistrale gioco delle ombre. In Rinaldi tutto allude ad un tempo trascorso: nei suoi dipinti il soggetto è solo uno splendido pretesto per suonare corde emozionali intime e nascoste, mai un fine rappresentativo vero e proprio. Così i suoi paesaggi innevati, una costante della sua più felice produzione, si caricano di riflessi ed ombre tutte e solo mentali, ricordo di una stagione passata e futura, mai presente (l’ombrellone abbandonato e addormentato in pieno inverno aspetta nuovamente il risveglio estivo, al pari del campo appena innevato in attesa del gelo e della nuova primavera). Il tempo nei dipinti di Rinaldi è mobile, risultato di un divenire passato e futuro, mai solo presente. Così come cariche di melanconia e fascino sono i muri sbrecciati ed ammuffiti, quelle macchie di colore-non-colore al limite dell’informale (come in Cortile del 2004) che rimandano ad un abbandono in cui anche l’incuria e i segni del tempo acquistano vita, spessore, emozione. Pittura di sentimento e di vita, delle grandi e piccole emozioni rinchiuse in un piccolo pettirosso infreddolito, in un tronco d’albero segnato dal tempo e dalla storia o di una grande distesa innevata che si perde in un infinito leopardiano.
Il paesaggio ritrovato.
Romantico ricercatore di atmosfere e suggestioni ideali è Massimo Catellani. Anch’egli artigiano dei pennelli e dei colori, schivo e timido come oggi si confà quasi solo a chi dipinge col cuore oltre l’ostacolo. Catellani ha il dono dello stupore, come un vero pittore Romantico davanti all’immensità ed alla potenza della natura. Il respiro dei suoi paesaggi è tale da provocare un senso di quieta vertigine. Anche quando i suoi cieli appaiono carichi di tempesta o furiosi di lampi e tuoni (che non si sentono ma si vedono!), il senso di familiarità e di quieta tranquillità domestica è tale da fugare qualunque intento panico. Da romantico nel solco della grande tradizione italiana, di uno Sturm und Drang padano verrebbe da dire (Fontanesi docet), il pittore si è ultimamente mosso in una direzione più misteriosa, visionaria seppure ancora fortemente legato ad una quiete tutt’altro che inquietante. Le ombre esasperate, in certi casi magrittiane vien da pensare, così tipiche sulle colline e nelle pianure emiliane, diventano protagoniste minute e particolari, in dipinti dal grande respiro, che in virtù proprio di quelle felici invenzioni assurgono a spazi mentali di un tempo ritrovato, di un paesaggio mentale faticosamente cercato e finalmente ritrovato.
Il paesaggio della mente.
Pochi pittori (e disegnatori) italiani possono vantare un atteggiamento etico ed un rigore analitico e compositivo così magistrali come Andrea Boyer. La sua passione per la fotografia (intesa come scrittura della luce, mai solo come esercizio espressivo) ed il suo possesso in chiave tecnica di quello strumento gli hanno consentito di sviluppare un’idea di “pittura” che trova ben pochi emuli, sia sul piano concettuale che su quello più squisitamente tecnico. L’iperrealismo di Boyer, infatti, è sempre e solo apparente. “A che serve dipingere una fotografia quando esiste già come tale?” (si) domanda il pittore quando viene accusato d’essere eccessivamente realista. Ed a ragione, perché pochi come e quanto lui hanno amato, amano e conoscono quella nuova Musa, così prepotentemente protagonista, ineludibile, dell’arte del Novecento tutta e tutto. Ed è proprio dal possesso assoluto di quella tecnica e dalla padronanza delle sue potenzialità che nasce in Boyer il desiderio di sfidare il visibile oltre i suoi oggettivi confini. Ecco allora che il disegno e la pittura offrono al fotografo la via di fuga dai recinti del visibile, per proiettare quelle stesse immagini e quegli stessi soggetti in un universo solo e sempre mentale. Il chiaroscuro esasperato, con quell’inseguirsi dei bianchi e dei neri assoluti, dalle più accecanti luci alle ombre le più cupe, è lo strumento, più mentale che reale, per trasportare la realtà visibile in una dimensione nella quale il pensiero si fa forma, il tempo spazio. Misticismo? Neopositivismo? O addirittura una sorta di Neoilluminismo nell’epoca del più buio relativismo ad ogni costo? Di certo nella pittura di Boyer di relativo rimane ben poco. Il pittore, con la sua poetica e con le sue scelte formali, afferma solo e sempre una strada univoca: nessuno spazio al relativismo qualunquista e disperato. Da qui una grande lezione di etica e coerenza, virtù che gli consentono quella libertà totale ed assoluta che solo un grande artista può permettersi di negare. Ogni scelta di Boyer è frutto di una virtù, mai di una necessità. Il fatto stesso di dedicarsi da decenni ad una pittura monocromatica è scelta lucida e ragionata, una rinuncia consapevole, al pari di quella del barone di Charlus proustiano, di cui dice il Narratore: “Guardando un po’ meglio, ci si accorgeva che se il colore era quasi completamente assente dai suoi vestiti, non era perché chi l’aveva bandito lo trascurasse, ma piuttosto perchè, per una ragione o per un’altra, se lo proibiva. E la sobrietà c’essi documentavano pareva scaturire, più che da una mancanza di golosità, dall’obbedienza ad una dieta…”
Il paesaggio del sogno
Mantova, meraviglioso non-luogo (al pari della vicina Ferrara) sospeso fra le nebbie e le afe di una Padania più mentale che geografica. Mantova e i Gonzaga, con la loro corte, con Giulio Romano e Claudio Monteverdi, con Andrea Mantenga e Leon Battista Alberti, con le sue tradizioni fieramente ferme al Rinascimento, quasi quel “momento” non dovesse mai finire. Mantova come luogo del sogno e dell’invenzione, dunque. Dei sensi, tutti. (Non è un caso se Piave e Verdi, dovendo rimaneggiare l’originario Le Roi s’amuse di Hugo per ricavarne il libretto di Rigoletto, spostarono l’originale ambientazione parigina presso la corte di Francesco I a quella del duca di Mantova Vincenzo Gonzaga, famoso libertino, celebrato buongustaio e protettore, per l’appunto, di Monteverdi e Tiziano. Quando si dice eclettismo dei sensi ed amore del bello…) Un sogno infinito, ancora, lontano dalle miserie della contemporaneità dalle sue brutture generatrici d’ansia e di inquietudine senza poesia. Mantova è la terra, fra gli altri e non a caso, di Lanfranco, certamente fra i più grandi pittori surrealisti italiani ed europei, ancorché segreto, misterioso, aristocraticamente rinchiuso nei confini di quella terra sconfinata. E mantovano è il giovanissimo Riccardo Negri, pittore visionario qui al suo debutto espositivo. Negri è figlio della sua terra. Antico e contemporaneo, persegue un’idea di bellezza e poesia che poco o nulla ha a che fare col nostro tempo, anche se nei suoi piccoli e preziosi dipinti si fà espressione di una sensibilità quanto mai giovane e moderna. Negri è il pittore di paesaggi sognati e sognanti, forieri di una metafisica gonzaghesca che solo nella sua irrealtà atemporale allude all’originale estense del Cossa e del Dè Roberti, con paesaggim rocce e speroni fluttuanti nel nulla, emergenti da un mare/cielo senza apparenti confini né colore. E’ il mistero di un mondo irreale, lontano da qualunque geografia possibile, da qualunque realtà, da qualunque dimensione spazio-temporale. E’ una poesia che da Borso d’Este arriva a noi attraverso i Gonzaga, de Chirico, Wainer Vaccari ed Edi Brancolini (magnifici visionari ancora estensi), Spielberg e Greenaway, a significare una continuità non solo del talento e dell’arte, ma di un’idea di sogno che solo la pittura può rinnovare e rigenerare. Anche e soprattutto attraverso gli occhi giovani e la mano forte di un pittore-ragazzo dalla fede indomita.
Galleria Primo Stato
via dei Due Gobbi, 5 - Reggio Emilia
orario: 9-12.30 16-19 chiuso festivi, mart e giov pomeriggio
Ingresso libero



