L'edicola digitale delle riviste italiane di arte e cultura contemporanea
Around photography (2004-2009) Anno 2 Numero 5 aprile-maggio 2005
The Fuccons
Marco Senaldi
L'arte dopo la tv
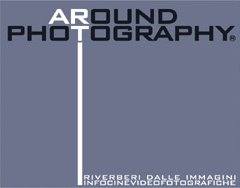
riverberi dalle immagini infocinevideofotografiche
Marcello Galvani
Roberto Maggiori
n. 14 novembre 2008 - aprile 2009
Talking about Biennals
Elvira Vannini
n. 13 maggio-ottobre 2008
The Demanded Cave
Anna Lovecchio
n. 12 novembre 07- aprile 2008
Fake Movement
Clara Carpanini
n. 11 marzo-giugno 2007
Tachiguishi Retsuden
Francesco Di Chiara
n. 10 novembre - febbraio 2006
La fotografia entropica di Robert Smithson
Pier Francesco Frillici
n. 9 Maggio - Settembre



E' molto istruttivo leggere le reazioni dei telespettatori alla serie The Fuccons, in onda da gennaio su Mtv; molti sono inorriditi dalla risata "urticante" dei protagonisti, taluni sono completamente sedotti, altri lo trovano demenziale, noioso, incomprensibile - un tizio arriva a dire che The Fuccons è come un dolce di cui non si capisce bene il sapore: "non capisco se mi piace o no, ma non riesco a smettere di mangiarlo". Comunque, nonostante The Fuccons faccia discutere molto e addirittura litigare in rete nessuno che l'abbia visto riesce a restare davvero indifferente.
Il motivo di tanto dibattito è evidente per chiunque sia incappato in questo bizzarro prodotto televisivo davvero indefinibile, a metà tra il cartone animato, la sit com e l'installazione. In effetti si tratta di piccoli episodi molto brevi (3 minuti l'uno) i cui protagonisti sono i componenti di una famiglia americana "supertipo" appena trasferita in Giappone - solo che questi personaggi, anziché essere interpretati da attori in carne e ossa, sono dei manichini.
Basta guaradre qualche frame di The Fuccons per capire che l'impiego dei manichini va molto al di là di quello che ci si potrebbe aspettare. In effetti i manichini qui, anche formalmente parlando, sono dei veri protagonisti: anche se logicamente sono sempre immobili e hanno sempre la stessa espressione, sopperiscono alle loro mancanze attoriali con molte altre armi: acconciature, abiti, ambientazioni e naturalmente dialoghi, riescono a reggere una narrazione altrimenti votata all'impossibile.
Ora, dal punto di vista formale, l'idea di impiegare dei manichini al posto di attori in carne e ossa è straordinariamente televisiva, per semplicità e linearità - ma chiaramente non deriva dal linguaggio televisivo, né da quello cinematografico o teatrale - e come potrebbe? Le reazioni degli spettatori di Mtv sono dunque corrette: il misto di attrazione e repulsione che The Fuccons suscita non appartiene al regime estetico televisivo, benché, al tempo stesso, ne porti certe oscure premesse alle estreme conseguenze. Persino all'occhio parzialmente ingenuo dello spettatore (immagino giovane) di Mtv non sfugge questa ascendenza - solo che, grossolanamente, viene riferita alla pop art: "Andy Warhol - scrive uno agli autori - ne sarebbe stato entusiasta!". Sì, è probabile, ma forse sarebbe anche scoppiato dall'invidia (un sentimento che conosceva assai bene) riconoscendo in quell'iconografia elementi non suoi. E' infatti nell'arte contemporanea che The Fuccons trovano la loro origine, ma certo non nella pop art. Benché Warhol fosse stato in gioventù un vetrinista per un negozio di grande importanza come Bonwit Teller di New York, addobbando con i suoi primi quadri (nel 1957) le quinte dietro i manichini vestiti, né lui né la pop art hanno mai veramente apprezzato la poetica peculiare del manichino. E questo per almeno due buoni motivi: il primo è che la pop art è sempre stata interessata più ai segni che agli uomini, più agli oggetti che ai soggetti; e il secondo è che anche quando inserisce elementi umani nella rappresentazione lo fa secondo le leggi dell'icona: questo è evidente sempre, se solo si pensa a Lichtenstein o a Rosenquist, ma lo è ancor di più se si pensa a Segal: le sculture di quest'ultimo infatti sono apertamente dei calchi, letteralmente delle ombre umane, immagini di individui - cioè l'opposto del manichino che ne è la contraffazione.
Ciò che infatti caratterizza il "manichino" come tale è un tratto che lo oppone al calco: la somiglianza all'umano ottenuta per differenza, l'eterno effetto-automa o effetto-bambola, in una parola, il carattere apertamente feticista del manichino. Tuttavia, benché la contraffazione artificiale dell'uomo sia un sogno che ha stregato generazioni di scrittori fin dall'antichità, è solo dagli ultimi decenni del XIX secolo che fa la sua comparsa - come supporto per capi di moda da esporre nelle vetrine dei negozi - il moderno manichino "industriale". In altre parole, il manichino come feticcio moderno è il sintomo che svela perfettamente il carattere feticista (individuato da Marx) di tutte le merci; d'altra parte il feticismo si rivela una componente essenziale dell'economia libidinale secondo Freud. Solo il surrealismo, in quanto avanguardia artistica che univa critica politica e attenzione ai processi inconsci, poteva cogliere appieno il significato del manichino: nelle opere di De Chirico, o in foto come quelle di Hans Bellmer, o dello stesso Breton per esempio, o in scene semidimenticate di capolavori come Estasi di un delitto di Bunuel (in cui il protagonista veste un manichino esattamente come la sua amata e glielo presenta), si coglie tutto il senso dell'inquietante paradosso di un essere somigliante all'uomo ma congelato in una fissità totalmente disumana.
Questo paradosso attraversa epoche e tendenze per tornare a riproporsi con l'iperrealismo - la più ingiustamente trascurata delle neoavanguardie. Le sculture di Duane Hanson o di John De Andrea sono chiaramente l'evoluzione esasperata dello stesso punto di partenza. Qui il paradosso si fa illusione estrema di verosimiglianza - ma proprio nella vicinanza estrema si annida l'estrema lontananza. A paragone della critica sovversiva dell'iperrealismo, la sofisticata ricerca simbolica della pop art pare quasi decadente. Non è un caso che la maggior parte dell'arte di tendenza degli anni '90 recuperi proprio la poetica iperrealista: dallo stesso Koons ai fratelli Chapman, da Ron Mueck a Paul McCarthy, da Cattelan a Charles Ray, la presenza del manichino iperrealista diventa un elemento espressivo centrale.
E' in questo ambito che The Fuccons va a recuperare le sue origini. E non a caso. L'autore, Yoshimasa Ishibashi ha infatti una preparazione artistica e multimediale, ed in patria i suoi film e le sue produzioni tv hanno ottenuto molta attenzione. Ishibashi è inoltre leader di un gruppo creativo, i Kyupi Kyupi, che realizzano performance musicali e spettacolari, con costumi postsurrealisti, ed hanno tenuto una notevole session al Palais de Tokyo nel 2003. Insomma, qui siamo di fronte ad un recupero completamente consapevole di certi stilemi e di certe atmosfere. Il richiamo a Charles Ray soprattutto mi pare particolarmente evidente: in genere le luci nette, fotografiche, gli abiti in una moda di una classicità senza tempo vagamente retrò, come le acconciature, la fissità degli sguardi, la mobilità delle foglie (nelle scene in esterni), i dettagli degli interni abilmente ricostruiti, creano una sensazione straniante "à la Ray" replicata per esempio dall'uso di manichini uguali nell'episodio particolarmente significativo de I gemelli. L'estetica di The Fuccons, d'altra parte, porta all'esasperazione gli elementi di artifizio già insiti nella tv delle soap e delle sit-com. Gli interni falsati, le luci artificiali anche in esterno, e soprattutto la non corrispondenza della voce alla mimica facciale (qui chiaramente inesistente) costruiscono qui una atmosfera di distorsione fra piani del reale, che tuttavia è già insita in questi prodotti televisivi. Non a caso The Fuccons utilizza il classico espediente delle risate preregistrate - le risate che il pubblico trova urticanti - perché si tratta di un tipico accorgimento che dovrebbe servire al coinvolgimento passivo del pubblico (la sensazione che, comunque, "qualcuno ride per me, si diverte per me, anche se io non mi diverto affatto"), che tuttavia ormai si è letteralmente logorato e funziona a rovescio, spandendo una patina di incredibilità sulla vicenda narrata. Anni di film gialli, noir e splatter in cui l'innocente viene assassinato mentre in tv va una sit com con tanto di risate preregistrate ci hanno ormai insegnato il valore straniante di questo sottofondo. The Fuccons ribalta il ribaltamento: l'apparente "normalità" drammaturgica perseguita assurdamente dalle sit com si rovescia qui completamente in un'assurdità quasi "normalizzata". Qui sta il motivo dell'ambigua sensazione che proviamo di fronte a questo geniale prodotto. E le trame stesse degli episodi non fanno che confermare il latente disagio; quasi sempre si tratta di storie a loop che letteralmente si avvolgono su se stesse, come quando James, il papà Fuccon, propone di votare l'esclusione di un membro della famiglia a scelta tra mamma Barbara e figlio Mike e ciascuno alla fine viene eliminato, o quando la famiglia si reca a fare un pic nic per poi scoprire che è la cosa che tutti odiano di più fare è esattamente un pic nic? E' proprio questa ipnotica reversibilità che ci rivela il lato post-beckettiano delle nostre esistenze - e che fa di The Fuccons uno dei migliori commenti alla celebre frase di Jean Baudrillard secondo cui, dall'avvento dell'epoca televisiva, "siamo diventati tutti dei ready-made".
Marco Senaldi


