L'edicola digitale delle riviste italiane di arte e cultura contemporanea
Ipso Facto (1999 - 2000) Anno 2 Numero 6 Gennaio-Aprile 2000
Le ombre di Warhol
Victor I. Stoichita
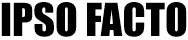
Rivista d'arte contemporanea
Editoriale
E.G.
n. 8 Settembre-Dicembre 2000
Editoriale
E.G.
n. 7 Aprile-Agosto 2000
Compresenza e disponibilità
Nicolas Bourriaud
n. 6 Gennaio-Aprile 2000
Editoriale
E.G.
n. 6 Gennaio-Aprile 2000
Rapporti schermo
Nicolas Bourriaud
n. 5 Settembre - Dicembre 1999
Plight di Joseph Beuys
Marion Hohlfeldt
n. 5 Settembre - Dicembre 1999

È nel 1979, alla Heiner Friedrich Gallery di New York, che Warhol espose una serie di sessantasei tele create un anno prima e recanti il titolo comune di “Shadows”. Sulla parete bianca, appena sopraelevate rispetto al pavimento, quel tanto per sottolineare la loro posizione a un livello diverso da quello dello spettatore, le tele, sprovviste di cornici, si succedono una accanto all’altra, una dopo l’altra, in un ritmo serrato e che segue un tragitto che si chiuderà esattamente dove era cominciato. Questo fregio continuo e circolare è tuttavia fatto di quelle che chiameremo delle “unità” indipendenti, il ricorso al termine tradizionale “quadro” per indicare queste tele non essendo legittimato né dalla loro forma né dal loro contenuto né dal loro contesto espositivo. Ma la cosa più importante consiste senza dubbio nel fatto che un’unità isolata dalla serie – un’unità acquistata separatamente e esposta indipendentemente – perde, in linea di principio, qualsiasi validità. Si tratta dunque tutt’al più di “tele” nel senso tecnico del termine, ma è senza dubbio significativo che, su questo supporto (lo stesso che la tradizione del “quadro” ci ha lasciato in eredità(1)), la rappresentazione sia stata effettuata con l’aiuto della serigrafia e dei polimeri sintetici, che permette, cosa molto rara, di accordare all’intervento diretto della mano un processo di stampa di origine fotografica. Questa serie, com’è noto, fu eseguita da Warhol e dai suoi assistenti a partire da fotografie riproducenti il gioco delle ombre portate di diverse figure di cartapesta fabbricate ad hoc. L’applicazione, alla fine, del colore sintetico dà alle “Shadows” una varietà e un ritmo che non possedevano originariamente.
Piuttosto che avanzare subito un’interpretazione del percorso di Warhol, penso istruttivo soffermarsi brevemente su una scorsa della ricezione critica della serie(2). Questa incursione preliminare all’atto ermeneutico è necessaria nella misura in cui ci si trova di fronte a un fenomeno completo che si potrebbe qualificare come “arte di esposizione”(3), il quale si lascia unicamente definire, da un lato, nel contesto espositivo come tale, dall’altro in quello della reazione critica immediata. Tolta da questo contesto, una “tela” di Warhol perde la sua ragione d’essere, si sfilaccia irrimediabilmente. Vediamo dunque in che modo, nel 1979, i critici più notevoli commentarono le ombre di Warhol. In “Art News”, per esempio Jane Bell faceva la notazione seguente: “Le ombre sono state serigrafate su un fondo dipinto che nega la superficie liscia e fredda che abitualmente viene associata alla Pop Art. La mano è presente ovunque in questa pittura, una mano generosamente sensuale che è senza dubbio quella di Warhol, anche se l’artista ha accettato, come sempre, l’aiuto accordato dai suoi amici della Factory”. Questa osservazione è interessante, soprattutto se si considera il carattere “autografo”, strano e paradossale che i grandi colpi di pennello conferiscono all’opera sotto un duplice registro: quello del titolo – “Shadows” – e quello della tradizione, in via di sparizione, del “quadro”. Procedendo a una doppia ermeneutica (che il critico di “Art News” fa solo affiorare), si giungerà alla conclusione che le serigrafie warholiane si situano al termine di una problematica fondamentale della rappresentazione occidentale, che è possibile illustrare con tutta una serie di esempi. Ne considererò solo due che, per la loro antichità, assumono nel quadro di questa problematica un valore per così dire inaugurale – tanto quanto l’esperienza warholiana ne segna la conclusione.
Il primo di questi esempi è un quadro di Maarten van Heemskerk, del 1553 circa. Rappresenta la realizzazione di un’immagine tradizionale (qui un ritratto della Vergine) per mezzo di una messa in scena estremamente complessa, al centro della quale appare sull’icona appena abbozzata, in un motivo paradossale, l’ombra portata della mano del pittore al lavoro.
Il secondo esempio è preso dal “Libro d’arte”, libro che illustra la tecnica pittorica del pre-Rinascimento, e in cui l’autore, Cennino Cennini, dà una lezione di disegno a un apprendista immaginario: “Prendi uno stile d’argento o d’ottone o di ciò si sia... Poi con essempio comincia a ritrarre cose agevoli quanto più si può, per usare la mano, e collo stile su per la tavoletta leggermente, che appena possi vedere quello che prima incominci a fare, crescendo i tuo’ tratti a poco a poco, più volte ritornando per fare l’ombre: nelle stremità vuoi fare più scure, tanto vi torna più volte; e così, per lo contrario, in su e’ rilievi tornavi poche volte. E ’l timone e la guida di questo potere vedere si è la luce del sole, la luce dell’occhio tuo, e la man tua; ché senza queste tre cose nulla non si può fare con ragione”(4).
A fronte di questi due esempi che chiariscono il tempo delle origini, si osserverà che nelle “Shadows” l’“ombre au tableau”(5) in quanto pura traccia, segno della presenza dell’artista, assume un’importanza immensa; invade e definisce la rappresentazione nella sua integralità.
Continuando la nostra carrellata delle recensioni, si noterà che un altro critico, Thomas McGonigle, su “Arts”, ritiene che Warhol “crei un terribile dilemma per lo spettatore” [creates a terrible dilemma for the viewer of this paintings]; tuttavia inclina a vedere nella serie una confessione autobiografica che mira a rivelare sotto forma di ombra la marginalità caratteristica dell’artista. Nella stessa rivista il critico Valentin Tatransky torna qualche tempo dopo sull’esposizione e, cosa significativa, propone una lettura che riunisce le due osservazioni anteriori. Tutta la serie sfocerebbe in un autoritratto astratto, che si manifesterebbe come tale soprattutto attraverso le immense tracce di pennello, e che attesterebbe l’autografia in un mondo dominato dalla ripetizione meccanica. Questa interpretazione è senza dubbio suggestiva, a dispetto del fatto che tralascia qualsiasi sforzo di concettualizzazione storica. La stessa lacuna appare in Carrie Rickey in una recensione complessa per “Artforum”, che va citata in extenso: “Sessantasei grandi tele [190 x 125 cm] sono esposte una accanto all’altra, riempiendo l’intera galleria. Spessi strati di colore acrilico fanno brillare le superfici, e dall’accumulazione di pittura sembrano staccarsi due configurazioni. Il comunicato stampa di Warhol assicura che tutte le sue tele rappresentano la stessa immagine: se da parte mia ne vedo due, sarà perché c’è una versione positiva e una negativa della stessa? Una assomiglia a una fiamma – la fiamma di un accendino o di una lampada a gas. L’altra a un vuoto. Ma questa speculazione è speciosa, perché le immagini sono evidentemente non figurative. E tuttavia c’è qualcosa dell’inchiesta di ‘Blow up’ in questa esposizione: ogni tela assomiglia a una fotografia ingrandita di qualche avvenimento riprovevole. Il riferimento a ‘Blow up’ di Antonioni è giustificato a doppio titolo, perché la disposizione delle immagini suggerisce che dovrebbero essere lette in successione, come dei fotogrammi. Esaminando i colori delle tele, in senso orario, alla ricerca di un filo narrativo, mi rendo conto che i colori acidi delle sessanta prime sono sostituite da colori argentati, dal bianco e nero, nelle ultime sei. Si tratta di una dissolvenza? Cosa devo capire da tutto questo? Warhol mi obbliga a giocare al detective. Sono ossessionato dal bisogno di trovare delle prove. Il lavoro del critico è un lavoro poliziesco, ed eccomi ora nell’ufficio delle impronte digitali”(6).
È sorprendente constatare che la maggior parte dei critici, a dispetto delle loro letture divergenti, insiste sul carattere enigmatico delle “Shadows”. Si rimane stupiti del fatto che alcuni di loro non si sforza di integrare l’esperienza di Warhol in un contesto storico, se non, forse, Rickey, con il rimando (discutibile ma interessante) al film di Antonioni. Tutti si attengono, nella linea retta dell’estetica warholiana, alla scorza del fenomeno, contemplandola attraverso il carattere enigmatico, senza immaginare un istante che il problema dell’enigma (se enigma c’è) possa essere quello della traduzione di uno spessore storico in superficie di esposizione. Giochiamo dunque a nostra volta al detective, ma entrando – quanto ci è permesso – nella pelle di un detective dotato di un po’ di senso storico. Incontriamo subito una fotografia che svela una buona parte dell’enigma. È del 1974 ed è stata presa a New York da Gianfranco Gorgoni e mostra Warhol e Giorgio De Chirico in una serata mondana. Il vecchio maestro della Pittura metafisica, bicchiere in mano e la traccia di un sorriso sospesa sulle labbra, guarda in macchina, mentre Warhol, (l’ancora) giovane maestro della Pop Art, distrae lo sguardo in un movimento di torsione della testa che dà al suo viso un’espressione di una forte intensità drammatica. La foto è sicuramente un’istantanea ma possiede la forza di un oracolo. È l’illuminazione della scena a drammatizzare questa fotografia, al punto che ci si può chiedere se non si tratti di un’istantanea manipolata. In ogni caso, a causa di questa illuminazione straordinaria, quello che non sarebbe stato che un semplice documento di un incontro mondano diventa l’immagine di un passaggio di poteri(7): nella casualità della posa, De Chirico trasmette a Warhol il suo mondo d’ombra e lo prega di diventarne il maestro.
Quattro anni passarono prima che Warhol potesse, nel 1978, esorcizzare in sessantasei varianti un unico incubo. Considerata in questa prospettiva, la serie delle “Shadows”, piuttosto che suggellare un mistero, lo svela come riconoscimento pubblico insieme di un debito e di un assassinio. In effetti, cronologicamente, la creazione di “Shadows” segue da vicino la morte di De Chirico – che sopravviene il 19 novembre; nel dicembre dello stesso anno Warhol iniziava la sua serie – ed è strano che la coincidenza sia passata inosservata. Non credo di forzare troppo considerando che la genesi delle “Shadows” sia la conseguenza diretta della sparizione di uno degli ultimi rappresentanti dell’avanguardia storica. L’esposizione equivale dunque al riconoscimento di un debito verso De Chirico. Se ha così a che vedere con un assassinio, esso è di natura simbolica e ha a che fare con la nozione di originale. Warhol fa succedere alle storie di ombre del maestro italiano delle ombre senza storia, e la loro serialità non è che il riflesso della sparizione irrevocabile del racconto pittorico e della sua sostituzione con la diffrazione infinita e l’infinito passaggio delle apparenze.
Questa lettura assomiglia a un’allegoria, ne sono consapevole. Lo è forse, ma nel senso di una “allegoria reale”. Quello che Warhol tace nel 1979 a New York, quello che nessun critico (a mia conoscenza) riesce a vedere in filigrana dell’esposizione delle “Shadows”, l’esposizione “Warhol verso De Chirico” lo aggiorna tre anni dopo, a Roma. Questa volta il programma è chiaro. Si tratta della serializzazione della pittura metafisica, della sua desacralizzazione attraverso la riproduzione e moltiplicazione.
In un’intervista con Achille Bonito Oliva, pubblicata nel catalogo dell’esposizione, Warhol spiega a posteriori il suo debito nei confronti di Giorgio De Chirico: “Ho sempre amato molto i suoi lavori. Mi piace la sua arte e poi quell’idea di ripetere sempre e sempre gli stessi dipinti. Mi pare molto quest’idea, e ho pensato che sarebbe magnifico farlo. […] De Chirico ha ripetuto le stesse immagini per tutta la vita. Credo che l’abbia fatto non soltanto perché i collezionisti e i mercanti d’arte glielo chiedevano, ma perché gli andava di farlo e considerava la ripetizione un mezzo per esprimersi. Probabilmente è questo che abbiamo in comune… La differenza? Quello che lui ripeteva regolarmente anno dopo anno, io lo ripeto lo stesso giorno nello stesso dipinto […]. È un modo per esprimere se stesso!... Tutte le mie immagini sono la stessa cosa… ma sono anche molto diverse... Cambiano con la luce dei colori, col momento e l’umore… La vita non è forse una serie di immagini che cambiano mentre si ripetono?”(8).
Invece che riconoscere semplicemente l’essenziale di quanto deve a De Chirico, ovvero il trasferimento delle ombre e degli enigmi, Warhol confessa un debito ancora più grande verso il maestro poiché gli attribuisce la paternità del pensiero stesso della ripetizione incessante, e dunque dell’intuizione della serialità come modo di espressione. Ora, questo pensiero non appartiene a De Chirico, è molto più antico. Questa incongruità non dovrebbe inquietarci troppo nella misura in cui, a credere alla sua solita battuta, Warhol non ama affatto dire la verità sulle sue opere e si sforza nelle sue dichiarazioni di imbrogliare le piste piuttosto che di chiarirle. La demarcazione che Warhol tiene comunque a introdurre, nell’intervista con Bonito Oliva, è importante perché oppone la contiguità dello stesso – fondamentale in Warhol – al ritorno dello stesso che caratterizza la pittura metafisica. Approfondiamo questa differenza.
De Chirico non ha mai nascosto il suo debito nei confronti del pensiero nicciano; al contrario, l’ha sottolineato in un modo che rischia il paradosso: “Sono l’unico uomo che ha capito Nietzsche – tutte le mie opere lo dimostrano”(9). E ancora: “Ricordo che spesso, leggendo l’immortale opera di Nietzsche ‘Così parlò Zarathustra’, certi passaggi mi lasciavano un’impressione che avevo già provato in gioventù alla lettura del libro italiano per i bambini intitolato ‘Pinocchio’. Strana somiglianza che rivela la profondità dell’opera!”(10).
Riguardo queste due confidenze ci si può giustamente chiedere in che cosa consistesse veramente la comprensione di cui si vantava il pittore. C’è una sola risposta possibile: se qualcosa avvicina “Così parlò Zarathustra” a “Pinocchio” è il dibattito intorno ai doppi dell’essere, l’interrogazione delle forme di esistenza inautentiche, la creazione di enigmi incessanti intorno alla libertà e al modo di viverla. Se De Chirico prende qualcosa da “Pinocchio” è l’ossessione del burattino, del doppio inautentico che usurpa il posto dell’uomo, e la tensione che ne risulta in vista di un superamento sempre in stato di attesa e mai realizzato. Ciò che De Chirico prende da Nietzsche è il suo pensiero più importante, quello della ciclicità assoluta e indefinitamente ripetuta di tutte le cose(11).
In quello che Warhol prende da De Chirico c’è un po’ di Nietzsche e molto di Pinocchio, nel senso che l’eterno ritorno dello stesso diventa in lui la contiguità infinita dello stesso sotto la forma di concatenazione indeterminata di icone decadute (Marylin, Jackie, la scatola di minestra...). O, per dirla con Gilles Deleuze, sotto il modo dell’emergenza vertiginosa dei simulacri, le cui forze, un tempo soffocate dalla tradizione platonica dell’Occidente, si liberano ora con violenza(12). Tutto questo trova nelle “Shadows” un’ultima espressione che partecipa ancora dell’antica forma del “quadro” e si rifà all’antica metafisica della “pittura”. Ogni tela è il riflesso di un’ombra, ogni “originale” è (già) una riproduzione; le tele riflettono il mondo, e il mondo stesso è la duplicazione di uno schermo infinito.
Sotto questo riguardo si può dire che, in occasione dell’inaugurazione di “Shadows” nella primavera del 1979, la galleria della SoHo newyorchese si trasformò per qualche ora – ma nel mondo di Warhol il transitorio è l’eterno – insieme in ventre di Leviatano, quello che inghiottì Pinocchio e le sue interminabili bugie, e in caverna platonica, fiera (lo spazio di una sera soltanto) delle proprie ombre.
Ma questa favola ha una seconda parte. Nel 1978, anno della creazione delle “Shadows”, Warhol esegue anche un suo autoritratto. Non era la prima volta, ma l’artista non aveva ancora mai sfruttato in modo così intensivo le modalità espressive del negativo fotografico. Moltiplicazione e rovesciamento, ecco i temi di cui Warhol parla ormai. La tecnica è quella utilizzata nella grande serie delle “Shadows” – serigrafia su polimeri sintetici applicati su tela. Conviene menzionare quest’opera non solo perché coincide (in modo per niente gratuito) con quella serie, ma anche a causa dei significati che derivano da un’“iconologia del materiale”(13), troppo spesso dimenticata dai commentatori. Tenendo conto di tutti i dati tecnici della rappresentazione e del loro investimento simbolico, si dirà che l’autoritratto non rappresenta soltanto l’immagine in negativo e moltiplicata di Andy Warhol ma anche la sua immagine polimerizzata.
Un polimero è (lo ricordo con l’aiuto del dizionario) una molecola la cui massa molecolare è multipla di quella di un’altra, detta monomero. La polimerizzazione è l’unione di diverse molecole di un composto per fornire una grossa molecola. L’operazione genera il materiale feticcio del XX secolo comunemente denominata materia plastica. Dagli anni ’60 Warhol utilizza in due modi quello che propongo di chiamare “polimerizzazione dell’immagine”: dapprima concretamente, procedendo alla plastificazione tecnica della rappresentazione-simulacro e infine simbolicamente, conferendo un’unità liscia, artificiale, indistruttibile al multiplo della vita. Nel suo “Autoritratto” del 1978 porta al culmine questa alleanza della forma e della tecnica della rappresentazione. Si tratta di un’immagine fondata sul doppio gioco del negativo fotografico. Come sempre il negativo rappresenta l’oggetto allo stato fantomatico. Warhol vi si rappresenta in due gruppi di tre immagini ognuno. Ogni gruppo lo riporta in tre vedute diverse: di tre quarti, di semiprofilo e di profilo. La lezione sembra chiara: l’uno è multiplo, lo stesso è diverso, la rappresentazione è il negativo della persona(14). La nozione di ombra appare qui solo in filigrana, ma in un modo comunque insistente. Si fonda su uno degli aspetti dell’immagine pubblica di Warhol, già entrata nell’immaginario collettivo e su cui egli stesso si è espresso in diverse occasioni: i suoi capelli (quasi) bianchi(15). Questa sua caratteristica fisica (ma per Warhol l’“esterno” è la persona) ricopre qui un significato importante poiché questo autoritratto lo rappresenta, nel momento in cui festeggiava segretamente il suo cinquantesimo anniversario, come un “bambino vecchio” ovvero come un “vecchio giovane”, conferendogli l’aura mitica di un puer senex, di un “genio” (nel senso primo del termine) infantile e matusalemme insieme. Ora, il rovesciamento operato dal negativo non è sufficientemente forte da rendere neri i suoi mitici capelli bianchi – il che fa vacillare il concetto di rappresentazione in negativo. Insomma, piuttosto che il suo negativo, il triplo spettro nero dai capelli bianchi rappresenta l’ombra triplicata del bambino-vecchio del secolo.
Il passaggio al contrasto rosso-nero, nella seconda terzina, introduce un secondo polimero della persona. È come se il flusso vitale avesse cambiato funzione e circuito passando dallo stato di contenuto a quello di contenente – il contenuto della forma si trasforma in forma del contenuto. Ma, così, la sostanza vitale diventa pura forma, e l’“Autoritratto” nel suo insieme si trasforma in un’allegoria dell’io nell’epoca della polimerizzazione dell’individuo.
Un autoritratto altrettanto interessante venne dopo quest’ultimo: è stato realizzato da Warhol nel 1981 e si intitola “Shadow”. È una grande serigrafia di circa 100 x 100 cm che lo rappresenta sovradimensionato e sdoppiato. Nella parte destra Warhol appare (quasi) di fronte, il volto tagliato parzialmente dal bordo, mentre più di metà dell’immagine è occupata dall’ombra del suo profilo. Il titolo sottolinea ancora il posto conferito a questo ectoplasma in espansione, che prende avidamente possesso dello spazio della rappresentazione. Titolo e immagine lasciano intravedere l’esistenza di un rapporto complesso con il doppio, su cui dobbiamo insistere(16). Questo rapporto non è del tipo, primario e vitalistico, che intrattiene il primitivo con la sua ombra; si tratta invece del rapporto teso e drammatico peculiare dell’individuo polimerizzato della postmodernità. Per penetrare i suoi segreti bisogna sottoporlo a una doppia contestualizzazione: la prima riguarda direttamente la creazione warholiana, la seconda riguarda le sue fonti.
Nel cotesto dell’anno 1981, accanto a “Shadow”, un’altra opera si segnala: “Double Mickey Mouse”. Il Mickey Mouse è un po’ il Pinocchio di Warhol. Più ancora, è, come Warhol, il puer senex dell’America, così come il suo feticcio. Di nuovo, le coincidenze cronologiche trascendono i limiti dei collegamenti puramente metaforici o, per precisare meglio, offrono loro un fondamento: Warhol (si sa ora dopo innumerevoli ricerche) è nato il 6 agosto 1928(17), e Mickey Mouse, secondo gli storici del cinema e dei fumetti, il 18 novembre dello stesso anno. Warhol e Mickey Mouse appartengono dunque alla stessa “classe” e non credo di sbagliarmi troppo quando affermo che l’artista trae tutto il profitto possibile da questa segreta coincidenza.
Accostiamo direttamente le immagini. Il “Double Mickey Mouse” non si accontenta di essere doppio, è anche gigante, soprattutto se si pensa alle dimensioni di un topo normale: misura esattamente 77,5 x 109,2 cm. Ma Mickey non è senza dubbio un topo “normale”. È un feticcio, un simulacro. È in questa qualità che il raddoppiamento gli è congeniale. Il “due” del “Double Mickey Mouse” non rimanda alla dialettica originale/copia, ed è giustamente questo il fatto più inquietante: i due sono insieme originale e copia. Identici e differenti, sono lo stesso e l’altro allo stato intercambiabile e monumentale. Warhol lo (li) rappresenta su un fondo ricoperto di polvere di diamanti, procedimento tecnico (e simbolico) che adotta spesso per le sue pseudo-icone. In tutto questo percorso apre l’immagine a una vertigine senza fine che è quella della postmodernità, vista come l’epoca della crescita e del trionfo dei simulacri(18).
A differenza di “Double Mickey Mouse”, l’autoritratto “Shadow” accosta la problematica della duplicazione come conseguenza di una separazione, di uno sfaldamento. L’ombra mostra il profilo di una persona (Warhol) che si può guardare (anche) in posizione (quasi) frontale. Tutta una dialettica della rappresentazione occidentale ci ha insegnato che la frontalità – e lo specchio – costituisce la forma simbolica del rapporto dell’io con lo stesso, mentre il profilo – e l’ombra – rimanda alla forma simbolica del rapporto dell’io con l’altro(19).
Mentre Mickey Mouse è l’immagine, sempre di profilo, insieme alienata e gioiosa di un “altro”, Warhol, nel suo autoritratto, mette in scena una tensione inesorabile tra le due immagini. Mentre in alcuni (auto)ritratti fotografici frontali l’artista attira l’attenzione sul valore di maschera dell’immagine o di sua rappresentazione, in “Shadow”, si potrebbe dire, si s-quadra, si s-figura. Da un lato scruta i propri tratti e dall’altro li disfa in un’operazione che rimanda essa stessa a una tradizione che non è estranea alla storia del ritratto e dell’autoritratto occidentale.
In effetti, fin dagli anni ’20 del XX secolo l’immaginario avanguardista accostò il rapporto frontalità/profilo sotto la forma di una schisi. L’esempio emblematico è qui il “Physiognomischer Blitz” (Fulmine fisiognomico) di Paul Klee, realizzato nel 1927(20). Come indica il titolo, quest’opera ha come punto di partenza le esperienze fisiognomiche condotte nel XVIII secolo dal pastore zurighese Lavater, che pensava di poter leggere il carattere di una persona nell’ombra del suo profilo(21). In Klee il grande zigzag nero che fende il volto rappresenta l’ombra del profilo. L’unità solare del personaggio è dislocata, e l’ombra, invece che dissociarsi dal viso, lo commenta, ironicamente, dall’interno. La forza dell’immagine di Klee consiste nel fatto che formalizza o cristallizza, in modo estremamente concentrato, tutta una procedura di simbolizzazione di una crepa in seno alla rappresentazione del volto umano, incrinatura di cui altri artisti hanno sondato le profondità.
Ma per ritornare al nostro punto di partenza, consideriamo più precisamente le esperienze immediatamente anteriori all’ombra warholiana. Esse sono dovute ai due artisti che hanno più segnato la formazione dell’artista americano: Marcel Duchamp e Giorgio De Chirico. Attraverso De Chirico, Warhol entra in un dialogo diretto e profondo con la tradizione occidentale, poiché nell’“Autoritratto” del 1920 il maestro italiano riprendeva e combinava anch’egli in modo evidente due fonti di ispirazione su cui è qui superfluo diffondersi. Occorre invece sottolineare l’abilità di Warhol, che interrogò con una tale insistenza il quadro di De Chirico (di cui aveva senza dubbio una conoscenza diretta) che riuscì a recuperare per suo conto, e in modo che credo puramente intuitivo, le sue profonde ragion d’essere. In questa impresa fu aiutato, indirettamente, dal suo secondo “padrino”: Marcel Duchamp.
Com’è noto Duchamp amava raddoppiarsi, e anche moltiplicarsi. Dire tutto quello che Warhol gli deve esigerebbe uno studio a parte. Limitiamoci dunque agli aspetti che potrebbero chiarire “Shadow”. Nel 1963 Duchamp, che la Pop Art americana stava riscoprendo e proclamando suo fondatore, prepara un’esposizione per il Pasadena Art Museum, in California. Come manifesto dell’esposizione utilizza un vecchio collage. Nei riquadri vuoti di un annuncio di ricerca criminale applica infatti due fotografie che lo rappresentano. Il risultato è intenzionalmente maldestro, e sorprendente: le fotografie sono troppo piccole per il loro riquadro, sono sfocate e male incollate. Inoltre il senso della fotografia di profilo è rovesciato, guarda infatti verso sinistra e non verso destra, come vuole l’uso(22).
L’uso consistente nel fotografare i criminali (o le persone sospettate di un delitto) sotto angolature che differiscono tra loro di 90 gradi è altrettanto vecchio del ricorso stesso alla fotografia da parte dell’apparato poliziesco. Essa trova spiegazione in una certa concezione dell’identità secondo cui quest’ultima è garantita esclusivamente dalla doppia inquadratura. Fotografare di fronte e di profilo equivale a realizzare un “calco” della persona, e il fatto che questo atto sia abitualmente accompagnato dal prelievo delle impronte digitali non è assolutamente un caso. “Di fronte” e “di profilo” formano – insieme – l’impronta del viso.
Nella tradizione occidentale della rappresentazione della persona è il profilo a venire a sottolineare la veduta frontale, e non l’inverso. Per questo la fotografia giudiziaria adottò su questa disposizione senza troppo porsi delle domande: nei manifesti di ricerca, come negli archivi di polizia, la fotografia del profilo occupa la prima posizione, e quella frontale la seconda. Inoltre la veduta di profilo deve guardare verso quella di fronte, come se l’identità della persona dovesse essere considerata nel dialogo riparatore di una schisi.
Riprendendo questo antico dialogo, Duchamp svela l’inganno: quella che si vede è una rappresentazione rovesciata, una rappresentazione in cui il calco della doppia veduta presenta un’incrinatura nascosta ma importante, una rappresentazione che propone una dichiarazione non di identità ma di falsa identità. Come se, in fin dei conti, Duchamp avesse staccato l’ombra dall’originale, o, per dirla nel linguaggio surrealista che gli era senza dubbio familiare, l’ombra dalla preda.
Un simile percorso non è del tutto sorprendente, visto l’interesse che Duchamp nutriva (e da tempo) da un lato per l’ombra e dall’altro per la problematica del rovesciamento. Si può ritrovare nella maggior parte dei suoi autoritratti qualcosa che rimanda a questo gioco, ma mi limiterò di nuovo a darne solo alcuni esempi. Si constata a più riprese nella sua opera una preferenza per il profilo come “firma”, sia negli (auto)ritratti fotografici di gioventù che nel quadro di alcune esperienze che datano degli ultimi anni della sua vita. Così, per la monografia di Robert Lebel “Sur Marcel Duchamp” (1959) preparò un frontespizio che rappresenta il taglio del suo profilo che si stacca sul fondo verde di una delle sue famose “scatole” (la “Scatola verde”). Questa composizione servirà come manifesto dell’esposizione organizzata in occasione del lancio del libro alla libreria La Hune del Quartiere Latino. È facile riconoscere qui il retaggio delle antiche silhouettes fisiognomiche di Lavater. Qual è il senso di questa ripresa tardiva da parte di Duchamp? Il manifesto per La Hune sembra dirlo abbastanza direttamente: libro ed esposizione interrogano un “Duchamp” misterioso e in definitiva indecifrabile; offrono, potremmo dire, un’“ombranalisi”.
In questo contesto va notato che Duchamp realizzò nello stesso tempo un autoritratto il cui profilo è ritagliato in negativo e che lo inviò ad alcuni amici. Per chi si è almeno un po’ familiarizzato da un lato con la retorica dei gesti duchampiani e dall’altro con la tradizione lavateriana, si apre la strada di una lettura dissociata di queste due immagini: come in Lavater, la veduta in positivo e quella in negativo rimandano l’una all’altra, ma – e qui Duchamp entra in gioco – il profilo nero è quello che, offrendosi alla sfera pubblica, rimane indecifrabile, mentre il profilo bianco, che si rivolge agli amici, è solo un’illusione poiché il suo “originale” non esiste più.
Per completare la riflessione duchampiana sulla schisi, conviene dare almeno un ultimo esempio. Si tratta di un ritratto fotografico, datato 1953 e il cui autore è Victor Obsatz. Come sempre in casi simili, è molto difficile separare la parte dovuta al modello nella concezione dell’immagine; tuttavia il suo carattere ludico eccezionale lascia pensare che questo contributo fu non trascurabile. La fotografia consiste in una sovrapposizione di due vedute (fronte e profilo). In quella principale (frontale) il modello fissa lo spettatore, gli sorride, intavolando con lui un dialogo del tipo io/tu. La veduta di profilo invece non vi partecipa e non potrebbe parteciparvi. Lo sguardo è diretto verso un punto indefinito, senza possibilità di incontro con il nostro. La sovrapposizione delle due immagini è di tale perfezione che è del tutto evidente che riguardano la stessa persona: la linea della fronte della veduta di profilo si confonde con il contorno della testa visto di fronte e, a un certo punto, non si sa più dove comincia un’immagine e dove finisce l’altra. Che questa apparente unità non sia di fatto che una dualità ha a che vedere con il carattere debole della veduta frontale: anche se è sorridente e apparentemente “qui”, attesta una trasparenza fantomatica, lasciando così che l’orecchia del profilo prenda il posto del naso. L’allusione a una certa retorica di una decostruzione di stampo cubista vi è senza dubbio presente, ma secondo me il discorso duchampiano mira più lontano: alla schisi della rappresentazione del volto in Occidente.
Terminato questo giro nei meandri della tradizione, interroghiamo un’ultima volta ancora “Shadows” di Warhol. L’inquadratura si concentra esclusivamente sul volto. Questo volto enorme (quasi un metro quadrato) si rifà a una retorica dell’ingrandimento e del formato che non è la retorica del ritratto pittorico occidentale ma quella del primo piano cinematografico. Warhol concepisce l’immagine, come è stato sottolineato in diverse occasioni, come più reale del reale(23). L’ingrandimento è solo uno dei metodi di iperrealizzazione, il raddoppiamento e la moltiplicazione ne sono altri. Quest’ultimo metodo, così ampiamente utilizzato da Warhol in tutte le sue icone postmoderne, si trova qui messo in opera in modo molto particolare: attraverso l’ombra portata. Ombra e volto formano un’antinomia: l’ombra si estende nello spazio della rappresentazione mentre il volto frontale è tagliato dalla cornice. Dove siamo? Il fondo blu evoca il cielo; lo strano colore del volto, quanto ad esso, ricorda piuttosto i riflessi della camera oscura di un fotografo. Si possono conciliare i due spazi? Forse, ma a una sola condizione: quella di operare la strutturazione in maniera simbolica. Nella camera oscura del suo atelier, Warhol si sviluppa. Facendolo, si dis-fa. Quello che vediamo è insieme un autoritratto e una sceneggiatura poetica, ma evidentemente un autoritratto/sceneggiatura poetica concepibile soltanto nell’era della fotografia.
Guardiamo l’ombra: essa non ha limiti, il profilo è in espansione indeterminata. L’ombra è piatta, unidimensionale, e la sua stessa forma è instabile. È il risultato di uno sviluppo del volto, e questo non solo nel senso di un fotogramma, ma anche, più concretamente, come sviluppo di un volume sulla superficie: “Io vedo tutto così, la superficie delle cose, una sorta di Braille mentale. Non faccio che passare la mano sulla superficie delle cose”(24). Ovvero: “Se volete sapere tutto su Andy Warhol, guardate la superficie – dei miei quadri, dei miei films, di me stesso –, è lì che mi troverete. Non c’è niente dietro la superficie”(25).
Poiché la superficie è l’io, poiché è la persona, lo straordinario sviluppo del volto nell’ombra portata non è più un’operazione di attestato della “presenza reale”, come aveva stabilito tutta una tradizione della rappresentazione in Occidente, ma un percorso mirante all’ultimo stadio dell’iperrealizzazione della persona: la sua realizzazione suprema nel proprio niente. Grande etcoplasma proiettato sul blu a paillettes di diamante, il volto senza profondità e senza forma di colui che si s-figura firma il paradosso di una rappresentazione dell’io vista come sparizione monumentale, cosmica.
1) Per maggiori dettagli, mi permetto di rimandare a Victor I. Stoichita, “L’invenzione del quadro. Arte, artefici e artifici nella pittura europea” (1993), trad. it. Il Saggiatore, Milano 1998.
2) Mi rifaccio al materiale raccolto e presentato da Patrick S. Smith, “Andy Warhol’s Art and Film”, U.M.I. Research Press, Ann Arbor 1986, pp. 198-202.
3) Su questa nozione, si potrà consultare il libro di Oscar Bätschmann, “Austellungskünstler. Kult und Karriere im modernen Kunstsystem”, DuMont, Colonia 1997.
4) Cennino Cennini, “Il libro dell’arte”, Neri Pozza, Vicenza 1995, pp. 9-10.
5) L’espressione è di Boileau, “Satira IX”. Vedi a questo proposito Jean Roudaut, “Une ombre au tableau”, Ubacs, Chavagne 1988.
6) Carrie Rickey, in “Artforum”, aprile 1979, p. 73 (in “Reviews New York”, recensione dell’esposizione). Da notare anche che altri autori parlano di un numero diverso di tele (67 + 16). Vedi David Bourdon, “Andy Warhol”, trad. fr. Flammarion, Parigi 1989, p. 372.
7) Sul rapporto tra Warhol e De Chirico, vedi le osservazioni di Donald Kuspit, “The Cult of the Avant-Garde Artist”, Cambridge University Press, Cambridge e New York 1993, pp. 67ss.
8) Andy Warhol, “Una metafisica industriale. Intervista di Achille Bonito Oliva a Andy Warhol”, in Achille Bonito Oliva (a cura di), “Warhol verso De Chirico”, Electa, Milano 1982, pp. 55-59.
9) Giorgio De Chirico, lettera a Fritz Gratz citata da G. Roos, “Giorgio De Chirico und seine Malerfreunde Fritz Gratz, Georgios Busianis, Dimitrios Pikionis in München 1906-1909”, in Wieland Schmied e G. Roos, “Giorgio De Chirico München 1906-1909”, Akademie der Bildenden Künste, Monaco 1994, p. 177.
10) Vedi James Thrall Soby, “Giorgio De Chirico”, The Museum of Modern Art, New York 1966, p. 245.
11) Vedi Friedrich Nietzsche, “La Gaia Scienza”, libro IV, frammento 341.
12) Gilles Deleuze, “Logica del senso” (1969), trad. it. Feltrinelli, Milano 1975, pp. 223-246. Vedi anche Thierry Lenain, “Pour une critique de la raison ludique. Essai sur la problématique nietzschéenne”, Vrin, Parigi 1993, pp. 112-143.
13) Secondo l’espressione di G. Bandman, “Bemerkungen zu einer ikonologie des Materials”, in “Städel Jahrbuch” (nuova serie), n. 2, 1969, pp. 75-100. Vedi anche Thomas Raff, “Die Spracher der Materialien. Anleitung zu einer Ikonologie der Werkstoffe”, Deutscher Kunstverlag, Monaco 1994, e, per quel che riguarda in particolare Warhol, Marco Livingston, “A faire soi-même: notes sur les techniques de Warhol”, trad. fr. in “Andy Warhol. Retrospective”, Centre Georges Pompidou, Parigi 1990, pp. 63-78.
14) Su questo problema, vedi Charles F. Stuckey, “Andy Warhol’s Painted Faces”, in “Art in America”, n. 68, maggio 1980, pp. 112-119, e soprattutto Reinhard A. Steiner, “Die Frage nach der Person. Zum Realitätscharakter von Andy Warhols Bildern”, in “Pantheon”, t. XLII, 1984, pp. 151-157.
15) Warhol a proposito di De Chirico: “Ogni volta che l’ho incontrato ho sentito che lo conoscevo da sempre. Credo che anche lui provasse la stessa cosa. Una volta notò che entrambi abbiamo i capelli bianchi” (“Una metafisica industriale”, cit., p. 70).
16) Seguiamo così l’interrogazione di Jean Baudrillard, “Lo scambio simbolico e la morte” (1976), trad. it. Feltrinelli, Milano 1979, pp. 84-90 e 162-170.
17) Data scoperta da Andreas Brown (“Andy Warhol: His Early Works, 1947-1959”, New York 1971).
18) Gilles Deleuze, “Differenza e ripetizione” (1968), trad. it. Cortina, Milano 1997, e “Logica del senso”, cit., pp. 223-246.
19) Per un’analisi più approfondita, ci si riferisca al mio libro “A Short History of the Shadow”, Reaktion Books, Londra 1997, pp. 29ss.
20) Vedi a questo proposito le spiegazioni date dall’artista stesso in Paul Klee, “Écrits sur l’art”, trad. fr. Dessain et Tolra, Parigi 1980, t. I, p. 330.
21) Per maggiori dettagli vedi V.I. Stoichita, “Johann Caspar Lavater’s ‘Essays on Physiognomony’ and the Hermeneutics of Shadow”, in “RES, Anthropology and Aesthetics”, n. 31, 1997, pp. 128-138.
22) Vedi la lettura di Richard Brilliant, “Portraiture”, Reaktion Books, Londra 1991, pp. 171-174, così come le osservazioni di Christine Van Schoonbeek, “Alfred Jarry, un oubli‚ de l’histoire de l’art”, in “Annales d’histoire de l’art et d’archéologie. Université Libre de Bruxelles”, t. XVII, 1995, pp. 94-96.
23) Vedi Jean Baudrillard, “Lo scambio simbolico e la morte”, cit., p. 86; Reinhard A. Steiner, “Die Frage nach der Person”, cit.
24) Andy Warhol, citazione estratta da Gretchen Berg, “Andy: My True Story”, in “Los Angeles Free Press”, 17 marzo 1967, p. 3.
25) Ibidem. Vedi anche lo studio di Benjamin Buchloh, “L’art unidimensionnel d’Andy Warhol 1956-1966”, trad. fr. in “AndyWarhol. Retrospective”, cit., pp. 39-61.
Victor I. Stoichita è nato a Bucarest nel 1949. È professore ordinario di Storia dell’arte moderna e contemporanea presso l’università di Friburgo, in Svizzera. In italiano è recentemente stato tradotto il suo “L’invenzione del quadro” (1993), Il Saggiatore, Milano 1998. Del 1997 è il suo libro “A Short History of the Shadow”, Reaktion Books, Londra, di cui il presente testo costituisce parte dell’ultimo capitolo, già apparso in questa forma in rivista. Traduzione di Elio Grazioli.


