L'edicola digitale delle riviste italiane di arte e cultura contemporanea
Ipso Facto (1999 - 2000) Anno 2 Numero 6 Gennaio-Aprile 2000
Compresenza e disponibilità
Nicolas Bourriaud
L'eredità teorica di Felix Gonzalez-Torres
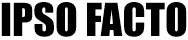
Rivista d'arte contemporanea
Editoriale
E.G.
n. 8 Settembre-Dicembre 2000
Editoriale
E.G.
n. 7 Aprile-Agosto 2000
Le ombre di Warhol
Victor I. Stoichita
n. 6 Gennaio-Aprile 2000
Editoriale
E.G.
n. 6 Gennaio-Aprile 2000
Rapporti schermo
Nicolas Bourriaud
n. 5 Settembre - Dicembre 1999
Plight di Joseph Beuys
Marion Hohlfeldt
n. 5 Settembre - Dicembre 1999

Si tratta di un cubo di carta di formato ridotto, non abbastanza largo da dare l’illusione della monumentalità, troppo poco abbondante da far dimenticare che si tratta di una pila di manifesti identici. Questo è di colore azzurro cielo, circondato da un largo bordo bianco. Sul dorso, l’azzurro appare rafforzato a causa della pila della carta. Il cartellino: “Felix Gonzalez-Torres, Untitled (Blu mirror), 1990. Offset print on paper, endless copies”. Si può portare via uno dei manifesti. Ma cosa succede se un grande numero di visitatori si impadronisce, ognuno per sé, dei fogli offerti al pubblico astratto? Secondo quale processo l’opera si modifica allora, per infine sparire? Perché non si tratta di una “performance”, né di una distribuzione di manifesti, ma di un’opera dotata di una forma definita, di una certa densità; un’opera che non espone il proprio processo di costruzione (o di smontaggio), ma la forma della sua presenza tra un pubblico. Questa problematica dell’offerta conviviale, della disponibilità dell’opera d’arte, così come la mette la scena Gonzalez-Torres, si avvera oggi fondatrice di senso: non soltanto si ritrova al centro dell’estetica contemporanea, ma va molto più lontano, fino all’essenza dei nostri rapporti con le cose. Per questo l’opera dell’artista cubano, dopo la sua morte avvenuta nel gennaio 1996, chiede un esame critico che la restituisca al contesto attuale, al quale ha largamente contribuito.
L’omosessualità come paradigma di coabitazione
Sarebbe troppo facile ridurre il lavoro di Felix Gonzalez-Torres, come si ha oggi tendenza a fare, a una problematica neoformalista o al tracciato di una militanza omosessuale. La sua forza risiede insieme nella sua abilità a strumentalizzare delle forme e nella sua capacità di sfuggire alle identificazioni comunitarie per raggiungere il cuore dell’esperienza umana. L’omosessualità rappresenta così per lui meno un tema discorsivo che una dimensione emotiva, una forma di vita creatrice di forme d’arte. Felix Gonzalez-Torres è senza dubbio il primo a porre in modo convincente le basi di un’estetica omo-sensuale, nel senso in cui Michel Foucault se ne ispirava per fondare un’etica creativa dei rapporti amorosi. In entrambi i casi si tratta di uno slancio verso l’universale, e non di una rivendicazione categoriale. L’omosessualità, in Gonzalez-Torres, non si chiude su un’affermazione comunitaria: al contrario, si fa modello di vita condivisibile da tutti, e a cui ognuno può identificarsi.
Ancor più, essa genera nella sua opera un campo di forme specifico, che si caratterizza principalmente attraverso una dualità senza opposizioni. La cifra “due” è onnipresente, ma non si tratta mai di un’opposizione binaria. Si vedono così due orologi fermi alla stessa ora – “Untitled (Perfect lovers)”, 1991; due cuscini su un letto sfatto, con ancora il segno di un corpo – 24 manifesti, 1991; due lampadine nude fissate alla parete, i cui fili si intrecciano – “Untitled (March 5th) #2”, 1991; due specchi posti uno di fianco all’altro – “Untitled (March 5th) #1”, 1991. L’unità di base dell’estetica di Gonzalez-Torres è doppia. Il sentimento di solitudine non è mai rappresentato dall’“1”, ma dall’assenza del “2”. Per questo la sua opera segna un momento importante nella rappresentazione della coppia, figura classica della storia dell’arte: non si tratta più della somma di due realtà fatalmente eterogenee, che si completano in un sottile gioco di opposizioni e di diversità, e mosse dall’ambivalenza dei movimenti di attrazione e repulsione (pensiamo ai “Coniugi Arnolfini” di Van Eyck, o al simbolismo duchampiano del “re e regina”). La coppia di Gonzalez-Torres si caratterizza invece come un’unità doppia e calma, come un’ellisse – “Untitled (Double portrait)”, 1991. La struttura formale della sua opera risiede in questa parità armoniosa, questa inclusione dell’altro in sé, che essa declina all’infinito e che costituisce senza dubbio il suo principale paradigma.
Verrebbe la tentazione di qualificare il suo lavoro come autobiografico, date le numerose allusioni dell’artista alla propria vita (la tonalità molto personale dei “puzzles”, l’apparizione delle “candy pieces” al momento della morte del suo boyfriend Ross), ma questa idea appare subito incompleta: Gonzalez-Torres racconta, dall’inizio alla fine, non la storia di un individuo, ma quella di una coppia, dunque di una coabitazione. L’opera si divide del resto in figure che intrattengono tutte uno stretto rapporto con la coabitazione amorosa. L’incontro e l’unione (tutti i “paia”); la conoscenza dell’altro (i “ritratti”); la vita in comune, presentata come una ghirlanda di istanti felici (le lampadine, e le figure del viaggio); la separazione, che comprende tutte le immagini di assenza onnipresenti nell’opera; la malattia (lo stampato di “Untitled (Blood-works)”, 1989; le perle rosse e bianche di “Untitled (Blood)”, 1992); infine la deplorazione della morte (la tomba di Stein e Toklas a Parigi; i bordi neri sui manifesti bianchi).
Nella sua globalità, il lavoro di Gonzalez-Torres si articola senz’altro intorno a un progetto autobiografico, ma un’autobiografia bicefala, condivisa. Così, fin dalla metà degli anni ’80, epoca delle sue prime esposizioni, l’artista cubano prefigura uno spazio basato sull’intersoggettività, che è precisamente quello che esploreranno gli artisti più interessanti del decennio seguente. Per citarne solo alcuni la cui opera arriva oggi a maturità: Rirkrit Tiravanija, Dominique Gonzalez-Foerster, Douglas Gordon, Jorge Pardo, Liam Gillick, Philippe Parreno, che, pur sviluppando ognuno delle problematiche personali, trovano un terreno comune intorno alla priorità che accordano allo spazio dei rapporti umani nella concezione e diffusione del loro lavoro (articolano dei modi di produzione sui rapporti interumani). Dominique Gonzalez-Foerster e Jorge Pardo sono forse i due artisti che presentano più punti in comune con Gonzalez-Torres: la prima per la sua esplorazione dell’intimità domestica come interfaccia dei movimenti dell’immaginario pubblico, che trasforma i ricordi più personali e più complessi in forme chiare e spoglie; il secondo per l’aspetto minimale, evanescente e sottile del suo repertorio formale, la sua capacità di risolvere problemi spaziotemporali attraverso la geometrizzazione degli oggetti funzionali. Sia Pardo che Gonzalez-Foerster pongono il colore al centro delle loro preoccupazioni: ora si riconosce lo “stile” di Gonzalez-Torres nella sua dolcezza cromatica (onnipresenza dell’azzurro cielo, del bianco; il rosso viene solo per indicare il sangue, nuova figura della morte).
La nozione di inclusione dell’altro non costituisce soltanto un tema. Si avvera di fatto essenziale alla comprensione formale del lavoro. Si è insistito molto sulla “ricarica” da parte di Gonzalez-Torres delle forme già storicizzate, del suo reinvestimento del repertorio estetico dell’Arte Minimal (i parallelepipedi di carta; i diagrammi, che assomigliano a disegni di Sol LeWitt), dell’Antiform e della Process Art (gli angoli di caramelle ricordano il Richard Serra della fine degli anni ’60) o dell’Arte Concettuale (i manifesti-ritratti, bianco su nero, evocano Kosuth). Ma anche qui si tratta di una questione di accoppiamento e di coabitazione. La domanda posta da Gonzalez-Torres, lancinante, potrebbe essere riassunta così: “come posso abitare nella realtà?”, oppure “come può un incontro tra due realtà modificarle bilateralmente?”...
L’iniezione dell’universo intimista dell’artista nelle strutture dell’arte degli anni ’60 crea delle situazioni inedite, e orienta retroattivamente la nostra lettura di questa arte verso una riflessione meno formalista e più psicologizzante. Certo, questo riciclaggio costituisce anche un partito preso estetico: mostra che le strutture artistiche non si limitano mai a un unico gioco di significati; d’altra parte, la semplicità delle forme utilizzate dall’artista contrasta vigorosamente con il loro contenuto tragico o militante. Ma l’essenziale resta questo orizzonte di fusione indicato da Gonzalez-Torres, questa esigenza di armonia e di coabitazione che abbraccia finanche il suo rapporto con la storia dell’arte.
Forme contemporanee del monumento
Il punto comune esistente tra tutti gli oggetti che vengono classificati sotto l’appellativo di “opera d’arte” risiede nella loro facoltà di produrre il senso dell’esistenza umana (di indicare traiettorie possibili) in seno a questo caos che è la realtà. Ed è in nome di questa definizione che l’arte contemporanea – in blocco – si vede screditata oggi, generalmente da quelli che vedono nel concetto di “senso” una nozione preesistente all’azione umana. Una pila di carta, per loro, non può entrare nella categoria dei capolavori, perché considerano il senso come un’entità prestabilita, che va oltre gli scambi sociali e le costruzioni collettive. Non vogliono vedere che l’universo non è nient’altro che un caos a cui gli Uomini oppongono del verbo e delle forme. Vorrebbero del senso già pronto (e la sua morale trascendente), un’origine che sarebbe garante di quel senso (un ordine da ritrovare) e delle regole codificate (la pittura, insomma!). Il mercato dell’arte si rivela del tutto d’accordo con loro, salvo eccezioni: l’irrazionalità dell’economia capitalista prova il bisogno strutturale di ancorarsi a certezze di fede – il dollaro non esibisce casualmente il suo fiero motto: “In God we trust” – e il grosso dell’investimento artistico va il più delle volte verso i valori certificati dal senso comune.
Ci si inquieta dunque nel vedere gli artisti d’oggi esporre processi o situazioni. Ci si lamenta dell’aspetto “troppo concettuale” delle loro opere (accordando così, segno di un istinto sicuro nella pigrizia, l’incomprensione delle forme all’uso di un termine di cui si ignora il senso). Ma questa relativa immaterialità dell’arte degli anni ’90 (che è del resto più il segno della priorità che questi artisti accordano al tempo rispetto allo spazio che una volontà di non produrre oggetti), non è motivata né da una militanza estetica, né da un rifiuto manierista di creare oggetti. Espongono e esplorano il processo che conduce agli oggetti, al senso. L’oggetto è solo una “happy end” del processo espositivo, come spiega Philippe Parreno: non rappresenta la conclusione logica del lavoro, ma un evento. Un’esposizione di Tiravanija, per esempio, non schiva la materializzazione, ma decostruisce i modi di costituzione dell’oggetto d’arte in una serie di eventi, ridandogli una durata propria, che non è necessariamente la durata convenzionale del quadro che si guarda. Non si deve cedere su questo punto: l’arte attuale non ha niente da invidiare al “monumento” classico per quanto riguarda il produrre degli effetti di lunga durata. L’opera contemporanea è più che mai questa “dimostrazione, per tutti gli uomini a venire, della possibilità di creare il significato abitando i bordi dell’abisso”(1), secondo le parole di Cornélius Castoriadis: una soluzione formale che raggiunge l’eternità precisamente perché è puntuale e temporanea.
Felix Gonzalez-Torres mi sembra esemplare di questa ambizione: morto di Aids, ha radicato il suo lavoro in una coscienza acuta della durata, della sopravvivenza delle emozioni più impalpabili; attento ai modi di produzione, ha centrato la sua pratica su una teoria dello scambio e della condivisione; militante, ha promosso forme nuove dell’impegno artistico; omosessuale, è riuscito a trasmutare il suo modo di vivere in termini di valori etici ed estetici.
Più precisamente, pone il problema dei processi di materializzazione in arte, e dello sguardo dei nostri contemporanei sulle forme nuove di materializzazione. Per la maggior parte delle persone, e malgrado l’evoluzione tecnologica che ridicolizza questo tipo di pregiudizi, la durata di un’informazione e la capacità di un’opera d’arte di affrontare il tempo sono legate alla solidità dei materiali scelti, e dunque, implicitamente, alla tradizione. Affrontando e rasentando la morte in quanto individuo, Gonzalez-Torres decide coraggiosamente di porre la problematica dell’iscrizione al centro del suo lavoro.
Arriva anche fino ad accostarla dal versante più delicato, cioè secondo i diversi aspetti del monumentale: la commemorazione degli avvenimenti, la perennità del ricordo, la materializzazione dell’impalpabile. Così l’apparizione delle ghirlande di lampadine elettriche è legata a una visione furtiva sopravvenuta a Parigi nel 1985: “Mi ci sono imbattuto per caso e ho immediatamente scattato una fotografia, perché era una visione felice”(2). La parte più monumentale del suo lavoro, Gonzalez-Torres la riserva ai ritratti che realizza a partire da conversazioni con il committente: fregi in cui si succedono, in un ordine spesso cronologico, ricordi intimi e eventi storici, i ritratti realizzati nella modalità del disegno murale (“wall drawing”) svolgono una funzione essenziale del monumento: la congiunzione, all’interno di una forma unica, di un individuo e della sua epoca.
Ma questa stilizzazione delle forme sociali si manifesta ancor più chiaramente nel permanente contrasto che Gonzalez-Torres instaura tra l’importanza degli avvenimenti evocati, la loro complessità, la loro gravità, e il carattere minimale delle forme impiegate per evocarle. Così, per esempio, un visitatore non avvertito potrebbe certamente guardare “Untitled (21 days of bloodwork - steady Decline)” come un insieme di disegni minimalisti; la fine quadrettatura, l’unica linea obliqua che attraversa lo spazio, non evocano direttamente la caduta dei globuli bianchi nel sangue di un malato di Aids. Una volta effettuata la connessione tra queste due realtà (la discrezione del disegno, la malattia), la forza allusiva dell’opera assume una terribile ampiezza che ci rimanda alla nostra volontà costante di non vedere questo, di negare inconsciamente la possibilità e l’entità della malattia. Niente è mai dimostrativo o esplicito nella strategia monumentale, politica, a cui si dedica l’artista. Secondo lui “due orologi uno accanto all’altro sono più minacciosi per il potere dell’immagine di due tipi che si fanno un pompino, perché non può utilizzarmi come un punto di adesione nella sua battaglia per cancellare il significato”(3).
Gonzalez-Torres non lancia messaggi: inscrive i fatti nelle forme, come messaggi criptati, bottiglie in mare. La memoria subisce qui un processo di astrazione analogo a quelli che subiscono i corpi umani: “È un’astrazione totale; ma è il corpo. È la vita”, diceva all’amico Ross, di fronte al tracciato di un esame sanguigno. Con “Untitled (Alice B. Toklas’ and Gertrude Stein’s grave, Paris)”, una fotografia del 1992 che rappresenta i fiori piantati sulla tomba comune delle due amiche, Gonzalez-Torres invalida un fatto; pone l’omosessualità femminile come una scelta indiscutibile, suscettibile di imporre il rispetto al più retrogrado dei senatori repubblicani. Ritrova qui, con l’aiuto di una semplice natura morta fotografica, l’essenza del monumentale: in altre parole, la produzione di un’emozione di ordine morale. Che un artista riesca a innescare questa emozione andando contro i procedimenti tradizionali (una fotografia incorniciata) e la morale borghese (una coppia lesbica) non è l’aspetto meno notevole di quest’opera profondamente, deliberatamente discreta.
Il criterio di coesistenza (le opere e gli individui)
L’opera di Gonzalez-Torres riserva dunque un posto centrale alla negoziazione, alla costruzione di una coabitazione. Contiene così un’etica dello spettatore. Sotto questo riguardo si inscrive in una storia specifica, quella delle opere che conducono lo spettatore a prendere coscienza del contesto in cui si trova (gli “happenings”, gli “environnements” degli anni ’60, le installazioni “in situ”).
A un’esposizione di Gonzalez-Torres ho visto dei visitatori ammassare tutte le caramelle che mani e tasche potevano contenere: eccoli rinviati al loro comportamento sociale, al loro feticismo, alla loro concezione accumulativa del mondo... Mentre altri non osano, o aspettano che il loro vicino ne trafughi una per fare altrettanto. Le “candy pieces” pongono così un problema etico sotto una forma apparentemente anodina: il nostro rapporto con l’autorità, e l’uso che i guardiani di museo fanno del loro potere; il nostro senso della misura e la natura dei nostri rapporti con l’opera d’arte.
Nella misura in cui rappresenta l’occasione di un’esperienza sensibile basata sullo scambio, deve vedersi sottoposta a criteri analoghi a quelli che fondano il nostro apprezzamento di qualsiasi realtà sociale costruita. Ciò che fonda oggi l’esperienza artistica è la compresenza degli spettatori di fronte all’opera, che sia effettiva o simbolica. La prima domanda che ci si dovrebbe porre in presenza di un’opera d’arte è: Mi dà la possibilità di esistere di fronte ad essa, o invece mi nega in quanto soggetto, rifiutandosi di considerare l’Altro nella sua struttura? Lo spaziotempo suggerito o descritto da quest’opera, con le leggi che lo reggono, corrisponde alle mie aspirazioni nella vita reale? Critica ciò che giudico criticabile? Potrei vivere in uno spaziotempo che le corrispondesse nella realtà?
Queste domande non rimandano a una visione esageratamente antropomorfica dell’arte, ma a una visione molto semplicemente umana: che io sappia, un artista destina i suoi lavori ai suoi contemporanei, a meno che si consideri un morto in anticipo, o che abbia una versione fascista-integralista della Storia (il tempo chiuso sul suo senso, sull’origine). Al contrario, le opere che mi sembrano oggi degne di notevole interesse sono quelle che funzionano come interstizi, come spaziotempo retti da un’economia che va al di là delle regole in vigore riguardanti la gestione dei pubblici. Ciò che ci colpisce nel lavoro di questa generazione di artisti è in primo luogo la preoccupazione democratica che li anima. Perché l’arte non trascende le preoccupazioni quotidiane, ci confronta con la realtà attraverso la singolarità di un rapporto con il mondo, attraverso una finzione. A chi si vuol far credere che un’arte autoritaria nei confronti dei suoi spettatori rinvii ad altro reale se non a quello, fantasmato o accettato, di una società intollerante? All’opposto, le situazioni di esposizione a cui ci confrontano artisti come Gonzalez-Torres, e oggi Angela Bulloch, Carsten Höller, Gabriel Orozco o Pierre Huyghe, sono rette dalla preoccupazione di “lasciare la sua opportunità” ad ognuno, attraverso forme che non stabiliscono nessuna precedenza a priori del produttore sullo spettatore (diciamo: nessuna autorità di diritto divino), ma negoziano con lui dei rapporti aperti, non risolti in anticipo. Quest’ultimo oscilla allora tra lo statuto di consumatore passivo e quello di testimone, di associato, di cliente invitato, di coproduttore, di protagonista. Attenzione dunque: si sa che le attitudini diventano forme, ci si deve ormai rendere conto che le forme inducono modelli di socialità.
E quella delle esposizioni non sfugge a queste precauzioni: la proliferazione dei “cabinets d’amateur” a cui assistiamo da qualche tempo, ma anche gli atteggiamenti elitari di certi attori dell’ambiente artistico, testimoniano un santo orrore dello spazio pubblico e della sperimentazione estetica condivisa, a profitto di boudoirs riservati agli specialisti. La messa a disposizione delle cose non comporta automaticamente la loro banalizzazione: come in un mucchio di caramelle di Gonzalez-Torres, può esistere un’oscillazione ideale tra la forma e la sua sparizione programmata, tra la bellezza visiva e la modestia dei gesti, tra la meraviglia infantile di fronte all’immagine e la complessità dei suoi livelli di lettura.
L’aura delle opere d’arte si è spostata verso il suo pubblico
L’arte d’oggi – e penso agli artisti già citati o anche a Lincoln Tobier, Ben Kinmont, Andrea Zittel e altri ancora – prende in conto nel processo di lavoro la presenza della microcomunità che la riceve. Un’opera crea così, prima all’interno del suo modo di produzione e poi al momento della sua esposizione, una collettività istantanea di spettatori-partecipanti.
In occasione di un’esposizione al Magasin di Grenoble, Gonzalez-Torres aveva modificato la caffetteria del museo ridipingendola di azzurro, ponendo dei mazzetti di violette sui tavoli e mettendo a disposizione dei visitatori una documentazione sulle balene. Nella sua esposizione personale alla galleria Jennifer Flay “Untitled (Arena)”, nel 1993, aveva disposto un quadrilatero delimitato da lampadine accese; un paio di walkman erano messi a disposizione dei visitatori perché potessero ballare sotto le ghirlande luminose, in silenzio, al centro della galleria. In entrambi i casi l’artista incita lo “spettatore” a prendere posto in un dispositivo, a farlo vivere, a completare il lavoro e a partecipare all’elaborazione del suo senso. Niente di che gridare al facile gadget: questo tipo di opere (che vengono erroneamente dette “interattive”) si rifà all’Arte Minimal, il cui sfondo fenomenologico speculava sulla presenza dello spettatore come parte integrante dell’opera. È questa “partecipazione” che Michael Fried denunciò del resto sotto il titolo generico di “teatralità”: “L’esperienza dell’Arte Letterale [Arte Minimal] è quella di un oggetto ‘in situazione’; questa, quasi per definizione, include lo spettatore”(4). Se l’Arte Minimal fornì a suo tempo gli strumenti necessari a un’analisi critica delle nostre condizioni di percezione, ci si rende facilmente conto che un’opera come “Untitled (Arena)” non ha più semplicemente a che fare con la percezione oculare: è il suo corpo intero, la sua storia e il suo comportamento che lo spettatore apporta, e non più una presenza fisica astratta. Lo spazio dell’Arte Minimal si costruiva nella distanza che separa lo sguardo e l’opera; quello che definiscono le opere di Gonzalez-Torres, con l’aiuto di mezzi formali paragonabili, si elabora nell’intersoggettività, nella risposta emotiva, comportamentale e storica data dallo spettatore all’esperienza proposta. L’incontro con l’opera genera meno uno spazio (come nel caso dell’Arte Minimal) che una durata. Tempo di manipolazione, di comprensione, di decisione, che va oltre l’atto di “completare” l’opera attraverso lo sguardo.
L’arte moderna ha ampiamente accompagnato, discusso e precipitato il fenomeno della sparizione dell’aura dell’opera d’arte, brillantemente commentata da Walter Benjamin nel 1935. L’epoca della “riproduzione tecnica illimitata” ha effettivamente rovinato questo effetto religioso che Benjamin definiva “l’unica apparizione di una lontananza”, proprietà tradizionalmente attribuita all’arte. Parallelamente, nel quadro di un movimento generale di emancipazione, la modernità si è impegnata a criticare la predominanza della comunità sull’individuo, a criticare sistematicamente le forme di alienazione collettiva. Ora, di fronte a che cosa ci ritroviamo oggi? Ovunque la sacralità fa il suo ritorno; si aspira confusamente al ritorno dell’aura tradizionale; non si hanno sufficienti parole per schernire l’individualismo contemporaneo. Una fase del progetto moderno si conclude. Oggi occorre, dopo due secoli di lotta per la singolarità e contro le pulsioni di gruppo, operare una nuova sintesi che possa preservarci dal fantasma regressivo all’opera un po’ ovunque. Reinvestire l’idea di pluralità, per la cultura contemporanea venuta dalla modernità, significa inventare modi di essere insieme, forme di interazione che vadano al di là della fatalità delle famiglie, dei ghetti della tecnoconvivialità e delle istituzioni collettive che ci sono proposte. Non si può prolungare con profitto la modernità se non andando oltre le lotte che ci ha lasciato: nelle nostre società postindustriali non è più l’emancipazione degli individui ad avverarsi più urgente, ma quella della comunicazione interumana, l’emancipazione della dimensione relazionale dell’esistenza.
Una certa diffidenza si è diffusa nei confronti degli strumenti della mediazione, degli oggetti transizionali in generale. E dunque, per estensione, all’opera d’arte considerata come un medium con cui un individuo esprime la sua visione del mondo di fronte a un pubblico. I rapporti tra gli artisti e la loro produzione ripiegano dunque verso la zona del feed-back: da qualche anno si moltiplicano i progetti artistici conviviali, festivi, collettivi o partecipativi, che esplorano molteplici potenzialità del rapporto con l’altro. Sempre più il pubblico si vede di colpo preso in causa. Come se ormai questa “unica apparizione di una lontananza” che è l’aura artistica si vedesse fornita da esso: come se la microcomunità che si raggruppa di fronte all’immagine diventasse la fonte stessa dell’aura, mentre la “lontananza” appare puntualmente per aureolare l’opera, che le delega i suoi poteri. L’aura dell’arte non si trova più nel retromondo rappresentato dall’opera, né nella forma stessa, ma davanti ad essa, in seno alla forma collettiva temporanea che essa produce esponendosi.
È in questo senso che si può parlare di un effetto comunitario nell’arte contemporanea: non si tratta di questi corporativismi che servono troppo spesso a mascherare i conservatorismi più affermati (il femminismo, l’antirazzismo e l’ecologismo funzionano troppo spesso ai nostri giorni come lobby che fanno il gioco del potere permettendogli di non rimettersi mai in causa strutturalmente). L’arte contemporanea opera dunque uno spostamento radicale in rapporto all’arte moderna, nel senso che non nega l’aura dell’opera d’arte ma ne sposta l’origine e l’effetto. Era già il senso di questo capolavoro del gruppo General Idea intitolato “Towards an audience vocabulary” (Verso un vocabolario pubblico), del 1977, che saltava la tappa dell’oggetto d’arte per parlare direttamente al pubblico e proporgli dei modi di comportamento. Là l’aura si ricostituisce, per libere associazioni. Importa tuttavia non mistificare la nozione di pubblico: l’idea di una “massa” unitaria ha più a che vedere con un’estetica fascista che con queste esperienze momentanee, dove ognuno deve conservare la sua identità(5). Si tratta di cordate determinate in anticipo e limitate a un contratto, e non di una colla sociale che indurisca intorno a totem identitari. L’aura dell’arte contemporanea è un’associazione libera.
La bellezza come soluzione?
Tra le tentazioni reazionarie che agitano oggi il campo culturale si trova in prima linea un progetto di riabilitazione della nozione di Bellezza. Questo concetto può nascondersi sotto diversi nomi. Si riconoscerà a Dave Hickey, il critico d’arte che si fa oggi il campione di questo ritorno alla norma, il merito di chiamare gatto un gatto. Nel suo testo “The invisible dragon. Four essays on beauty”(6), Hickey resta piuttosto vago sul contenuto di questa nozione. La definizione più precisa è la seguente: si tratterebbe della “composizione che causa il piacere visivo nello spettatore; e ogni teoria dell’immagine che non si basa sul piacere dello spettatore pone la questione della propria efficacia, e si condanna all’insignificanza”.
Si possono notare qui due nozioni: a) l’efficacia, b) il piacere. Se tiro le conclusioni necessarie da questa proposizione, un’opera d’arte si avvera dunque insignificante se non è efficace e se non si rivela utile (cioè se non procura una certa quantità di piacere) ai suoi spettatori. Quali che possano essere i miei sforzi per evitare paragoni spiacevoli, necessariamente non posso evitare di constatare che questo tipo di estetica costituisce un esempio di morale reagano-thatcheriana applicata all’arte. Da nessuna parte Hickey interroga la natura di questa “composizione” che procura piacere: considera naturali le nozioni di simmetria, armonia, sobrietà, equilibrio, per dire i pilastri del tradizionalismo estetico, che fondano altrettanto i capolavori del Rinascimento quanto quelli dell’arte nazista?
Hickey apporta comunque alcuni elementi: si vede meglio a che cosa si riferisce quando scrive che “la bellezza vende”. L’arte, aggiunge, non si confonde con l’idolatria o la pubblicità, ma “gli oggetti di culto (idolatry) e la pubblicità sono certo arte, e le migliori opere d’arte hanno sempre e inevitabilmente un po’ di entrambi”(7). Non avendo nessun gusto né per l’uno né per l’altra, lascio all’autore la responsabilità dei suoi testi.
Per tornare alla questione della bellezza in arte, o a ciò che ne fa le veci, le posizioni “istituzionaliste” di Arthur Danto (per il quale c’è Arte quando l’istituzione “riconosce” un’opera) mi appaiono, rispetto a questa ondata di irrazionalismo feticista, più conformi all’idea che mi faccio del pensiero. La “natura” reale della composizione detta Bellezza da Hickey è estremamente relativa, poiché sono la negoziazione, il dialogo, l’attrito culturale, lo scambio dei punti di vista, ad elaborare generazione dopo generazione le regole che reggono il gusto. La scoperta dell’arte africana, per esempio, modificò profondamente i nostri canoni estetici, attraverso una serie di mediazioni e discussioni. Ricordiamo che alla fine del XIX secolo El Greco era materiale per rigattieri, e che non esisteva “vera” scultura tra l’antichità greca e Donatello. Ma il “criterio istituzionale” caro a Danto mi sembra anch’esso un poco limitativo: in questa lotta incessante per definire il campo dell’arte, diversi altri attori mi sembrano entrare in gioco, dalle pratiche “selvagge” degli artisti fino alle ideologie dominanti.
In Felix Gonzalez-Torres si trova tuttavia un’aspirazione a ciò che Hickey chiama bellezza: una ricerca permanente della semplicità, di un’armonia formale. Diciamo un’immensa delicatezza, questa virtù insieme visiva e morale. Mai il minimo sovraccarico, la minima insistenza su un effetto: la sua opera non aggredisce né l’occhio né i sentimenti. Tutto vi è implicito, discreto e fluido, all’opposto di ogni concezione cosmetica e bodybuilding dell’”impatto visivo”. Gioca in permanenza sui clichés, ma essi rivivono tra le sue mani: la vista di un cielo nuvoloso, o la fotografia di una spiaggia stampata su carta satinata, tutto fa impressione quando lo spettatore potrebbe essere infastidito dal suo lato kitsch. Gonzalez-Torres interviene su emozioni inconsce: vengo così colto da una meraviglia infantile di fronte ai colori cangianti e brillanti del mucchio di caramelle. L’austerità degli “stacks” si vede controbilanciata dalla loro fragilità, precarietà.
Si potrebbe obiettare che l’artista gioca qui su emozioni facili; che niente è più comune, dopo Boltanski, di queste estetiche che virano presto al ricatto affettivo. Ma quello che conta è ciò che si fa di questo tipo di emozioni; verso che cosa le si dirige, come l’artista le organizza tra di loro, e con quali intenzioni.
1) Cornélius Castoriadis, “La montée de l’insignifiance”, Seuil, Parigi 1996, p. 89.
2) Dal catalogo della mostra al Guggenheim Museum, New York 1995, p. 192.
3) Ivi, p. 73.
4) Michael Fried, “Art and Objecthood”, in Gregory Battcock (a cura di), “Minimal art: a critical anthology”, Dutton, New York 1968, p. 127.
5) Si possono consultare a questo proposito i lavori di Michel Maffesoli, soprattutto “La Contemplation du monde”, Grasset, Parigi 1993.
6) Dave Hickey, “The invisible dragon. Four essays on beauty”, Art issues, Los Angeles 1995, p. 11.
7) Ivi, p. 17.
Nicolas Bourriaud è redattore della rivista “Documents sur”; ha curato diverse esposizioni e pubblicato nel 1998 il volume “Esthétique relationnelle” (Les presses du réel), raccolta dei testi più importanti della sua attività critica, da cui anche il presente è tratto. Traduzione di Elio Grazioli.


