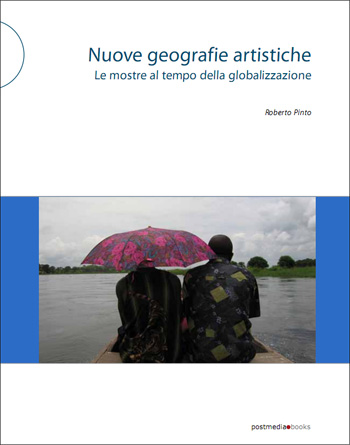UnDo.Net: Da dove sei partito e perché hai sentito l’esigenza di scrivere questo saggio?
Roberto Pinto: Il libro nasce dall'esigenza di ricollegare due parti del mio lavoro, dato che negli ultimi tempi mi sono dedicato maggiormente allo studio e all'insegnamento nelle Università mentre nel passato avevo dato più spazio alle attività curatoriali.
La scrittura del saggio è stata l'occasione di unire entrambe le esperienze usando gli strumenti dello storico per leggere la contingenza, ciò che è successo e che ho in parte contribuito a fare.
L'obiettivo era analizzare l'attuale panorama espositivo in cui convivono artisti con differenti provenienze geografiche e culturali. Fino a trent'anni fa si definivano “internazionali” quelle esposizioni a cui partecipavano artisti provenienti da Francia, Germania, Inghilterra e Stati Uniti, ma ora il panorama è profondamente cambiato. Analogamente a ciò che succede nelle altre discipline - possiamo vedere film coreani, indiani, si leggono libri di scrittori sud africani, o colombiani - anche nell'arte il panorama è molto più aperto.
Negli ultimi cinquant'anni in campo artistico si sono verificate una serie di trasformazioni: prima fra tutte la trasformazione del mondo di esclusiva (o quasi) pertinenza maschile tramite una lento e progressivo aumento (anche in termini numerici) delle presenze femminili; successivamente abbiamo assistito a un'apertura nei confronti di opere provenienti da culture diverse da quella occidentale.
Tali cambiamenti, necessariamente, rimettono in discussione una serie di categorie che eravamo abituati ad applicare.
UnDo.Net: Il titolo del libro è "Nuove geografie artistiche. Le mostre al tempo della globalizzazione": cosa intendi per globalizzazione nell'ambito delle geografie artistiche?
R.P.:
Con 'globalizzazione' intendo quel fenomeno di accelerazione di informazioni, di contatti e di economie avvenuto negli ultimi trenta quarant'anni.
Non è un termine che uso volentieri e forse in ambito artistico risulta molto condizionante. Allo stesso tempo era quello che più si avvicinava agli argomenti di cui volevo occuparmi, anche se, ripeto, "globalizzazione" ha una connotazione negativa (che in parte è del tutto legittima), fa venire in mente una sorta di uniformità che in realtà non corrisponde esattamente alla attuale situazione. In ogni caso non ho trovato un termine sostitutivo che mi sembrasse più adatto.
UnDo.Net: Scrivi che “a una produzione artistica globale spesso non fa riscontro una storia dell'arte che analizza gli artisti del mondo intero e i loro riferimenti culturali” Cosa intendi quando parli di “categorie di analisi delle opere”? E in che modo andrebbero riviste?
R.P.:
Il discorso è complesso. Siamo abituati a leggere le opere secondo un'iconografia, un valore simbolico che trova i suoi riferimenti culturali nella storia dell'arte occidentale.
Usiamo abitualmente categorie, strutture di pensiero e di lettura delle immagini, che rispondono al nostro uso delle immagini, alle nostre abitudini, le quali sono anche influenzate dalla funzione che storicamente hanno avuto per il cristianesimo.
Risentiamo tutti di questa forte impronta simbolica e leggiamo le immagini secondo categorie ben determinate. Però, guardando le immagini prodotte da Ai Weiwei piuttosto che da Pascal Martin Tayou, le categorie da usare dovrebbero essere un riviste, innanzitutto perché si riferiscono a simboli che non provengono dal nostro contesto culturale, e probabilmente concepiscono l'arte in modo parzialmente differente dal nostro.
Certamente l'arte contemporanea, così come la si conosce, è strettamente legata alle forme che questa replica all'interno di un contesto di partenza occidentale.
UnDo.Net: Secondo te quanto i curatori di biennali e mostre internazionali sono interessati al pubblico delle persone che abita i luoghi dove si svolgono e quanto invece si rivolgono all'elite del sistema?
R.P.:
Tutti si rivolgono all'elite, qualcuno ogni tanto si ricorda che magari il contesto non accetta le imposizioni curatoriali. Un esempio eclatante è stato la seconda Biennale di Johannesburg, curata da Okwui Enwezor nel 1997, a tre anni dall'elezione a presidente di Nelson Mandela.
Secondo me è stata una delle mostre che ha rispecchiato gli aspetti più interessanti della globalizzazione poiché voleva davvero essere espressione del cambiamento, voleva raccontare storie diverse, leggere in modo politico le trasformazioni in atto.
La mostra aveva tutto ciò che a noi qui poteva sembrare interessante; invece è stata una delle meno visitate in assoluto. Le persone e gli intellettuali del posto leggevano la mostra come aliena non in grado di interagire con il contesto, una espropriazione di territorio, non un arricchimento.
Tutto questo per dire che anche Okwui Enwezor - una delle persone più attente nel panorama internazionale sia agli intrecci tra arte e politica che all'idea di globalizzazione e alle narrazioni legate alla migrazione - in realtà nella mostra parlava di sé stesso e dell'elite internazionale.
In un certo senso ha fatto quello che tutti i curatori attualmente fanno: mettersi in mostra, far vedere di essere più bravi degli altri, ma non dialogare, non prender coscienza del fatto che si sta parlando ad un contesto, a delle persone, non solo ai curatori e agli artisti internazionali.
Il curatore dovrebbe capire che ciò non esaurisce il suo ruolo, perché di fatto si trova a spendere un sacco di soldi pubblici, soldi che appartengono alla comunità.
UnDo.Net: Riguardo a questo si sentono fare discorsi legati all’economia locale, all’indotto...
R.P.:
Sì, ma sono tutti discorsi un po' falsi per esempio Documenta porta centinaia di migliaia di persone (in quest'ultima edizione si è parlato di 850.000) a Kassel, ma l'investimento di oltre 20 milioni di euro è gigantesco...
Vorrei, però slegare il discorso dal problema economico puro e semplice perché con questa logica si dovrebbero chiudere i musei e le mostre visto che non fanno direttamente economia. Secondo me tutti gli eventi culturali hanno una economia "di ritorno", cambia la qualità del pensiero che scaturisce da un ambiente più stimolato e più fertile, e questa qualità non è quantificabile né in numeri né in biglietti strappati.
Nel libro cito un caso che ha studiato una mia studentessa per fare la tesi di Laurea e si tratta di Manifesta svoltasi in Trentino e in Alto Adige nel 2008. Analizzando i dati si evince che le provincie di Trento e di Bolzano hanno speso per ogni persona che è entrata nella mostra più di 100 Euro.
È un investimento folle se non a questi eventi non viene data continuità.
UnDo.Net: A proposito di questo, secondo te quali sono i fattori di successo di Documenta? La durata, il luogo, le politiche culturali?
R.P.:
Documenta è stata per certi aspetti un perfetto meccanismo di rilancio della Germania. La rassegna è iniziata nel '55 quando il territorio doveva dimenticare sia i 12 anni hitleriani durante i quali (solo per parlare dell'ambito culturale) era stata chiusa la Bauhaus, inventata l'arte degenerata, dati al rogo i libri, erano state organizzate mostre che riflettevano anche sul piano culturale la politica nazista eliminando il dissenso o ciò che si discostava dall'ideale ariano tedesco.
Documenta cercava di riconnettere con l'Occidente il ricco tessuto delle avanguardie tedesche dove era proliferata un'arte politica molto interessante con la scuola di Monaco - già fertile a cavallo fra Ottocento e Novecento - dove è nata una Scuola Astratta, l'Espressionismo e il Dadaismo...
D'altra parte Kassel era vicinissima al confine tra primo e secondo mondo, cioè tra capitalismo e socialismo. Documenta ha dimostrato come l'arte astratta avrebbe potuto essere vicina all'ideale individualista occidentale.
Ha funzionato perfettamente anche perché, come i tedeschi sono bravi a fare, Documenta è diventata immediatamente un'istituzione. E' diventata subito credibile, una mostra sulla quale era possibile lavorare per cinque anni.
I risultati sono legati alle ricerche svolte dai singoli curatori ma tutti, a partire dagli stessi tedeschi, si sentono in dovere di andare a visitarla.
UnDo.Net: Mostre e biennali internazionali hanno un tale ritmo che gli stessi curatori se ne occupano in modo convulso. Come fanno i curatori a curare se non hanno più tempo di studiare medicina?
R.P.:
A volte non si ha nemmeno il tempo di scrivere un testo decente per spiegare cosa si sta facendo. Allora a cosa serve tutto questo meccanismo? Spesso ad alimentare il mercato e questo, alcune volte, può essere positivo, soprattutto per gli artisti che hanno più occasioni per sviluppare nuovi lavori e ricerche, ma d'altra parte sembra uno spettacolo che si autoalimenta e che è fine a se stesso.
UnDo.Net: Recentemente abbiamo pubblicato una ricerca dal titolo Mostramania basata sull'analisi delle mostre del 2009 e 2011 in Italia. Tra i molti dati emersi quello più interessante è che il numero delle mostre sembra crescere in modo esponenziale nonostante la crisi. Inoltre in Italia si fanno più mostre d'arte contemporanea rispetto al passato perché questa costa meno. Cosa ne pensi?
R.P.:
L'arte contemporanea è quella che costa di meno ma aggiungerei che, mancando studi e analisi serie, qualsiasi persona si sente in diritto di farla.
Nessuno affiderebbe una mostra su Botticelli a qualcuno che non sia un esperto, ciò non è garantito in Italia, anche su artisti importanti del contemporaneo. Poi più vai fuori dalle grandi città e più ti rendi conto che ognuno fa quello che gli pare.
Esistono mostre di dilettanti allo sbaraglio che costano tantissimo, con cataloghi imponenti, e altre mostre curate molto bene a costi pari quasi a zero. È veramente il caos, qualunque cosa può andare perché purtroppo non ci sono i riferimenti adatti: come ad esempio degli studi appropriati o istituzioni di riferimento.
UnDo.Net: Quando hai presentato recentemente il tuo libro a Milano hai invitato a parlare Ivan Bargna, un antropologo. Che contributo ha dato alle tue riflessioni?
R.P.:
Mi interessava uno sguardo trasversale. Leggere l'arte, soprattutto quella contemporanea, con uno sguardo antropologico significa legare l'artista a un sistema di valori culturali e sociali. Nello scrivere questo libro mi è capitato di sentirmi inadeguato improvvisandomi sociologo o antropologo nonostante abbia tentato di studiare con attenzione la materia.
Credo che il libro abbia dei difetti perché è costruito su un territorio un po' scosceso: non è solo critica d'arte, ma cerca di non dimenticare uno sguardo antropologico, sociologico o politico.
Quindi sono contento di confrontarmi con studiosi di altre discipline, nella presentazione al MART ad esempio, ci sarà una storica dell'arte, Alessandra Galizzi, insieme a Claudio Giunta, uno specialista di Dante.
Francamente sono un po' stanco di fare riferimento al solo sistema dell'arte, sarebbe utile aprirsi e cercare il dialogo con qualcuno che usa strumenti diversi, a maggior ragione se si tratta di persone che frequentano il campo.
Roberto Pinto è curatore indipendente e storico dell’arte. È ricercatore di Storia dell’arte contemporanea presso l’Università di Bologna. È stato caporedattore di Flash Art e ha curato mostre come la Biennale di Gwangju (2004), la Biennale di Tirana (2005), Subway (varie sedi, Milano, 1998), Transform (varie sedi, Trieste 2002), Spazi Atti (Pac, Milano, 2004), Dimensione Follia (Galleria Civica, Trento, 2004), Confini (Man, Nuoro, 2006). Ha curato le otto edizioni del programma di incontri e conferenze La generazione delle Immagini (Accademia di Brera e Triennale di Milano) e le relative pubblicazioni. Tra i suoi libri, si segnala Lucy Orta, Phaidon Press, London 2003. Dal 2004 al 2008 è stato curatore del Corso Superiore di Arti Visive della Fondazione Ratti, Como.
Le foto pubblicate in questa pagina sono di Mario Gorni