L'edicola digitale delle riviste italiane di arte e cultura contemporanea
Nero Anno 7 Numero 22 inverno 2010
When Franco met Cesare
Franco Vaccari e Cesare Pietroiusti

free magazine
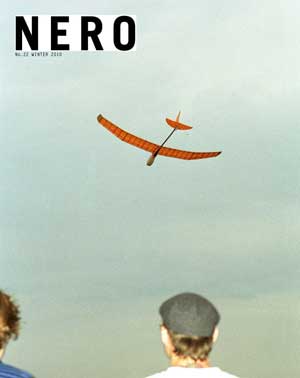
Crackers
A methodist to my madness
Pantheon Electronique
Trofeo vivo,trofeo morto
White Dogg
When Franco met Cesare
A White wedding
Bulletin n. 9
Artist Project
Giulia Piscitelli
Ruins of exhibitions
n. 34 primavera 2014
Exercises in coherence
Amelia Rosselli
n. 33 inverno 2014
Ruins of exhibitions
n. 32 estate 2013
Ruins of exhibitions
n. 31 inverno 2013
Exercises in coherence
Dario Bellezza
n. 30 autunno 2012
Body Builders
Walter Siti
n. 29 primavera-estate 2012

Esposizione in tempo reale n.4.
Lascia su queste pareti una traccia fotografica del tuo passaggio
1972/1994, XXXVI Biennale di Venezia
black&white silver print selenium

Difetti normali, 2001
photographic prints on aluminium
courtesy the artist

Difetti normali, 2001
photographic prints on aluminium
courtesy the artist
Ci sono persone che colleghi automaticamente, in modo così automatico che quasi ti sembra banale. Per esempio Cesare Pietroiusti e Franco Vaccari. Intanto perché tutti e due sono artisti italiani, seppur di generazioni completamente diverse. Poi per l’attitudine: Pietroiusti prosegue da circa vent'anni la sua ricerca artistica legata al quasi totale annientamento dell’opera d’arte ‘finita’ e alle problematiche e ai paradossi insiti nelle relazioni sociali o nelle azioni quotidiane. Vaccari è stato uno dei primi ad usare la fotografia con fini non-fotografici e ad includere in modo coerente l’elemento del ‘tempo reale’ nell’opera d’arte. Ha prodotto anche alcuni tra i più bei libri d'artista degli anni '70. Il peso del loro lavoro è secondo noi ancora sottovalutato, soprattutto al di fuori del paese d’origine. A Cesare e Franco li accomuna anche la formazione scientifica e la profonda stima reciproca. Sfidando il freddo, siamo andati con Cesare a Modena, nel nord Italia, per farli chiacchierare, in una specie di pellegrinaggio tra la casa di Franco e i diversi bar chiusi per le vacanze di natale.
Cesare Pietroiusti: Ci siamo conosciuti a metà anni '90 e, all’epoca, del tuo lavoro conoscevo solo quello che avevi fatto alla Biennale del 1972, per averlo visto su libri e cataloghi, nonché Bar Code, che avevi presentato alla Biennale del ‘93.
Franco Vaccari: Quella del 1972 fu una mostra fondamentale per me. Era la Biennale curata da Barilli e Arcangeli. Il tema era “Opera o comportamento”. Barilli curò la parte dedicata al comportamento.
CP: Che era la sezione in cui eri tu. Barilli sapeva già quale opera avresti esposto, quando ti invitò?
FV: No, però aveva visto una mia mostra l’anno precedente, una cosa apparentemente semplice, ma dove in pratica c’era già dentro tutto.
CP: Che cos’era?
FV: Dovevo fare una mostra alla Galleria 2000, a Bologna. Feci il viaggio in treno da Modena a Bologna, seguito da due fotografi che, con la Polaroid, documentavano il mio viaggio. Arrivato in galleria esposi le foto mentre i fotografi continuavano a scattare, durante l’allestimento, e anche durante l’inaugurazione. Così le polaroid aumentavano di minuto in minuto sulla parete. Io mi limitai a mettere il biglietto d’andata e ritorno del treno dentro una teca, ben esposto. Poi, finita la mostra, ripresi il biglietto dalla teca e tornai a casa.
CP: Ecco, questo lavoro mi sembra perfetto per comprendere il tuo concetto di “esposizione in tempo reale”, un concetto che, sin dall’inizio, comprende un importante aspetto performativo.
FV: Per rendere visibile una cosa in modo adeguato, per evitare che venga interpretata in modo equivoco o assimilata a concetti preesistenti, devi avere la parola giusta che la nomini. Per questo, già da allora, mi sono servito della formula “esposizione in tempo reale”, che significava proprio questo: documentare man mano che l’opera è in atto. E l’opera diventa il processo di documentazione di se stessa.
CP: In effetti tutto avveniva (l’opera si faceva) nel luogo e nel momento stesso della mostra, non prima.
FV: Sì, fu così anche nella mostra che feci, sempre in quel periodo, a Firenze. Ero stato invitato ad una collettiva e sono andato lì senza sapere cosa avrei fatto. Quando sono arrivato ho trovato la mostra già allestita, allora ho deciso di ‘parassitarla’. Mi facevo fotografare accanto all’opera di un altro artista e mettevo lì la mia prima polaroid. Poi fotografavo, esattamente dalla stessa posizione, chi andava a vedere la polaroid o l’opera in questione, e attaccavo la nuova foto accanto alla prima foto. In ogni immagine c’era la storia della precedente. Utilizzavo un sistema che raccontava se stesso. Era una cosa semplicissima.
CP: Io una volta mandai, a dei curatori che mi avevano invitato ad una mostra (Democracy! Socially Engaged Art, Royal College of Art, Londra 2000), una lista di istruzioni per creare delle opere. Dissi loro che avrebbero potuto scegliere quali e quante farne, e che avrebbero potuto scegliere come meglio presentarle. Insomma, quando sono arrivato, il giorno dell’inaugurazione, la mostra era già fatta, pronta. Avevano fatto tutto loro, avevano scelto quali opere realizzare, e come esporle. La cosa divertente è che avevano scelto anche cose che io non avevo mai realizzato prima di allora. Era una situazione in cui sia il tipo di lavoro che il modo di esporlo era stato deciso da altri, e io dico spesso – un po’ ci scherzo, ma un po’ ci credo davvero – che si tratta della mia mostra migliore, quella per cui io non ho fatto quasi nulla.
FV: Quando sono venuto a conoscenza del tuo lavoro, ho pensato che ci fosse un grado di libertà ulteriore rispetto al mio. Personalmente mi sono sempre preoccupato di fare una cosa molto semplice, netta, e in un certo senso immediatamente percepibile. Seguo però una dinamica interna, mentre i tuoi lavori mi sembra si basino su un livello di rarefazione ulteriore.
CP: Diciamo che io ho avuto un passaggio cruciale nel mio lavoro, che più o meno coincide con una mostra che feci nel 1991 a Roma. Prima di allora facevo principalmente lavori fotografici, tipo esporre sui muri delle gallerie le foto di quello che c’era dall’altra parte di quegli stessi muri: case private, magazzini, negozi, studi dentistici... Io le chiamavo Finestreed erano come buchi nel muro che consentivano di vedere (grazie al mezzo fotografico) dall’altra parte. Poi, nel 1991, feci un passo ulteriore: portai il pubblico a visitare gli appartamenti situati nello stesso edificio della galleria che ospitava la mostra. Ovviamente la questione era la stessa: una critica alle convenzioni dello spazio-tempo e del ruolo della galleria d’arte contemporanea, ma per la prima volta si inserì un elemento nuovo che riguardava il “qui e ora” della mostra (un po’ come nelle tue “esposizioni in tempo reale”). I visitatori non guardavano più delle fotografie, ma erano invitati a visitare direttamente un luogo. In quel caso ci fu una donna che durante queste visite rimase a casa sua, continuando a fare le sue faccende domestiche, senza fare caso a noi che visitavamo il suo appartamento.
Quest’ultimo elemento (peraltro del tutto imprevisto) per me fu decisivo perché mi fece comprendere come il fatto di esperire una “situazione” fosse più interessante e coinvolgente che guardare un’immagine fotografica. Forse che la rarefazione di cui tu parli sta in questo passaggio oltre il mezzo, oltre la fotografia?
FV: In effetti ho sempre privilegiato la fotografia, ma non è mai stata il centro del mio lavoro. Per esempio quando fui invitato alla Biennale di Graz del 1973, il tema era il video ma io ero contrario alla video-arte. Prima di tutto perchè se uno registra mezz’ora di video poi ci deve essere qualcuno che impiega un’altra mezz’ora per vederlo, e così via. I video sono, nella maggior parte dei casi, strumenti ‘mangiatempo’. In quel periodo c’erano i “cascami” del minimalismo, e così succedeva che i vari video-artisti riempivano quelle mezz’ore con cose veramente noiosissime. Un’artista, per fare un esempio, aveva fatto un video in cui stava sotto una lampadina e si metteva in testa un panetto di burro, aspettando che questo si sciogliesse e gli colasse sul viso. Sembrava non finire più... Tornando a noi, a Graz decisi di fare una cosa che oggi si chiamerebbe video-installazione. Erano due ambienti in comunicazione audiovisiva tra loro. Sulla porta d’ingresso di entrambi c’era scritto “comunicazione segreta”. Entravi in una delle due stanze, ti chiudevi dentro, e stavi in comunicazione con un’altra persona chiusa nell’altra stanza e il pubblico, fuori, non vedeva né sentiva nulla. Una specie di proto chat-line. Sono nati anche degli amori lì dentro. Il titolo era Comunicazione segreta, il sottotitolo Spazio privato/spazio pubblico. Volevo creare eventi che producessero una presa di coscienza in contemporanea all’accadere degli eventi.
CP: Per questo credo sia fondamentale, nella mia esperienza, quel passaggio di cui parlavo poco fa. Come ho detto, negli anni ’80 avevo questa posizione un po’ ideologica sulla critica dello spazio espositivo, del fatto che le gallerie fossero tutte uguali tra loro, e che dietro questa neutralità si nascondessero i meccanismi del mercato. Ma quando feci quella mostra a Roma, successe qualcosa. Il motivo per cui decisi di portare direttamente le persone a visitare gli appartamenti probabilmente era un motivo molto banale: non c’erano i soldi per produrre il lavoro fotografico. Così, per caso, scoprii che, oltre alla dimensione del “vedere” c’era anche la dimensione dell’emozione, della relazione, dell’imbarazzo, della tensione, che derivavano dall’entrare nello spazio privato di altre persone. Da quel punto in poi si è aperto un mondo. Ho capito che era interessante creare delle condizioni...
FV: Sì, l’operazione estetica consiste nello scoprire, nell’entrare dentro dimensioni reali innescando un meccanismo grazie al quale sei portato a conoscere una dimensione della realtà che altrimenti non avresti conosciuto…
CP: …vivendola direttamente, non attraverso documenti.
FV: L’operazione estetica è la produzione di realtà. Che è una cosa diversa, per esempio, dalla performance classica, che è basata sull’esecuzione di un canovaccio preesistente. Ai tempi, tanto più lo eseguivi in modo meccanico ed esatto, tanto più la performance acquistava valore. Prendi Oldenburg: rimase colpito dai camerieri che servono a tavola e che viaggiano tra i tavoli con i piatti in equilibrio sulle mani, così ha trasferito questa suggestione in un ‘canovaccio’. A me invece non interessava questa aderenza così rigorosa alla parte, mi interessava produrre un evento, una realtà che avesse delle sfaccettature inaspettate.
CP: Questo concetto di spazio/tempo e spazio/realtà come nasce in te?
FV: Quasi tutto quello che facevo era una specie di autodifesa da qualcosa che non mi andava a genio. Tu per esempio hai raccontato che ti dava fastidio l’idea di uno spazio costantemente a disposizione degli artisti, incurante e indipendente dal resto. E rispetto a questo probabilmente provavi un senso di malessere, di fastidio. Io ero in polemica con la divisione dello spazio in spazio privato e spazio pubblico, con l’occupazione pubblica degli spazi, con la cosiddetta “arte pubblica”, che ho sempre trovato retorica. Così provai a creare delle condizioni in cui gli spazi pubblici potessero diventare spazi privati, senza per questo sentirmi in colpa. Ad esempio, nella Biennale del 1975, sempre a Graz, il tema era l’identità. In una galleria mi ero fatto costruire uno spazio, tutto colorato con quel colore che si chiama ‘blu dei sogni’. C’era una porta con uno spioncino, attraverso il quale si poteva guardare dentro. Fuori avevo messo un foglietto con scritto: “Quando la galleria sarà chiusa, dormirò in questo ambiente e il giorno successivo esporrò il racconto dei sogni fatti durante la notte”. L’idea era che il mio spazio diventasse agibile quando finiva l’agibilità “pubblica” della galleria. Lavoravo di notte invece di lavorare da sveglio. Mi sembrava il massimo, lavorare dormendo. Il giorno dell’inaugurazione il direttore della galleria mi disse: “Venga che le presento il Capo dello Stato”. Io, nello scarsissimo tedesco che conosco, gli spiegai il lavoro, poi mi misi le mani in tasca, tirai fuori la chiave della porta e gli dissi: “Scusi ma devo entrare nella mia stanza.” Sono entrato, mi sono chiuso dentro, e dall’interno ho fotografato il capo dello stato che mi guardava dallo spioncino. Avevo messo una brandina, un televisore, delle provviste…
CP: Quindi sei rimasto lì diverse notti, non solo una.
FV: Sì, e al mattino esponevo la descrizione dei sogni fatti durante la notte precedente. A Bologna, per la “Settimana della performance” alla Galleria d’Arte Moderna, nel 1977, organizzata sempre da Renato Barilli, scelsi la stanza dove di notte andavano a riposare i guardiani notturni. L’idea originaria era di far esporre ai guardiani i propri sogni, suggellando la mostra con una frase che diceva “I vigili di notte non sono più vigili”. Ma il capo dei guardiani non accettò, allora decisi di andarci a dormire io. La prima notte però non me la sentii. Quando incontrai Barilli, mi disse: “Ma come, avevi detto che saresti andato a dormire e non hai dormito nel tuo spazio performativo??” Io risposi: “Senti Renato… ma secondo te io devo fare i compiti in classe? Non me la sentivo, basta.” Poi, poco dopo, incontrai la Abramovic, che insieme ad Ulay e ad altri era venuta a Bologna con un camper blu. Di notte soffrivano un gran caldo, così le dissi che avevo uno spazio dove avrebbero potuto passare la notte al fresco. Glielo feci vedere e gli piacque molto. Però, dissi, avrebbero dovuto… pagarmi l’affitto: avrebbero cioè dovuto esporre i sogni che facevano. Accettarono. La notte successiva ci dormì un artista francese, Jacques Charlier. Come vedi anche in questo caso non c’era la fotografia.
CP: Questo lavoro con lo spazio espositivo usato per dormirci mi fa venire in mente un lavoro che ho fatto nel 1996, al museo Louisiana di Copenaghen. Un museo molto grande, con tanti servizi per il pubblico (caffetteria, sala computer, auditorium, etc.), molto frequentato dalle famiglie, tutto puntato sull’idea di “museo vivibile”. Così presi la cosa alla lettera, e decisi di viverci per una settimana, non però in una stanza dei servizi, ma in una sala espositiva. Sono stato chiuso dentro, murato, nella sala dove c’erano i quadri di Picasso (che ovviamente erano stati rimossi). Sono rimasto dentro per una settimana, quella precedente all’inaugurazione. Volevo proprio seguire letteralmente questo concetto di vivibilità del museo. E, secondo me, questo punto del prendere una cosa alla lettera è uno dei punti fermi del mio lavoro. Guardare cosa c’è dietro i muri, andare nella casa del vicino, vivere in un museo definito ‘vivibile’: c’è sempre un compito molto semplice.
FV: Credo che in questo ci sia una sorta di filo rosso che contraddistingue gli artisti di Roma. Per esempio uno che ha fatto dei lavori per così dire alla lettera è stato Gino De Dominicis. Pensa a Mozzarella in carrozza… O anche Emilio Prini. Ti devo raccontare un episodio a proposito di Prini. Ero a Torino, nel 1973, per la prima grande mostra italiana che mettesse in rapporto pittura e fotografia, “Combattimento per un’immagine”, alla Galleria d’Arte Moderna. La sera ero in compagnia di Prini ed andammo a casa di Mario Merz. Raccontai che avevo registrato il passaggio dei raggi cosmici attraverso un dispositivo sonoro, con un contatore Geiger. I raggi cosmici sono entità reali, ma niente del nostro apparato sensoriale è in grado di rilevarli. Spiegavo a tutti che siamo attraversati costantemente da questi raggi cosmici, ma che nonostante questo non possiamo rendercene conto, né vederli. E lo sai Prini cosa mi risponde? “Io li vedo”.
CP: Sono curioso di capire se dietro alle tue idee e all’attenzione per l’hic et nunc c’è l’influenza della filosofia, in particolare della fenomenologia esistenzialista - Husserl, Merleau-Ponty ecc.
FV: Per me è stato molto importante leggere, nel 1973, un libro di Allan Watts, all’epoca abbastanza di moda, intitolato Lo Zen. Parlava dello Zen come di un atteggiamento sensibilmente diverso rispetto a quello occidentale. Per la poesia Zen si trattava della presa di coscienza di un istante senza mediazioni concettuali. Allora mi venne voglia di fare poesia Zen. Ma come tutti quelli che avevano tentato di imitarla, facevo solo delle “poesie Zen giapponesi”. Allora ho capito che dovevo utilizzare un altro linguaggio. Ho scoperto che volevo mettere in cortocircuito i miei dati psichici. Volevo evocare contenuti mentali che normalmente non sarebbero emersi. Come guardare una macchia sul muro e vedere un uomo a cavallo. Cominciai a fare delle associazioni mentali non pre-ordinate.
CP: Il concetto di “tempo reale”, il cortocircuito del qui-e-ora, il tentativo paradossale di far coincidere tempo dell’esperienza con quello dell’osservazione, diventano modi di aggirare la predeterminazione.
FV: Si mette in moto un meccanismo. Il mio scopo era quello di utilizzare un meccanismo che disattivasse i miei processi mentali pre-ordinati. Faccio un esempio: nel 1970 sono andato all’Isola di Wight a vedere quello che fu il più grande festival di musica pop in Europa. Mi trovai in una situazione che non corrispondeva a ciò che mi aspettavo, forse perché appartenevo ad una generazione precedente. Così quando mi trovai a documentare quella situazione, capii che avrei dovuto disattivare i miei meccanismi mentali automatici, altrimenti avrei fotografato una cosa per me nuova, con un’ottica vecchia. Decisi allora di fare così: la mattina, appena sveglio, camminare per cento metri e fotografare a destra e sinistra, poi altri cento metri e di nuovo destra e sinistra. E così via. Misi in moto un meccanismo che mi portava a vedere quello che non sapevo, mi faceva andare oltre ciò che conoscevo.
CP: Condivido l’idea che l’intervento completamente consapevole, o perfettamente organizzato, anche da un punto di vista tecnico, sia più un impaccio che una risorsa. Se ti fissi sulla tecnica, ti crei degli ostacoli rispetto al fenomeno che vorresti conoscere. Io credo proprio di essermi formato sull’idea dell’evitamento dell’espressione, che già c’è nella tua generazione come critica all’espressionismo astratto, all’informale. È un tema che mi interessa molto. Anche io vorrei aggirare il meccanismo della predeterminazione e andare a conoscere le cose che non so, ma… senza volerlo. Mi interessa il meccanismo in grado di cogliere gli effetti collaterali. Quella degli effetti collaterali è una mia vera ossessione.
FV: Infatti, come dicevo prima, io credo di essere più incentrato sulla mia persona di quanto lo sia tu. Se noto un grado di libertà maggiore nel tuo lavoro, è perché tu ti apri di più al contesto. Io sono più preoccupato di disattivare certi miei meccanismi automatici, di espandere i limiti della mia azione e del mio pensiero personale.
CP: Secondo me, sotto sotto, in me c’è sempre stata una posizione di negazione della figura stessa d’artista.
FV: Anche per me! Un’altra delle cose insopportabili è proprio il mito dell’artista, del genio dell’artista. La figura dell’artista presentata secondo gli stereotipi contemporanei, come colui che “sa” e che “vede”. Nelle mie mostre succedevano sempre cose che non mi permettevano di perseguire uno scopo pre-ordinato. Definirei questa cosa, che ritengo fondamentale, come ‘dirottamento di progetto’.
CP: Che è effettivamente l’effetto collaterale di cui parlavo prima. Comunque, rispetto al mito dell’artista, secondo me tu non sopporti la cosa che vedi falsa. L’artista che mitizza se stesso è in realtà un artista che rifiuta di mettersi in gioco e rifiuta di mettere in gioco il significato del suo lavoro.
FV: Sono tutti tentativi di azzerare i rischi: usi colori di un certo tipo, ti servi di critici di un certo tipo, con il fine di tenere in piedi questo monumento inesistente. A me interessava un’altra cosa. Ma qui sorge un altro problema: dato che non avevo grandi rapporti con gallerie e istituzioni in genere, come facevo a ricavare la sensazione che ciò che facevo potesse essere interessante? Perché se tu hai delle strutture che ti certificano, ti senti più tranquillo. Io dovevo cercare questa garanzia solo dentro di me, e la misura dell’autenticità, per me, era data dal rischio. Se c’era un rischio autentico, questo mi garantiva che quello che andavo facendo aveva una validità oggettiva…seppure partendo da un’esperienza soggettiva. Volevo correre il rischio: Chris Burden, che si faceva sparare addosso, anche lui amava il rischio.
CP: Quando metti in piedi un meccanismo per cui devono succedere delle cose, c’è sempre qualcosa che non funziona, e la tua sensazione lì per lì è spesso quella di mentire. Però, curiosamente, a vederle a distanza di tempo, ti rendi conto che sono proprio quelle, le cose che ti mettono in difficoltà, che hanno più senso. Potrei citare molti miei lavori: all’Angelo Mai a Roma, 3 anni fa, mi misi a scavare un tunnel nelle fondamenta fino a che non fossi spuntato da qualche parte. Mi ricordo benissimo una sensazione tipo: “Ma io che ci sto a fare qua, che sto facendo??”. Una sensazione di completa assurdità e falsità. Continuavo a scavare solamente perché avevo detto che l’avrei fatto, e c’erano molte persone che erano venute a vedermi, e non capivo come e perché avrei dovuto finire quella performance... A distanza di tempo, questi aspetti sono proprio quelli che ti dicono qualcosa che prima non sapevi. Nel punto in cui ti senti in imbarazzo, ti senti di aver sbagliato, se vai a fondo, scopri la zona più densa di significati.
FV: Io ho fatto solo due cose di cui non butterei via niente. Una è Viaggio + rito (quella del viaggio Modena-Bologna citato prima); l’altra è la Biennale del 1972. In quest’ultima avevo proprio bisogno di correre un rischio. Misi una macchina automatica per foto-tessera e invitai la gente a farsi una fotografia e poi ad attaccarla alla parete espositiva. La macchina automatica era a pagamento, perché credevo che solo attraverso un piccolo sacrificio personale si sarebbe passati dalla virtualità alla realtà. Se fosse stata gratuita, sarebbe stata un’azione completamente virtuale. La sala all’inizio era vuota. Ho fatto la prima foto-strip e poi non sono più intervenuto. Poteva fallire totalmente. L’ambiente era stato criticato perché all’inizio era assolutamente vuoto, ma era vuoto per gli altri. Per me era pieno. Pieno del rischio che stavo correndo. Poi man mano che la gente si faceva le foto e le attaccava, la stanza si riempiva di foto e si svuotava del rischio.
CP: Mi sembra interessante notare come ad accomunarci sia soprattutto la ricerca dell’effetto collaterale o, come lo chiami tu, del dirottamento di progetto, essendo noi due persone con una formazione scientifica, io laureato in medicina e tu in fisica. C’è sicuramente un’organizzazione del pensiero alla base di questa ricerca.
FV: Noi che abbiamo questo tipo di formazione siamo istintivamente portati all’utilizzo di qualcosa che può essere definito ‘metodo’. Da questo punto di vista siamo stati fortunati a nascere in un periodo dove il concetto era particolarmente importante rispetto all’abilità tecnica.
CP: Il pensiero è correlato con l’esperienza, così come il progetto è correlato con l’effetto collaterale o il suo dirottamento. Il pensiero non è mai astratto. La preparazione scientifica si vede nel modo in cui si organizza l’esperimento. Prendi per esempio l’approccio che tradizionalmente si attribuisce a Sol LeWitt: l’idea di poter convertire l’opera in un’istruzione per la realizzazione della stessa. Questa è una definizione dell’opera molto rigorosa, predefinita, che però rifiuta i cosiddetti ‘fenomeni di esecuzione’, cioè gli errori, gli effetti collaterali. Non c’è bisogno di realizzarla perché si verifichi la condizione d’esistenza dell’opera. Per noi invece è come se ci fosse un passo ulteriore. Le istruzioni, ossia il metodo, servono a creare delle condizioni, ma diventa necessario mettere in moto il meccanismo per vedere cosa succede, per andare al di là del pre-determinato.
FV: Un’altra cosa che non ho mai affrontato concettualmente in modo rigoroso è che nelle esposizioni in tempo reale cercavo anche di aprirmi ad un livello di percezione quasi paranormale. Le chiamavo ‘coincidenze straordinarie’. Ve ne racconto una. Ero stato invitato in Slovacchia a fare un progetto in una sinagoga sconsacrata, a Trnava. Mi venne subito in mente quel passo della Bibbia che dice: “Vanità della vanità, è tutto vanità, un correre dietro al vento”. Un pezzo della Bibbia quasi ateo, che non parla di consolazione. Sapevo che per quella vecchia comunità di ebrei non ci sarebbe stata alcuna consolazione rispetto ai mali del passato. Ho pensato alla vanità, e mi sono venuti in mente dei pavoni. Volevo liberarli nello spazio della sinagoga, ma credevo potesse essere considerata una provocazione, e non sapevo se era il caso di dirlo agli organizzatori. Poi ho visto che c’erano delle lampade che avevano la forma di un pavone, così mi sono convinto che dovevo farlo. Poi, tornando verso la casa in cui ero ospite, vidi che nel cortile c’erano dei pavoni liberi. Infine, sebbene ci furono delle complicazioni, vicino Modena trovai casualmente un altro allevamento di pavoni. Insomma, erano coincidenze, ma straordinarie.
CP: Anche io sono molto interessato a questo tipo di fenomeni, anche se do loro un accento diverso. Nel senso che penso più al concetto di ‘contemporaneità’ come sincronicità degli avvenimenti. Nella vita di un artista succede che c’è la tendenza a dire che un certo lavoro è fatto, compiuto, che appartiene al passato ed ha una certa data. Mentre io considero sempre ciò che ho fatto come un lavoro ancora non finito, non-fatto. Se hai questa attitudine, in un certo senso torni costantemente a concetti presenti in lavori precedenti e i lavori stessi tornano nella produzione attuale. È come se ci fosse una compresenza dei fenomeni per cui, a posteriori, acquisiscono senso anche cose che in un certo momento non l’avevano. Come se i fenomeni, le opere, si spostassero nel tempo e fossero sempre, potenzialmente, tutte qui, adesso.
FV: Un altro problema è che siamo abituati a partire sempre dalla posizione dell’artista, trascurando il punto di vista dell’osservatore. Se uno produce senso compie un lavoro, ma lo anche chi decodifica quel segno compie un lavoro. Gli artisti sono tanti, tutti propongono un loro punto di vista, ma io perché devo stare a guardare? Il problema non è più quello della figura dell’artista, del genio. Forse si dovrebbe creare il mito dello spettatore-genio, il genio di chi guarda e capisce le opere.
CP: L’artista secondo me rende valido un lavoro non soltanto quando lascia un segno la cui decodifica è possibile, ma soprattutto quando lascia la sensazione di una possibilità, in modo che chiunque entri in contatto con l’opera abbia la sensazione di potervi includervi il proprio pensiero, di poterne essere ospitato tanto quanto di ospitarlo. Solo così una cosa si apre al di là del contenuto, e ti lascia l’esperienza che la libertà è possibile.
FV: Ti apre degli orizzonti, come quando da piccolo leggevo dei libri che mi colpivano molto, come il Rosso e il nero, e mi veniva immediatamente una strana e inarrestabile frenesia di scendere in strada, per vivere quelle sensazioni, per viverle nel luogo dove avvenivano le cose.
CP: Esattamente.


