L'edicola digitale delle riviste italiane di arte e cultura contemporanea
Juliet Anno 35 Numero 173 giugno-luglio 2015
Adrian Paci
Maria Vinella
Sguardo politico
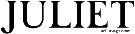
Art magazine

COPERTINA
Emilio Isgrò “Il Seme dell’Altissimo”, opera scultorea in marmo bianco, installata
all’ingresso Ovest dell’Expo di Milano, davanti al Padiglione Zero
(courtesy Archivio Emilio Isgrò, Milano; ph Andrea Valentini)
Intervista
42 | Emilio Isgrò. Cancellazione e Restauro / Luciano Marucci
46 | Luca Maria Patella. Tra Identità e Totalità / Luciano Marucci
54 | English Breakfast [16]. Lee Marshall, BSL Song-Signer / Matilde Martinetti
62 | Driant Zeneli. When Dreams... / Giulia Bortoluzzi
68 | Robert Inhof / Roberto Vidali
72 | Adrian Paci. Sguardo politico / Maria Vinella
75 | Leone Contini. Imagined Menu / Paola Bonino
77 | MCDA (Marche Centro D’arte) 2015. Intervista a Lino Rosetti / Nikla Cingolani
Focus
50 | Xing Danwen. Ambiguità e utopia / Emanuela Zanon
Fotocronaca
52 | Fotocronaca 56. Biennale / Luciano Marucci
Recensione
56 | Arcangelo Sassolino. Le materie e l’uomo / Caterina Flor Gümpel
60 | Dario Ghibaudo. Il museo di storia innaturale / Patrick Amine
70 | Contro l’infelicità / Ernesto Jannini
71 | Il carico della libertà / Liviano Papa
76 | Nelle trame del tempo / Eleonora Fiorani
74 | Alberto Di Fabio. GeograficaMente / Luciano Marucci
78 | Agnese Purgatorio. Orizzonti nomadi / Lucia Anelli
79 | Hanna Preuss. “Pavana per Antigone” / Maria Campitelli
REPORTAGE
58 | Anarchia a Mendrisio! / Emanuele Magri
Presentazione
64 | Collezionare per il possesso / Liviano Papa
Focus
66 | Vi racconto Colorfood! / Eleonora Garavello
69 | Workevent. Business Plan / Sara Bidinost
Fotoritratto
73 | Andro Merkù / Fabio Rinaldi
85 | Chiara Badinella e Fabrizio Affronti / photo by Luca Carrà
Rubrica
80 | Arte preziosa. Riccardo Zancano / Rosetta Savelli
81 | P. P.* Marco Pierini / Angelo Bianco
82 | Ho Del Museo… / Angelo Bianco
83 | Catherine Morris. Through feminist Lenses / Leda Cempellin
84 | Giovanni Puiatti / Serenella Dorigo
spray
86 | Recensione mostre / AAVV
91 | “Zero peso specifico?” / Pino Boresta
Case chiuse, corpi aperti
Roberto Borghi
n. 172 aprile-maggio 2015
Yang Xinguang e la materia
Sara Bortoletto
n. 171 febbraio-marzo 2015
Eugenio Re Rebaudengo
Giulia Bortoluzzi
n. 170 dicembre-gennaio 2015
Biennale Architecture
Gabriele Pitacco Marco Gnesda
n. 169 ottobre-novembre 2014
Biennale Marrakech
Emanuele Magri
n. 168 giugno-luglio 2014
Andreas Zingerle
Gianluca Ranzi
n. 167 aprile-maggio 2014



Adrian Paci, l’artista albanese che vive a Milano, è, dagli anni Novanta, tra i protagonisti della scena internazionale. Il problematico contesto dell’Albania post-comunista, il conseguente abbandono del proprio paese, sono stati punto di partenza per l’elaborazione di una ricerca originale, espressa con diversi linguaggi. Il vissuto personale, segnato dalle dinamiche del viaggio e dello sradicamento, incrocia non solo un vissuto storicamente condiviso, ma anche il senso più ampio di precarietà della condizione umana contemporanea. I suoi lavori hanno un carattere narrativo e si basano sulla forza icastica dell’immagine. Le visioni di Paci si affidano ai temi correnti del transito, della lontananza e dell’attraversamento, e, pur sviluppandosi dalla propria personale vicenda autobiografica, assumono un carattere universale.
Adrian, qual è la storia della tua vicenda artistica a partire dalla formazione in Albania sino a quando ti stabilisci in Italia?
Ho studiato in Albania quando c’era il regime comunista, e l’unica arte possibile si chiamava “Realismo socialista”. Lo studio era incentrato solo sui classici e arrivava fino agli Impressionisti: tutto ciò che c’era dopo veniva considerato arte degenerata. Così, per liberarci del diktat figurativo, molti di noi incominciarono a fare pittura astratta. Nel ‘92 venni in Italia, a Milano, con una borsa di studio e cercai di comprendere quale fosse la scena artistica contemporanea. Andando nei musei mi resi conto però che le cose che facevo erano già state realizzate negli anni Cinquanta. Così i primi anni italiani per me furono di confusione. Nel ‘95 rientrai in Albania per insegnare, ma ai miei studenti, più che risposte, offrivo delle domande. Poi, nel ‘97 sono tornato definitivamente in Italia con la mia famiglia.
I tuoi primi video traevano spunto dalla narrazione di quella realtà? Come nasce il tuo interesse per la videoarte? Mi riferisco soprattutto ad “Albanian stories”.
L’idea mi venne un giorno a casa, ascoltando mia figlia di tre anni che raccontava fiabe alle sue bambole. Nei suoi racconti la voglia di divertirsi, di inventare storie e personaggi, si univa ai ricordi della guerra che noi tutti avevamo vissuto in Albania. Riconobbi la forza di queste storie, capaci di mettere insieme memorie di vita vissuta con la leggerezza di un gioco, i fatti reali con la finzione. Però non avevo un mezzo mio artistico con cui affrontarle. Allora chiesi a un amico una telecamera, e a mia figlia di raccontare davanti ad essa le sue storie. Non c’era un’esigenza di fare videoarte, ma semplicemente di dare testimonianza a questi racconti. Nacquero così “Albanian stories”, un lavoro privo di qualsiasi intervento di editing e che io considero molto importante.
Qual è il processo che dai primi video, dove la parola è protagonista, porta ai lavori dove tutta la narrazione è affidata alla forza delle immagini? Penso a “The Column”, del 2013, presentato in anteprima al parigino Palais de Tokyo e poi al Pac di Milano e poi in altri posti ancora...
La storia nasce da una circostanza casuale: dal racconto di un amico che stava restaurando un castello. Il proprietario voleva ripristinare una fontana, ormai scomparsa. L’amico scoprì che la scultura si poteva rifare prendendo la pietra in Cina e facendola scolpire in nave durante il viaggio. Per me, l’idea di una scultura che si può scolpire nell’oceano durante il trasporto, aveva qualcosa di favoloso e visionario. Così, verificai che esistono navi-fabbrica in cui il tempo del trasporto coincide con quello dell’esecuzione. Dovendo fare una mostra a Parigi e in altri musei, ho insistito per riuscire a produrre questo progetto. Ho scelto una colonna, una forma semplice ma anche ricca di significati: la stabilità, il potere, la forza della verticalità. Una verticalità che, quando la colonna è sdraiata, come nel mio lavoro, diviene simbolo d’impotenza.
Come nasce la performance del 2011 realizzata a Scicli, in Sicilia, che ha uno sguardo più “antropologico”?
In questo caso, volevo indagare le potenzialità della stretta di mano e creare intorno a questo gesto un rituale. Dare la mano è un gesto molto antico che ci accompagna in diversi riti e nella quotidianità. Pensando all’importanza della piazza soprattutto nel Sud Italia, ho voluto mettere in scena questo gesto, sistemando al centro una sedia dove dapprima rimango seduto in silenzio. Poi mi alzo in piedi e c’è una folla di persone, una comunità che viene verso di me: circa settecento persone che si mettono in fila, passano davanti all’artista e attivano il gesto. Così nel momento stesso in cui pensavo al gesto ho riflettuto sulle varie stratificazioni del senso della stretta di mano, ai significati che questo gesto porta con sé, e ho elaborato l’immagine di questa scena, con una circolarità di persone che continuano a camminare lasciando però sempre lo spazio uguale.
Adrian, tu hai sempre dipinto, affiancando una figurazione rarefatta all’uso prevalente di altri linguaggi. Nelle ultime mostre hai esposto opere pittoriche, disegni, mosaici. Che progetti hai in mente per il prossimo futuro?
Ho appena inaugurato una mostra ad Atene nella galleria Kalfayan con due lavori nuovi e una doppia personale al MAXXI con un mio amico, il regista Roland Sejko. Il progetto del MAXXI prende spunto da centinaia di lettere trovate nell’Archivio di Stato albanese, scritte da italiani rimasti bloccati in Albania dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale e mai consegnate al destinatario. Con Roland abbiamo portato alla luce queste lettere e, attraverso un lavoro di finzione, abbiamo cercato di dare loro volto e voce.
MARIA VINELLA critico d’arte e curatore. Insegna presso l’Accademia di Belle Arti di Bari. Autrice di testi e ricerche che coniugano storia dell’arte contemporanea e pedagogia della creatività.

