L'edicola digitale delle riviste italiane di arte e cultura contemporanea
Millepiani Anno 14 Numero 32 aprile 2007
Geografie del concetto ed esercizi di libertà nell’età della tecnica
Ubaldo Fadini
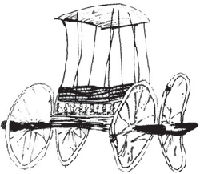
Filosofia, estetica e politica

• Gilles Deleuze
Contro i “Nuovi Filosofi” p. 7
• Saskia Sassen
Intervista a cura di Thierry Paquot p. 17
• Tiziana Villani
Ecosofia p. 31
• Thierry Paquot
Tre, quattro, cinque ecologie! p. 43
• Ubaldo Fadini
Geografie del concetto ed esercizi di libertà nell’età della tecnica p. 53
• Manola Antonioli
Nuove cartografie del senso p. 65
• Saverio Caponi
Il nido e l’uovo p. 79
• Silvano Cacciari
Logica del senso e ricezione americana p. 93
• Viviana Verdesca
La danza delle caoidi sulle tavole del senso p. 105
• Alessandro Rudelli
Senso eventuale p. 121
• Simone Biagini
Il marketing nei territori dell’infanzia p. 137
• Margherita Pascucci
Il senso p. 153
• Paolo Godani
à la lettre
Per François Zourabichvili p. 167
artefacts
• Antonio Del Guercio
Ernest Pignon-Ernest: un’arte in situ p. 175
• Giulio Angelucci
Esilio e permanenza p. 178
• Recensioni & schede di lettura p. 181
La macchina del senso
Nicola Lonzi
n. 40 novembre 2013
Ontologia e praxis istituzionale
Ben Matsas
n. 39 novembre 2012
L'uscita dal futuro
Tiziana Villani
n. 37 novembre 2011
Deep Ecology ed ecosofia
Silvano Cacciari
n. 36 novembre 2010
Il Fuori della Filosofia. Crisi di senso, vero dire e umorismo
Tiziana Villani e Ubaldo Ladini
n. 35 novembre 2009
Cittadinanza radicale nella repubblica della tecnologia
Darin Barney
n. 34 ottobre 2008

Epidemie-Napoli 1990
Serigrafia

Lyon-Les cabines 1996
Serigrafia

Torso 589674
olio su tela 100x70, 2006
Il punto di partenza di questo mio contributo è dato da un testo recente di Tiziana Villani – Il tempo della trasformazione. Corpi, territori e tecnologie – che mi permette di sottolineare come la riflessione filosofica sia stata spesso attenta, anche per ragioni che attengono alla sua specificità, al motivo dell’urbano. Oggi si tratta di fare soprattutto i conti, anche rispetto alle mutazioni del tessuto urbano, con quella centralità della progressione tecnologica, in alcuni dei suoi aspetti (forse “ideologicamente” rivestiti e – appunto – “urbanizzati”), che sembra in grado di sussumere le grandi narrazioni otto-novecentesche e di riorientare, in senso quasi “destinale”, il cammino dell’umano. Particolari sviluppi tecnologici si affermano effettivamente nelle modalità di trasformazione dell’abitare odierno in contesti urbani differenti e tuttavia sempre sottoposti alla trionfante logica dell’omologazione. Villani richiama opportunamente, in tale prospettiva, alcune osservazioni critiche di Thierry Paquot: “La civilizzazione moderna unifica il mondo tramite la supremazia delle proprie certezze, ma essa non può appiattire del tutto le specificità che provengono dalle storie particolari. Una civiltà urbana mondiale e delle culture locali sembrano dover coabitare all’interno di specifici rapporti di forza che non sono mai fissi e definiti. Non vi è che un mondo in questo mondo ed esso è popolato dall’Homo urbanus”.1
Le mutazioni del tessuto urbano – delle sue figure – riguarda oggi non soltanto il piano geografico-materiale (com’è ovvio), ma anche quella dettagliata “geografia del quotidiano” che consente di dare corpo al testo richiamato di Paquot, in quanto indica la compresenza di stili di vita differenti, di condotte “neo-tribali”, di processi tecnologici importanti e di sistemi di controllo sofisticati. A ragione Villani osserva come circoli sempre di più, in certi ambiti di “discussione” filosofica (ricordando però che la filosofia non è “perpetua discussione”, come sottolineano G. Deleuze e F. Guattari…), l’idea che i nuovi fenomeni collegati all’urbanesimo non siano semplicemente da indicare alla luce delle dualità tradizionali (centro/periferia, metropoli/provincia, città/campagna), bensì cogliendoli come processi di scomposizione/ricomposizione di identità complesse, di assetti economici e relazioni sociali particolarmente innovativi e originali. Ancora più significativo è il rinvio all’invito – proprio di J. F. Lyotard – di ripensare allora radicalmente il rapporto tra città e filosofia. Non ritengo che le tensioni dell’urbanizzazione dissolvano quel “suo” concetto di un “fuori del pensiero” che starebbe alla base addirittura della metafisica, anche perché di tale “fuori” bisognerebbe forse fornire una figurazione che non lo vincoli a quella “cattiva approssimazione del pensiero” fornita dal soggetto e dall’oggetto: vale qui il richiamo al quarto capitolo (“Geofilosofia”) di Che cos’è la filosofia?, nel quale Deleuze e Guattari sostengono come il pensare non sia “né un filo teso tra un soggetto e un oggetto, né una rivoluzione dell’uno intorno all’altro. Il pensare si realizza piuttosto nel rapporto tra il territorio e la terra”. Sono scontati, in quest’ottica, i rimandi a Kant e a Husserl come filosofi che hanno ribadito il valore di un pensare che è in relazione con la terra, ma particolarmente interessante, negli autori del progetto su “capitalismo e schizofrenia”, è l’idea che la terra operi “un movimento di deterritorializzazione sul posto, attraverso cui supera ogni territorio”. Deleuze e Guattari sottolineano come la terra sia insieme deterritorializzante e deterritorializzata, si confonda con il movimento: “La terra non è un elemento tra gli altri: riunisce tutti gli elementi in un’unica presa, ma si serve dell’uno o dell’altro per deterritorializzare il territorio. I movimenti di deterritorializzazione non vanno disgiunti dai territori che si aprono altrove, né i processi di riterritorializzazione vanno disgiunti dalla terra che restituisce i territori. Il territorio e la terra sono due componenti di altrettante zone di indiscernibilità: la deterritorializzazione (dal territorio alla terra) e la riterritorializzazione (dalla terra al territorio); e non si può dire quale venga prima. Ci si potrebbe domandare in che senso la Grecia sia il territorio del filosofo o la terra della filosofia”.2
È proprio a questo punto della riflessione che si introducono “gli Stati e le Città” in termini meno sbrigativi rispetto alla analisi del fuori e del dentro, dell’esterno e dell’interno, azzerati dall’affermazione “post-filosofica”/“post-moderna” (per così dire…) della “megalopoli”, della “città totale”, della “onnipolis” nel senso delineato da P. Virilio: “Gli Stati e le Città vengono spesso definiti in termini di territorio e ciò quando un principio territoriale si sostituisce al principio di discendenza. Ma non è esatto: i gruppi di una stirpe possono bensì cambiare territorio, ma si determinano effettivamente solo sposando un territorio o una residenza, dando vita a una ‘stirpe locale’. Lo Stato o la Città al contrario operano una deterritorializzazione, perché l’uno stima e misura i territori agricoli in riferimento a un’unità aritmetica superiore, e l’altra adatta il territorio ad un’estensione geometrica prolungabile nei circuiti commerciali. Spatium imperiale dello stato o extensio politica della città non sono tanto principi territoriali quanto deterritorializzazioni, pienamente evidenti allorché lo stato si appropria del territorio di gruppi locali quando la città si svincola dal suo entroterra; nel primo caso la riterritorializzazione investe il palazzo e le sue riserve, nell’altro l’agorà e le reti mercantili”.3
La deterritorializzazione imperiale si articola in linee di trascendenza, mentre quella della città si concretizza in linee di immanenza, liberando un “autoctono cittadino”, vale a dire una “potenza della terra”, che fa appello “agli stranieri in fuga” per rifondare il territorio, meglio: per poter creare “una nuova terra a venire”. Metto subito in evidenza, a questo punto, un “segnavia” di questo mio contributo, che consiste nell’accostamento dell’“autoctono cittadino” all’abitante di quella “città singolare” (Napoli) attraversata dalla particolare sensibilità “politica” di “stranieri in fuga”, per così dire, come W. Benjamin e A. Sohn Rethel. Su tutto ciò ritornerò nella seconda parte del testo, ma per il momento voglio insistere su come la dilatazione complessa del divenire-urbano del territorio richieda un indispensabile ripensamento delle categorie e dei concetti con cui si tenta abitualmente di descrivere le trasformazioni urbane e sociali. Non è dunque sufficiente pensare ad una crisi, sia pure radicale, dei modelli urbani o delle periferie; si tratta invece di riflettere su una trasformazione dell’urbano che lo vede disseminato ovunque, con una imposizione uniforme di modelli che però vengono insieme contaminati/mutati dagli stili di vita incontrati e dai luoghi di realizzazione: “Questa nuova dimensione territoriale, costituita da microappartamenti, fabbriche in disarmo, strade asserragliate, megasupermarket, è forse la protesi più fattuale dell’oggi, quella più plastica, capace di connettersi con ogni mutamento e di forgiare, trasformando e autotrasformandosi, gli attuali spazi di vita e dunque il tempo-vita stesso. Il volto multiforme della produzione, le differenziazioni assunte dal capitale incontrano in questa trasformazione dell’urbano il loro corpo più proprio. La cosiddetta flessibilizzazione delle funzioni produttive, agevolata dall’applicazione delle nuove tecnologie, ma soprattutto veicolata dal mitologema tecnologico, delinea i nuovi paesaggi del vivere e dell’abitare. Paesaggi che reinvestono in modo radicale fisionomie, aspirazioni e desideri scontrandosi in modo più o meno decisivo con i codici della omologazione”.4
È sulla base di queste osservazioni che si sviluppano ancora delle questioni che riguardano la possibilità concreta di ritrovare tensioni – cioè contingenza felicemente produttiva di ulteriore diversità – nell’odierno declinare il locale con il globale, relazionalità capace di smarcare gli spazi dalla presa “strumentale”, calcolata, sotto veste di “potere totale del Capitale” (per riprendere una formula apparentemente “inattuale” della Dialettica dell’Illuminismo di T. W. Adorno e M. Horkheimer). Può essere che la forza di un rimettere in gioco gli spazi, di fronte al loro utilizzo così condizionato, sia afferrabile, come ritiene Villani, nelle destrutturazioni/movimentazioni dei linguaggi, proprio dentro le trasformazioni delle strutture abitative e degli arredi urbani, in alternativa o in allontanamento comunque dai luoghi comuni delle vulgate dominanti, del linguaggio degli ordini, dei comandi, con le loro maledette “spine”, per dirla con E. Canetti?
A proposito di queste destrutturazioni e movimentazioni dei linguaggi, dentro i mutamenti delle strutture abitative e degli arredi urbani, cioè in riferimento alle trasformazioni della sensibilità, in prima battuta: del soggetto che “percepisce”, si potrebbe fare un lungo elenco delle loro messe in forma “artistica”, in grado di stimolare una riflessione critico-estetica (nel senso proprio di alcune opere di B. Stiegler). Per quel tempo storico – il “nostro”, ancora – che vede “tutto ciò che è solido dissolversi nell’aria” (così Marx, in una pagina del Manifesto del Partito Comunista, giustamente celebrata da M. Berman come un campione straordinario della cosiddetta “immaginazione modernista”), si dovrebbero spendere nomi di scrittori, pittori, musicisti, autori di cinema ecc.: da Baudelaire e Rimbaud a Brecht, passando magari attraverso alcune particolari “emergenze” del futurismo, arrivando poi ai paesaggi psicourbani di J. G. Ballard o alle figurazioni dell’inabitabile rintracciabili nei testi di B. Ellis. Sicuramente fertile è l’attenzione dimostrata alle metamorfosi dello spazio urbano, nel Novecento, da parte di filosofi come G. Simmel, W. Benjamin, E. Bloch, toccando poi studiosi ancora più vicini come lo stesso Lyotard o P. Virilio.
Ciò che appunto voglio richiamare, in questa seconda parte del contributo, è un complesso di pagine dedicate ad un particolare paesaggio urbano frammentato, alle correnti di vita proprie di strade urbane singolari, che mette in discussione un modo asettico di considerare la cosiddetta razionalità dello scopo e delineano una filosofia contraddistinta dall’ “ideale del rotto”, dall’ideale des Kaputten, da un accesso alle “ragioni” della tecnica, della sua progressione, per vie traverse, capaci di riorientare un cammino – di pensiero critico – altrimenti incerto, per non dire impedito.
Il rinvio è diretto ai viaggi, alle esperienze di viaggio, di Sohn-Rethel, Benjamin, Adorno, Bloch, S. Kracauer, K. Loewith, in un contesto come quello napoletano che costitutivamente non esclude il caos, mescolando storia, cultura e natura. Sottolineando come i reportages di questi viaggiatori colti tedeschi si confrontino con una realtà ben più complicata e ambigua rispetto a quella raffigurata da illustri predecessori come Goethe e Nietzsche, E. Donaggio ha ben sintetizzato uno dei sensi di queste immagini napoletane che contestano il “classico” orientamento selettivo dell’attenzione filosofica “sull’accordarsi armonioso e misurato di natura e cultura”, quasi che questo potesse svolgere una funzione terapeutica nei riguardi del contrasto “tra le fatigues du Nord e la leggerezza del Sud”: “Se è vero che, come scrive Kracauer, ‘le città del Nord sembrano sognare, quelle del Mediterraneo hanno qualcosa del sogno’, lo è anche che questo aspetto onirico, come testimonia la descrizione dell’abitazione di Clavel a Positano (…), è sempre pronto a volgersi in incubo; nemmeno l’incontaminata natura del Vesuvio, tra l’altro, è priva di tratti infernali. Quanto a Napoli, varcando la linea d’ombra su cui si arrestano d’abitudine le rappresentazioni oleografiche, le cronache di questi ‘viaggiatori di talento’ la collocano a pieno titolo nella costellazione delle grandi città europee, tentando di cogliere la singolare modernità di una metropoli che non esclude nessun elemento del caos. Esse si sforzano quindi, non sempre riuscendovi, di capovolgere o intrecciare le prospettive usuali, di coniare nuove categorie interpretative (la ‘porosità’, la ‘tuttilità’, l’‘Ideale del Kaputt’ e così via), di riflettere sul tempo e lo spazio, sulla tecnica e l’architettura, allo scopo di mostrare come quel che si ama considerare ‘moderno’ e quel che, di contro, si bolla come ‘arcaico’, ben lungi dall’escludersi, si compenetrano vicendevolmente secondo modalità che, con buona pace dei sostenitori del ‘postmodernismo’, erano state individuate e comprese già agli albori della modernità”.5
E ancora: è condivisibile l’insistenza sulla convinzione benjaminiana che sia possibile – anche nei confronti di quella sfida alla filosofia rappresentata dalla realtà napoletana – mettere in piedi una descrizione positiva di una “confusione”, rendendola produttiva e non restituendola semplicemente come una descrizione confusa. Da qui procede, come osserva Donaggio, una attenzione ai paesaggi urbani, in particolare a quei dettagli (da curare con “precisione mimetica”) nei quali si nasconde “non solo il diavolo, come recita un proverbio tedesco, ma anche il buon dio, come riteneva Aby Warburg”, a cui si accompagna una proliferazione di “immagini di pensiero”, di Denkbilder, rappresentative di una singolare “grande città” che vede affermarsi lo specifico di un rapporto con la tecnica, con le “macchine”, in fondo benevolo e soltanto un po’ brutale (Sohn-Rethel).
Proprio nelle pagine dell’autore di Lavoro manuale e lavoro intellettuale dedicate all’“ideale del kaputt”, cioè alla “tecnica napoletana”, si trovano delle osservazioni particolarmente significative, soprattutto là dove si scrive che “i congegni tecnici sono per principio rotti” (a Napoli) perché così possono cominciare effettivamente a funzionare. I termini dell’intervento di Sohn-Rethel mi ricordano quelli di Benjamin, allorquando il filosofo berlinese tratta la figura di Mickey Mouse come concretizzazione del sogno di una tecnica mimetica non estraniante, come esemplificativa di un rapporto con la tecnica che si esprime al meglio in un suo attraversamento ludico-critico: “L’esistenza di Mickey Mouse per l’uomo di oggi è un sogno di questo genere. Questa esistenza è piena di meraviglie, che non solo superano quelle della tecnica, ma si prendono gioco di esse. Perché ciò che in queste è più notevole, è certo il fatto che tutte quante senza machinerie, improvvisate, saltano fuori dal corpo di Mickey Mouse, dei suoi partigiani e dei suoi persecutori, dai più comuni mobili, così come da un albero, dalle nubi o da un lago. Natura e tecnica, primitività e comfort qui sono diventati perfettamente una sola cosa e agli occhi della gente, stancatasi delle complicazioni senza fine della vita quotidiana e per la quale il fine della vita affiora solo come un lontanissimo punto di fuga in un’infinita prospettiva di mezzi, appare liberante un’esistenza che in ogni frangente basta a se stessa nel modo più semplice e contemporaneamente più confortevole, in cui un auto non pesa più di un cappello di paglia e il frutto sull’albero si arrotonda così velocemente come la navicella di un aerostato” .6
Che il senso della tecnica non consista nel “dominio della natura”, bensì nell’assicurare la possibilità del “dominio del rapporto tra natura e umanità”, è convinzione forte di Benjamin, il quale sottolinea appunto come la tecnica abbia il potere straordinario di mostrare la natura in prospettive differenti e di modificare, nel suo accostamento all’uomo, “gli affetti più originari, le angosce e i desideri”. Ed è proprio su tale “accostamento”, meglio: nella sua particolare “introduzione” all’/nell’umano e alla possibilità di diversi sviluppi, che si articola la riflessione di Sohn-Rethel sulle “apparecchiature tecniche” che cominciano a funzionare realmente, per il napoletano (che riesce a “far ripartire la sua auto in panne grazie a un pezzetto di legno trovato in strada per caso”), soltanto quando sono rotte (da qui deriva la “ripugnanza” nei confronti delle stesse riparazioni che si pretendono definitive). “In ciò non vi trova nulla di strano.
Se qualcuno gli dicesse che non è così in realtà che ci si serve di un motore o di un’apparecchiatura tecnica in generale, lo guarderebbe sbalordito e si opporrebbe addirittura in modo energico: perché l’essenza della tecnica consiste per lui proprio nel far funzionare quel che è rotto. E nel maneggiare macchinari difettosi, è senza dubbio un maestro, ben al di là di ogni tecnica. Nell’abilità e nella prontezza di spirito con cui, di fronte a un pericolo, ricava con irrisoria facilità la soluzione vincente proprio da ciò che non funziona, ha per certi versi qualcosa in comune con l’americano. Ma dalla sua ha la suprema ricchezza inventiva dei bambini, e come i bambini è sempre fortunato, e come accade ai bambini, la fortuna gli arride volentieri. Di ciò che è intatto invece, di quel che per così dire funziona da sé, egli in fondo sospetta e diffida: infatti, proprio perché va da solo, alla fine non si può mai sapere come e dove andrà” .7
Anche rispetto all’elettricità, che difficilmente si riesce a rompere, vale questa sorta di profanazione (della) tecnica, che si risolve in un corpo a corpo “positivo” con la macchina stessa, con i suoi elementi. Perché “positivo”? Si è detto che l’essenza della tecnica consiste nel far funzionare ciò che è rotto e Sohn-Rethel indica un inizio concreto della tecnica nel momento in cui “l’uomo pone il suo veto all’inaccessibile e ostile automatismo dei macchinari, e si lancia nel loro mondo, dimostrandosi di una spanna superiore alla legge della tecnica”. Non ci si appropria infatti semplicemente del funzionamento di una macchina in base alla conoscenze delle regole del suo impiego, bensì “scoprendo in essa il (…) proprio corpo”: “Dopo aver distrutto la magia, ostile all’uomo, dell’intatto funzionamento delle macchine, egli si installa nel mostro ormai privo di maschera e nella sua stolida anima, felice di possederlo in carne e ossa nel dominio sfrenato di un’utopica onnipotenza. Non si fa più trarre in inganno dalla tracotanza tecnica dello strumento in cui si è incorporato; il suo sguardo non si lascia più sedurre dalla menzognera apparenza delle sue manifestazioni: un pezzetto di legno o uno straccio possono funzionare altrettanto bene. La potenza di ciò che ha incorporato deve però esprimersi di continuo in scontri vittoriosi. (…) Una proprietà che si rispetti va per l’appunto maltrattata, altrimenti non vale niente: va goduta fino in fondo, consumata e per così dire distrutta, annientata”.8
Sembra qui avverarsi l’idea benjaminiana di una ricerca di padronanza del nuovo corpo (così realizzato: attraverso il divenire corpo della tecnica o il divenire tecnica del corpo), nel senso di ricondurre proficuamente il “delirio dell’annientamento” in una posizione di servizio – nell’essere vivente – rispetto all’ “ebbrezza della procreazione” (espressione – direi – della “potenza della terra” richiamata da Deleuze e Guattari). Sohn-Rethel coglie con divertita intelligenza, nella sua “filosofia del rotto”, una resa/traduzione della tecnica (che rappresenta un tradimento nei confronti delle logiche imperanti della omologazione, della uni-formità della produzione capitalista) a/in pratiche di risoluzione di faccende semplici e, proprio per ciò, “impensate”. La tecnica, “ormai quasi slegata dalle sue finalità”, viene orientata così, nei modi più bizzarri e convincenti (il motore di una motocicletta che diventa “montapanna” in una latteria), “verso mondi di vitalità a lei del tutto alieni”, radicati, nel caso di Napoli, in un diciassettesimo secolo che continua, “fornito di telefoni e di tram”, ad esistere nella maniera più stravagante, “rimanendo sempre, seppur sullo sfondo, al servizio della libertà di questa vita”.
È proprio su tale servizio, alla “libertà di questa vita”, che mi sembra opportuno oggi gettare lo sguardo, riconoscendo, con Sohn-Rethel, come ci possa essere una com-prensione dei “meccanismi” – della potenza di ciò che viene incorporato – che non li consideri soltanto come rappresentativi di quella particolare “continuità civilizzatrice per cui sono stati predisposti” . Si potrebbe dire che nelle riflessioni degli intellettuali critici tedeschi sul rapporto tra il mondo delle macchine e quello della fantasia è possibile trovare lo stimolo ad una analisi rinnovata di ciò che oggi si presenta come “realtà” di un corpo ibridato, per via tecnologica, collocato all’interno dei processi di valorizzazione che delineano il new capitalism, il “capitalismo flessibile” (R. Sennett). C. Marazzi ha parlato, a tale proposito, di una sorta di modello antropogenetico, che caratterizzerebbe il nuovo capitalismo, definito da una qualifica del corpo della forza-lavoro, del corpo vivente, come contenitore delle funzioni di capitale fisso e di capitale variabile, vale a dire di materiali e strumenti di lavoro “passato” e di lavoro vivo “presente”. È giusto insistere sulla trasposizione delle funzioni del capitale fisso macchinico nel corpo mobile e fluido del vivente, perché ciò conduce alla rilevazione di una possibilità di eccedenza della tecno-natura umana rispetto ai suoi usi storicamente determinati nel quadro delle trasformazioni del modo di produzione capitalistico.
Tale eccedenza è una “eccedenza di valore” (di “rottura”), che rinvia a quella “variabile permanente” (Marazzi la qualifica come una “invariabile” che attraversa la “storia” umana) costituita dalla forza vitale dell’uomo, da una “dote di natura” che “si conserva malgrado l’erosione, malgrado il consumo riproduttivo che è costretta a subire lavorando per il capitale. Così come ‘il macchinario non perde il suo valore d’uso appena cessa di essere capitale’ (Grundrisse), nel modello antropogenetico il corpo della forza-lavoro come cervello sociale, come corporeità del sapere e delle abilità, non perde il suo valore d’uso anche quando cessa di lavorare per il capitale. Con una differenza non da poco, comunque, dato che quando la macchina è inoperosa è sì lavoro passato, ma è anche morto, mentre il corpo-macchina della forza-lavoro, anch’esso sedimentazione di lavoro passato, è sempre vivo. In questo senso preciso la forza-lavoro eccede la sua stessa messa al lavoro nel processo direttamente produttivo”.9
L’“arsenale del rotto”, descritto da Sohn-Rethel, appare allora come una felice conferma del carattere “finito” della “classica” separazione tra capitale fisso e capitale variabile, separazione/distinzione superata oggi, nelle sue forme tradizionali, dallo stesso sviluppo capitalistico, a partire dalla crisi del modello fordista e della sua definizione del rapporto tra capitale e lavoro. Tale sviluppo individua una specie particolare di “autonomia del vivente dal modo di produzione storicamente determinato” sulla quale è possibile far leva per scardinare i costrutti d’ordine della “tracotanza tecnica”, del suo impiego, per installarsi nel “mostro”, come scrive ancora Sohn-Rethel, o per riconoscerlo come una dimensione del nostro esistere in grado di fornire un contributo, che manca il suo scopo originariamente delineato all’interno della continuità “civilizzatrice” propria del capitalismo, ad una ripresa di contatto con il “mondo”. Riprendo, per concludere, l’aforisma di Benjamin, “Al Planetario”, già richiamato, per centrare l’obiettivo di una figurazione efficace della produttività di quella sensibilità teorica che ha visto, tra l’altro, nella “tecnica napoletana” un esempio di una pratica che tiene assieme storia, cultura e natura, non escludendo alcun elemento del caos “metropolitano”: “È vero, gli uomini come specie si trovano da millenni al termine della loro evoluzione; ma l’umanità come specie ne è appena all’inizio.
Nella tecnica le si sta organizzando una physis nella quale il suo contatto col cosmo avverrà in forma nuova e diversa che per popoli e famiglie. Basti ricordare l’esperienza di velocità grazie alle quali ora il genere umano si prepara a viaggi vertiginosi verso il cuore del tempo, per imbattersi là in ritmi da cui i malati trarranno vigore come prima in alta montagna o in riviera. I luna park sono una prefigurazione di futuri sanatori. Il brivido di un’autentica esperienza cosmica non è legato a quel minuscolo frammento del mondo naturale che noi siamo abituati a chiamare natura. Nelle notti di sterminio dell’ultima guerra una sensazione simile all’estasi degli epilettici scuoteva le membra dell’umanità. E le rivolte venute poi sono state il suo primo tentativo di acquistare la padronanza del nuovo corpo. Termometro della sua guarigione è il potere del proletariato. Se la disciplina di questo non gli penetra fin nel midollo, nessun arzigogolo pacifista lo salverà.
Il delirio dell’annientamento è superato dall’essere vivente solo nell’ebbrezza della procreazione”.10
NOTE
1. Cfr. T. Villani, Il tempo della trasformazione. Corpi, territori e tecnologie, Manifestolibri, Roma, 2006, p.15 (il testo di Paquot richiamato è Demeure terrestre. Pour une philosophie de l’architecture et de l’urbain, Ecole Polytechnique, Dip. D’Architecture, Lausanne, 2000, p.47). Di Villani cfr. anche La teoria dell’“individuazione” e le società di controllo, in “Millepiani”, n.31, 2006, pp.35-46.
2. G. Deleuze – F. Guattari, Che cos’è la filosofia?, tr. di A. De Lorenzis, a cura di C. Arcuri, Einaudi, Torino, 1996, pp.77-78.
3. Ivi, p.78.
4. T. Villani, Il tempo della trasformazione. Corpi, territori e tecnologie, cit., p.19.
5. E. Donaggio, Introduzione ad Adorno, Benjamin, Bloch, Kracauer, Loewith, Sohn-Rethel, Napoli, tr. di vari, a cura di E. Donaggio, L’ancora del mediterraneo, Napoli, 2000, pp.14-15.
6. W. Benjamin, Esperienza e povertà, tr. di F. Desideri, in F. Rella (a cura di), Critica e storia, Cluva, Venezia, 1980, pp.207-208.
7. A. Sohn-Rethel, L’ideale del kaputt. Sulla tecnica napoletana, in Adorno, Benjamin, Bloch, Kracauer, Loewith, Sohn-Rethel, Napoli, cit., p.46. Rinvio anche ad un’altra tr. di questo testo di Sohn-Rethel, che ho tenuto presente: Napoli: la filosofia del rotto, tr. a cura di S. Custoza, con una nota di C. Freytag, A. Caròla Editrice, Napoli-Milano, 1991.
8. Ivi, pp.47-48.
9. C. Marazzi, Capitalismo digitale e modello antropogenetico di produzione, in AA.VV., Reinventare il lavoro, Sapere 2000 Edizioni, Roma, 2005, p.122.
10. W. Benjamin, Strada a senso unico. Scritti 1926-1927, tr. di vari, Einaudi, Torino, 1983, pp.68-69.


