L'edicola digitale delle riviste italiane di arte e cultura contemporanea
Juliet Anno 29 Numero 145 dicembre 2009 - gennaio 2010
Giuseppe Desiato
Roberto Vidali
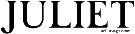
Art magazine

Dicembre 2009, n. 145
* Copertina di Giuseppe Desiato
* Gigantismo: metodologia o spettacolarizzazione, di Matteo Bergamini
* Giuseppe Desiato, di Roberto Vidali
* Performing the city, di Ernesto Jannini
* Marlon De Azambuja, di Fabio Fabris
* Colonia contemporanea, di Stefania Meazza, 2° puntata
* Ritratto da Milano, di Luca Carrà
* Ritratto da Trieste, di Fabio Rinaldi
* Ritratto da Torino, di Simona Cupoli
* Rubrica di Vegetali Ignoti
* Rubrica di Angelo Bianco
* Notiziario Spray
ecc., ecc.
Adrian Paci
Maria Vinella
n. 173 giugno-luglio 2015
Case chiuse, corpi aperti
Roberto Borghi
n. 172 aprile-maggio 2015
Yang Xinguang e la materia
Sara Bortoletto
n. 171 febbraio-marzo 2015
Eugenio Re Rebaudengo
Giulia Bortoluzzi
n. 170 dicembre-gennaio 2015
Biennale Architecture
Gabriele Pitacco Marco Gnesda
n. 169 ottobre-novembre 2014
Biennale Marrakech
Emanuele Magri
n. 168 giugno-luglio 2014



Nel 1980, nel primo pomeriggio del 9 aprile, Giuseppe Desiato arriva a Trieste. Ha in corso di svolgimento una mostra presso il Centro La Cappella, e proprio lì (in quel vano rettangolare di 5 x 20 x 3,50 metri, scandito a soffitto da una sequenza di travicelli in ferro e a pavimento da una scacchiera di mattonelle), due giorni dopo, allestisce una delle sue consuete animazioni con modella. Il tema conduttore è quello della crocefissione, ma Desiato non mette solo in scena i simboli di un rituale religioso (la croce, le luminarie, l’icona, la maschera, ecc.), vi aggiunge anche una parodia della stessa; invertendo i termini, accentuandone i caratteri, istituendo delle difformità linguistiche, immettendo nella traccia di alcuni elementi-base tradizionali altre sequenze, altre matrici, che con la prima (l’origine religiosa del tema) hanno solo il rapporto dialettico di un vissuto che ha origine concreta, e nei rioni popolari e nel presepe partenopeo e nella teatralizzazione mistica medioevale e nelle feste popolari del mezzogiorno d’Italia.
Il lavoro di Desiato -salta subito all’occhio- non punta sulla fedeltà narrativa, quanto sulla miscellanea e sullo sberleffo, cioè sull’unione di una creatività popolare a quella colta, e su quella pernacchia spernacchiante di cui De Filippo in “L’oro di Napoli” ci ha dato una bellissima testimonianza. Allora, non ricostruzione storica, bensì reinvenzione totale, pretesto affidato alle mani di un abile vasaio, capace di farci la bocca larga e d’infilarci poi dentro di tutto un po’. Il dato irriverente e creativo è quello tipico della venditrice di banane del rione Montesanto o della sigherattaia della Sanità, cioè di qualcuno che ti arpiona sulla pubblica piazza, con le parole, per catturarti ma al contempo per respingerti, come per creare un alibi a chi non vuol cadere nella rete di un contratto offerto con maniere troppo brutali e spontanee. Allora, non studio a tavolino di matrici, comportamenti, grida, accenti, decorazioni, tuttora esistenti nel cuore del popolo napoletano, bensì l’autentico sgorgare dall’animo dell’autore di tutte quelle componenti facenti parte di un vissuto e di una formazione provenienti dal basso, da un ethnos che lo vede protagonista, fin dalla sua prima infanzia, di una condizione dialettale e mimica, tipica di una umanità creativa per istinto, proprio perché lì il tempo sembra camminare in un’altra direzione, non omologata e non uniformata con il resto del mondo occidentale.
La ricomposizione, poi, di tutte queste grida, all’interno di un sistema di segni visivi, ovvero nella gabbia di un’estetica che risponde ai requisiti dell’improvvisazione e della processualità, è storia non di quella serata, bensì appartiene a quei propositi di ricerca e sperimentazione che prepararono la nascita dello slogan “la fantasia al potere”. Ci si riferisce qui all’happening e al fluxus in primis, e al Wiener Aktionismus in secundis: situazioni che Desiato ha vissuto in maniera scanzonata, ludica, fin dagli anni del suo soggiorno a Sorrento.
Quelle erano estetiche che avevano innestato all’interno dell’opera il concetto di estensione temporale, ovvero di teatralizzazione dell’immagine artistica, e queste premesse -si capirà- erano molto consone a uno spirito napoletano verace, divoratore di pizze e di pastasciutta aglio-olio-peperoncino.
Se Lucio Fontana, proprio in quegli anni, andava a definire il concetto spaziale di distruzione del campo neutro della pittura, Kaprow e Nitsch diedero sostanza a quello di un’immagine fatta propria da un flusso vitale che trova nel simulacro finale (relitto o reperto o fotografia) solo una pallida eco del trascorso. Desiato s’inserisce, quindi, a pieno diritto in questo flusso vitale, escindendo però da sé quel drammatico istinto di thanatos -e per ascendenze psicanalitiche e per compendio di antiche culture religiose- onnipresente e onnipotente nelle esperienze del gruppo viennese, e in particolar modo in Schawarzkogler, che con la performance da studio “Hochzeit” ci ha dato più che qualche curiosa coincidenza con le processioni-matrimonio del Nostro.
Desiato ha recitato e cantato davanti ai suoi quadri, ha incartato bambini, modelle e turiste che gli sono capitate tra le mani, ha prodotto performance, tele-happening, finti monumenti con scatoloni ‘pittati’ a calce, ha realizzato film e foto con una trascuratezza per il dato tecnico che rivela più una costrizione verso la macchina che una scelta di libertà.
Ripercorriamo per sommi capi parte di questo itinerario. Dal 1955 al 1958 dipinge figure erotiche, paesaggi espressionisti, nature morte, contemporaneamente recita davanti a questi quadri. Nel 1960 assume l’incarico di disegno dal vero presso l’Istituto statale d’arte dell’Aquila; qui continua a dipingere, disegnare, fotografare, incartare, progettare i "monumenti inutili". Nel 1963 viene trasferito all’Istituto d’arte di Sorrento, e qui, sarà stata la luce diversa, saranno stati altri fattori di ordine climatico, esistenziali o coloristici, incarta non più oggetti ma i bambini della Marina Grande di Sorrento, un povero villaggio di pescatori. Ritrova così i colori della tradizione negli scafi dipinti delle barche da pesca, nei vestiti poveri di Resina, nelle processioni, nel viavai di gente cosmopolita e bene agghindata. Continuando il discorso sul recupero dei materiali poveri vengono fuori pupazzi usati come personaggi viventi. Nel ‘64, subito dopo la notizia della morte di Kennedy, esegue una grossa composizione, facendosi interprete dei vuoti culturali, politici e civili che seguirono.
Segue un periodo durante il quale recupera delle scritte apponendole su corpi viventi e su immagini inanimate, e nel 1966 esegue una serie di fotocopie manipolate del suo stesso corpo. Nel ‘70, in Spagna, con alcuni visi di cartone, rappresentanti la morte e le guardie, maschera le persone per le vie di Barcellona. Dal ‘70 al ‘74 continua a filmare, fotografare, progettare, scartare, incartare, disegnare, progettare monumenti inutili, e a schivare galleristi, critici, collezionisti, mercanti. La vita di Desiato è sempre stata una vicenda in fuga, una esistenza ribelle e riottosa che nulla concede all’aspetto moralistico ma nemmeno a quello corruttivo. Inoltre è importante rilevare che durante tutti quegli anni, accanto alle azioni (da strada, da studio e da galleria), anche se in tono minore, ha continuato la produzione di disegni e bozzetti, attività che ritornerà preponderante dopo il 1978, con la “Riappropriazione della pittura dopo la Body Art”. Che fin da allora Desiato abbia avvertito d’istinto il baratro verso il quale si stava avviando l’intero sistema dei segni, optando così per una resa dei conti finale che lo ha ricondotto a uno specifico, a una pratica dell’arte, dilagata poi a macchia d’olio e in maniera fors’anche eccessiva?
Tuttavia non solo questo è Giuseppe Desiato. In lui è presente uno dei temi cari alla pittura accademica cioè la modella come fonte di studio analitico e soggetto ispiratore, che qui viene rivisitata in chiave plausibile, sulla falsariga del segno-sogno erotico, capace di fungere da volano scatenante il raptus del rattuso, ovvero di scoperchiare quegli istinti repressi che una società moralistica, nella sua falsità di comportamenti, cerca di nascondere, di velare, di deviare. Se codesto istinto è quindi parte di una pulsione sociale, tanto più -dice l’autore- appartiene di forza a un sistema artistico che da sempre, nel proclamare una autonomia da quelle regole del ‘buoncostume’, si pone ai margini, ai confini di quell’apparenza che fa marciare la società verso una direzione omologatrice.
Così, accanto a un’elenco di merci poste in un’esibizione quasi natalizia, il corpo nudo della modella (in carne e ossa e in effigie) sostituisce in “Ricostruzione della croci-fissione” il corpo del Cristo, ottemperando a una traslazione anche poetica, e non solo di senso, grazie a un cappellino a punta della Fata Turchina, con la maschera che cela il volto profferto al pubblico (velare e non svelare, è uno dei termini ricorrenti del discorso). Si tratta in effetti di uno scompenso tra proposte a valanga dal grande magazzino delle merci -immagine privilegiata della sodomizzazione consumistica- e tentativo di resistervi con un atto di fuga parziale; declinando cioè la propria avversione ideologica in chiave sostanzialmente caricaturale, il che varrebbe a dire: “Ci sono costretto, ma partecipo, mio malgrado”.
La proibizione evidentemente istituisce il problema. La resa visibile dei contenuti ne crea la forma: croce/fallo/albero di Natale sono i segni che si disperdono nel campo della rappresentazione; bocca/occhi/mani sono i simboli primari che giocano nello spazio dell’immaginario. I comandi dell’etica si risolvono nel mare dell’estetica, e la preoccupazione della propria salvezza chiude l’essenza dell’orgasmo culturale: la proibizione non si cancella ma si sospende, i problemi non si risolvono ma si palesano. Il serbatoio della pre-iconografia popolare resta a vedetta per controllare le griglie della finzione: con un’implosione vesuviana si entra nel ventre della mitica caverna di Averno. La devozione dei bambini per un gioco fatto con e tra i rifiuti, la Madonna calorosa e i preti del rosso inferno, la santità da strada con i fiori di plastica e le aureole al neon, il sesso minorile praticato nei ‘bassi’ e cicalato sulle scalinate, il brusio televisivo (invasivo come e forse più di una messa cantata), le grida e i richiami (gorgheggiati come le canzoni di San Remo), sono le presenze che chiudono la vertigine creativa dei sensi. Scatole rifiutate dal ciclo consumistico, nastri colorati, vestiti usati, maschere di carnevale, luci elettriche, spade di plastica, giocattoli per bambini, sono le monete gettate senza legame sul tavolo della scommessa erotica.
Con questi oggetti il corpo nudo o il foglio vuoto -entrambi campi dell’azione- possono essere addobbati, immettendo all’interno del meccanismo formale una accumulazione di tipo sacrale, dove regna il sistema delle merci più che la litania della parola. Il pubblico si eccita; si carica di curiosità e di aspettative non confessate. Le luci degli spot e il fumo del tabacco spandono nello spazio aloni di nebbia; tutto l’insieme contribuisce a creare un clima da ribaltone anarchico che fa aumentare la temperatura anche in presenza di un altro gradiente di umidità. Il silenzio e l’attesa appartengono, comunque, al pubblico devoto: appartengono alle persone chiuse nel caveau di un sistema elitario, unitamente al capriccio e alla convinzione di essere parte di un motore estetico. Modella-disegno-azione sono quindi le cerniere impiegate per la dilatazione del linguaggio, che dalla pittura arriva fino all’autopresentazione. Obbliqua/distesa/rovesciata la tecnica dell’irruzione e dello scompiglio fornisce l’impressione della provvisorietà: in definitiva tutto si può iniziare, disfare, confezionare, concludere in pochi minuti. La processione o il quadro possono allora dirsi conclusi.


