L'edicola digitale delle riviste italiane di arte e cultura contemporanea
Juliet Anno Numero 94 ottobre 1999
Guerra & arte
Enrico Mascelloni e Sarenco
Riflessioni attorno alla 3° guerra balcanica
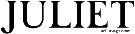
Art magazine
Adrian Paci
Maria Vinella
n. 173 giugno-luglio 2015
Case chiuse, corpi aperti
Roberto Borghi
n. 172 aprile-maggio 2015
Yang Xinguang e la materia
Sara Bortoletto
n. 171 febbraio-marzo 2015
Eugenio Re Rebaudengo
Giulia Bortoluzzi
n. 170 dicembre-gennaio 2015
Biennale Architecture
Gabriele Pitacco Marco Gnesda
n. 169 ottobre-novembre 2014
Biennale Marrakech
Emanuele Magri
n. 168 giugno-luglio 2014
Riflessioni attorno alla 3° guerra balcanica. Chi firma questo documento, redatto a caldo dopo un ampio viaggio nella Jugoslavia devastata dai bombardamenti, ritiene che la Serbia o "piccola Jugoslavia" che la si voglia chiamare (paese fiero e geloso della propria autonomia, area sovrana che ha saputo sbarazzarsi degli ottomani e degli austro-ungarici, dei nazisti e degli stalinisti) sia a tutti gli effetti un ostacolo concreto al nuovo ordine mondiale. Ogni qualvolta l' occidente a dominanza americana trova delle resistenze al suo processo di penetrazione, il conflitto viene posto come uno scontro tra civiltà, assumendo, quindi, un'ampia dimensione culturale. Poiché sembrerebbe di cattivo gusto dichiarare esplicitamente che si stanno affamando interi popoli per predisporli a bere una bevanda dal sapore di piscio come la Coca-Cola, è certo più efficace raccontargli che stanno difendendo, a seconda dei casi, l' "occidente", la "civiltà cattolica", la "minoranza islamica albanese", i "buddisti tibetani"... e che stanno combattendo il "fanatismo dell'Islam", la "violenza genetica degli slavi", il "tribalismo dei somali" o quant'altro sappia scatenare la viltà e l'ignoranza dei propri utenti, di cui il milieu della "cultura avanzata" è un'appendice comica e imbelle.
Anche questa guerra, come quelle più recenti, accentua nella propaganda e nella pratica le sue ambizioni culturali. La Nato è l'apripista di un modello culturale. A traino del modello economico che si vuole espandere, che se non si espande muore, si ingorga in attesa di spurgo tutta la sua cultura, dall'hamburger alla c(ia)nn, dalla Coca-Cola ai telefilm, dalla minimal art al Guggenheim Museum.
Nonostante sia il conflitto la figura che permette ancora a questo mondo di non somigliare a un supermarket di Miami o a una scuola di Denver, nonostante tale evidenza la cultura cosiddetta "avanzata" è un inno alla sudditanza, al codismo, alla subalternità. È tale, e forse ancor di più, quando si traveste da mattatoio postumano o da palcoscenico interetnico, da critica alla guerra o da luogo dove si perora la pace e la convivenza tra i popoli.
Non c'è alcuna libertà o solidarietà o fratellanza che ci interessi al di fuori del conflitto, o per meglio dire del piacere del conflitto con i nuovi poteri imperiali.
Ce ne freghiamo anche dei linguaggi degli artisti e dei loro messaggi, quando non sappiano concretamente arrecare danno, osteggiare, insultare nella sostanza i padroncini politically correct e le loro libertà. Cosa possiamo dire ai produttori di pittura, di installazione, di video arte o di qualsiasi altra insignificanza contemporanea; cosa potremmo suggerirgli se non che, come minimo, soltanto una presa di posizione chiara e fattiva in favore della sovranità serba sarebbe capace di trasformarli in qualcosa di diverso da rottami multiuso?
Il sonnifero della mondializzazione -all'insegna di musei pulitini come sale operatorie e di conferenze pluraliste come i vecchi convegni delle correnti democristiane- li ha convinti che l'arte è luogo di convivenze e di fratellanza tra le culture. Gli USA non stanno forse difendendo la cultura kosovara come proteggono e conservano quella dei pellerossa che hanno ripulito etnicamente? Non si apprestano, c'è da scommetterci, a organizzare una qualche mostra d'icone bizantine dopo aver centrato qualche monastero intorno a Nis cercando di distruggere una fabbrica di tabacco? La fabbrica di Nis era una delle più moderne della Jugoslavia; ospitava asili nido e collezioni d'arte contemporanea. Se il consiglio di fabbrica avesse destinato qualche miliardo per acquistare un "aereo in picchiata che spara" del pop artista Lichtenstein, chissà, forse sarebbe stata risparmiata. Si sarebbero magari innervositi i critici d' arte.
Noi riteniamo che l'arte potrà tornare ad avere un qualche senso (e una sua non svilita tensione estetica) soltanto se agiterà adeguatamente e con la massima chiarezza il conflitto tra le culture.
Essi ritengono che qualche kermesse mondializzata, come la prossima Biennale diretta da un poveraccio in ritardo persino sui portavoce della NATO, possa riavvicinare le culture. Son sicuri che qualche pagamento in dollari (si accontentano in genere di poco) avrebbe sradicato, come per magia, le radici millenarie delle culture conflittuali e delle conflittualità che diventano cultura. Non accettano l' evidenza che la Storia costruisce non solo uomini ma anche popoli più liberi, più fieri ed esigenti di altri. E che quando non si è capaci di schierarsi con questi (uomini e all' occorrenza popoli e non solo classi) si perdono tutti gli appuntamenti e ci si ritrova nell' "internazionalismo" del Nazismo o dell' Americanismo, che è il suo erede disinibito e senza costume da parata.
Può, allora, la guerra spaventare chi ha ancora un briciolo di orgoglio? Si può tenere una posizione di sufficienza o di equidistanza quando gli individui e i popoli che conservano una certa fierezza non stanno più al gioco? E quindi accettano, accendendolo, lo scontro e il conflitto? Veniamo da permanenze di una qualche consistenza in luoghi di conflitto. I conflitti ci rendono euforici. Ci dimostrano che è ancora possibile qualche scommessa con la storia e non soltanto con la memoria. La guerra non ci repelle. Ma l' azione della NATO è guerra che finge di non esserlo e al contempo è sterminio che rivendica, senza riuscirci, l' antica onorabilità di una guerra. Alle finalità strategiche (devastazione culturale, affamamento, frammentazione in microentità) unisce i caratteri epocali della viltà e dell' ipocrisia.
Eppure gli imperi, come i grandi golosi, muoiono sempre per un ultimo boccone di dolce... che tra i crampi gli sembrerà esser stato persino superfluo.
Enrico Mascelloni e Sarenco
Aprile 1999


