L'edicola digitale delle riviste italiane di arte e cultura contemporanea
Juliet Anno Numero 96 febbraio 2000
Studio Azzurro
Diletta Borromeo
Intervista a Paolo Rosa
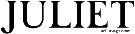
Art magazine
Adrian Paci
Maria Vinella
n. 173 giugno-luglio 2015
Case chiuse, corpi aperti
Roberto Borghi
n. 172 aprile-maggio 2015
Yang Xinguang e la materia
Sara Bortoletto
n. 171 febbraio-marzo 2015
Eugenio Re Rebaudengo
Giulia Bortoluzzi
n. 170 dicembre-gennaio 2015
Biennale Architecture
Gabriele Pitacco Marco Gnesda
n. 169 ottobre-novembre 2014
Biennale Marrakech
Emanuele Magri
n. 168 giugno-luglio 2014

Nella creazione di ambienti sensibili che posseggono la qualità di stabilire un contatto e formare esperienze socializzanti, quale è l'atteggiamento di voi autori nei confronti delle macchine?
Paolo Rosa: Siamo coscienti che esiste ormai una dimensione diffusa del portato degli strumenti. Siamo immersi in un'epoca in cui la tecnologia ha un valore fortissimo per i nostri comportamenti, le nostre relazioni, il nostro immaginario. Secondo me è un delitto vero e proprio che di tutto questo non ci sia un punto di vista nell'arte, perché la tecnologia possiede anche dei geni fortemente negativi. Credo sia necessario esporsi a lavorare con questi mezzi per cercare di immettersi dal punto di vista che si può chiamare poesia o linguaggio, che è indispensabile proprio per cogliere il lavoro. È importante assumersi la responsabilità di metterci la mano dentro. Questo è l'atteggiamento, pensando poi alle possibili implicazioni sulla base di un piano più poetico.
Diletta Borromeo: A proposito della capacità di raccontare, di saper dire con poco, hai portato per esempio gli Haiko, una forma letteraria giapponese sintetica e immediata, capace di suscitare in chi legge un'emozione o un'interpretazione istantanea, sempre diversa e sempre unica. Forse in maniera simile molte vostre opere vivono attivate da persone che ogni volta producono un'esperienza irripetibile.
Paolo Rosa: In qualche modo sì. Se vuoi la donna che dorme su uno dei "Tavoli" sarebbe rimasta lì. Lei continua a dormire se tu non la tocchi, per cui nel toccarla e stare a vedere che cosa faccia ti prendi una responsabilità. Mi piace il fatto che il pubblico si prenda delle responsabilità, come secondo me deve fare l'autore. Entrare in contatto con l'immagine e capirne la reazione è automatico, perché se anche non c'è nessuno nella stanza e tu sei solo, attraversi i tavoli, guardi le immagini che pulsano, che vivono ma non si muovono più di tanto, prima o poi la volontà di toccarli è irrefrenabile, viene voglia di sentirne proprio la matericità. In quel momento si genera una reazione ed è importante, ma accanto a questo è ovvio che l'intenzione di affondare le mani nel territorio in cui ci si serve delle tecnologie e dei nuovi linguaggi deve essere accompagnata da un grande disincanto rispetto ai parametri con cui si interpreta l'arte. Credo sia interessante poter sperare in questo territorio e nelle sue possibilità, avere la sensazione di come potrebbe trasformarsi il panorama dell'arte, pensando al ribaltamento delle figure di autore e spettatore, al coinvolgimento e all'immersione dello spettatore, a un'opera che può essere più narrativa.
Diletta Borromeo: Cosa vorresti raccontare delle collaborazioni con il teatro? Forse si tratta di una curiosità naturale per un lavoro come il vostro che si basa su diversi livelli di comunicazione e non si può incanalare in una sola direzione.
Paolo Rosa: Infatti non c'è un salto logico per noi così forte, anche se poi il teatro condiziona in parametri legati al bisogno di spettatori seduti. Spesso quella è una regola difficile da contravvenire per una questione fisica, anche di spazi. A Londra un anno e mezzo fa abbiamo fatto un esperimento interessante in cui abbiamo lavorato sull'interattività, però non durante lo spettacolo. Dapprima la rappresentazione si svolgeva con i nostri sistemi di proiezione, tutto in maniera molto particolare, ma alla fine, cioè quando la pièce si è conclusa e gli attori sono tornati nei camerini, abbiamo lasciato la scena attiva in modo che gli spettatori potessero entrare nello stage, toccare le immagini che erano predisposte per essere interattive e quindi richiamare alcune parti dello spettacolo, scene anche nuove. Per loro è stato come entrare nel luogo del delitto e appropriarsi di questa rappresentazione dopo aver visto la nostra versione. Gli spettacoli hanno sempre il fascino di mettere in scena l'uomo nel senso fisico, di conservare una fisicità molto forte che si mescola alla parte più virtuale. Il teatro rappresenta, quindi, un laboratorio un po' privilegiato, oltre a riportare l'esperienza su un territorio narrativo. Credo occorra recuperare non solo il rapporto con le persone, che spesso viene tralasciato o addirittura negato, ma anche un rapporto forte con il racconto. Penso che il racconto sia una frontiera importante per l'arte a venire e che certo non sarà il racconto che conosciamo. C'è uno spazio sperimentale che dovrebbe essere sviluppato. Tutto ciò avverrà in altro modo, sarà probabilmente non più unidimensionale ma multisensoriale, sarà costruito su strutture che non ricorderanno minimamente quelle del passato.
Diletta Borromeo: Alcuni elementi della vostra poetica sembrano muoversi su binari paralleli: l'analisi rigorosa degli strumenti e la loro umanizzazione, l'interesse per il Giappone in cui convivono tecnologia avanzata e culto della tradizione.
Paolo Rosa: Credo che, l'ho scritto alcuni anni fa, siamo in un'epoca in cui è necessario sapersi perdere e potersi ritrovare, non avere intorno a noi quell'apparato di logica, di pensieri razionali, di conoscenza che conduce a sistematizzare tutto, cosa ormai impossibile nella società caotica in cui viviamo oggi. Ritrovare l'ebbrezza del sapersi perdere, provare il brivido di sensazioni intensamente legate alla vita interna e la possibilità di ritrovarsi fortemente in un'identità, una radice. Questa ambivalenza per me è proprio un sistema di navigazione in cui poter pensare. Lo stesso vale per l'impatto dei linguaggi: letterario, audiovisivo, musicale. Concepire la multimedialità come un cocktail: in realtà io la considero un percorso parallelo di linguaggi che hanno una specificità, una loro identità che non si può sciogliere in una soluzione unica. Se lavori con la musica credo che tu debba comunque lasciarle la sua capacità narrativa, così se lavori con le immagini o con altri sistemi. I linguaggi scorrono paralleli, se avvengono contemporaneamente si può saltare da uno all'altro e alla fine si incrociano. È importante conservare un'identità, perché le sollecitazioni sono spesso spaventose. L'arte contemporanea ci spinge tutti a correre dietro a qualcosa senza mai avere la possibilità né il tempo di dargli un indirizzo coerente, quello che poi forma la contemporaneità.


