L'edicola digitale delle riviste italiane di arte e cultura contemporanea
Juliet Anno Numero 99 ottobre 2000
New York news
Ivana Mulatero
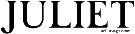
Art magazine
Adrian Paci
Maria Vinella
n. 173 giugno-luglio 2015
Case chiuse, corpi aperti
Roberto Borghi
n. 172 aprile-maggio 2015
Yang Xinguang e la materia
Sara Bortoletto
n. 171 febbraio-marzo 2015
Eugenio Re Rebaudengo
Giulia Bortoluzzi
n. 170 dicembre-gennaio 2015
Biennale Architecture
Gabriele Pitacco Marco Gnesda
n. 169 ottobre-novembre 2014
Biennale Marrakech
Emanuele Magri
n. 168 giugno-luglio 2014



Chi è Egizio Panetti? Figlio di genitori veneti, ma nato in Egitto (il nonno era egittologo ed ecco spiegato il nome di battesimo), Egizio è giunto nel 1982 a N.Y. per studiare alla Parson School of Design. Da allora, come un vulcano, ha prodotto e messo in pratica numerose idee, tutte legate al mondo dell'arte, dello spettacolo, del costume, e idee che si sono sviluppate nel tempo. Lo spazio Egizio's Project è come lo definisce lui stesso: "Un ombrello di tutte le cose che mi divertono". Egizio è dappertutto, fa di tutto e soprattutto quello che fa ha sempre la sua risonanza e questo non è cosa facile in una città come N.Y. "Sono stato uno dei primi a portare la musica afro-caraibica nei circuiti più ufficiali, a Manhattan, mentre continuavo a fare l'art dealer e a curare alcune mostre. Ho gestito locali, adesso da alcuni anni sono con Nell's il giovedì e il venerdì, dove presento sempre gruppi diversi, preferibilmente di musica etnica. Intanto ho creato una etichetta discografica grazie alla quale riesco a produrre la musica in cui credo. Ho anche progetti più grossi, ma ne parleremo quando diverranno certezze. Lo sai che Time Out mi ha messo perfino in copertina?" E molte altre riviste a giudicare dalla quantità di giornali e quotidiani come il New York Times che a più riprese lo ha intervistato e in cui lui viene celebrato come personaggio, come qualcuno capace di fare tendenza. Un servizio della Rai International realizzato a giugno di quest'anno, dedicato a dieci personaggi italiani famosi a N.Y., vede Egizio quale primo soggetto intervistato. Con l'apertura della galleria, avvenuta due anni fa, Egizio vuole dare spazio alle ricerche in cui crede, offrendo agli artisti l'opportunità di essere visti, apprezzati e richiesti da maggiori gallerie. "Questo una volta era il mio ufficio, poi mi sono detto perché non creare una galleria, ed eccomi qui. Ho esposto opere di Thomas Moller, Grimanesa Amoros e molti altri. Quest'estate farò un group show intitolato Women e in autunno la personale di Edwina Sandys, che è la nipote di Winston Churchill. Nel mentre sto pubblicando un libro di miei ritratti Myselves, realizzati da vari artisti, abbinato a una mostra che girerà per varie parti del mondo e toccherà anche l'Italia nel 2001". Situata quasi di fronte al Guggenheim Museum di Soho, la galleria è piccola ma permette di raccogliere e presentare al visitatore le opere esposte, in modo diretto, senza ricorrere a scenografici allestimenti. Panetti sta lavorando alla possibilità di un ampliamento degli spazi, un progetto che diverrà realtà nell'autunno, sebbene emerga tra le gallerie di Soho la preferenza a spostarsi più a sud, e cioè a Chelsea. Ormai da alcuni anni molte gallerie hanno traslocato da Soho, come Weber, Sonnabend, Nosei, e altre lo hanno fatto recentemente come Gagosian, altre lo faranno come Sperone Westwater. La Soho attuale è boutique, moda, design e arredamento. Molto diversa da come si presentava negli anni d'oro dei primi Ottanta. Un'osservatore d'eccezione come Corrado Levi, che visse a N.Y. in quegli anni, ci racconta: "Soho assorbì la linfa creativa prodotta dagli artisti e dalle gallerie improvvisate, nate per intuizione nell'East Village e seppe capitalizzarla, la rese fruibile e commerciale". Anche Rosma Scuteri, che ha da poco pubblicato un resoconto di vita e di lavoro nella grande mela ai tempi di Reagan, rileva: "E pensare che il primo Soho, quello scoperto e creato da Maciunas, era uno slum affollato solo da grandi magazzini abbandonati, interi piani di alti palazzi. (...) Bisognava percorrere lunghi blocks a piedi, prima di avvistare il primo grocery store dove potere fare la spesa. Non sembra esistere più un mondo specifico dell'arte, come non esiste più un mondo deviante o chiaramente dissidente che abbia adottato una formula di espressione differente e immediatamente riconoscibile".
Un'altra galleria che è borderline, nel senso che ha lasciato il vecchio spazio (ed è alla ricerca di uno nuovo) è quella di Holly Solomon, al momento ospitata nella stanza n. 405 del Chelsea Hotel (222 West, 23 Street). L'odore di pane abbrustolito si effonde per i corridoi di un edificio straboccante di sculture e quadri di artisti che hanno pagato in natura il pernottamento. L'hotel costruito sul finire del secolo scorso è divenuto famoso per aver ospitato Thomas Dylan, Arthur Miller e artisti come Mapplethorpe, cantanti come Patty Smith e persino nel 1912 i sopravvissuti del Titanic. Il senso di una costruzione che sopravvive a sé stessa ci accompagna alla porta di Holly Solomon. Chi ci riceve è Sara Jo Romero, la direttrice artistica e organizzativa della galleria. "Noi abbiamo ritenuto necessario lasciare Soho in quanto ci sembrava un quartiere più adatto a ospitare negozi tradizionali". Qual è la ragione per fermarsi al Chelsea Hotel? "Holly ha molti amici qui, sia nel mondo della moda che in quello dell'editoria e inoltre ci sono artisti e musicisti. Quando parlò con il padrone dello spazio precedente e seppe che avremmo dovuto traslocare, si dispiacque molto di dover lasciare la galleria. Non abbiamo avuto molto tempo per trovare uno spazio espositivo delle stesse dimensioni di quello che avevamo prima. Anni fa Holly aveva pensato di andarsene da qui perché se ne stavano andando in molti, ma penso che allora avesse valutato varie cose: le piaceva l'hotel, le piaceva il posto; come posizione è molto buona, per quanto riguarda il traffico è semplice da raggiungere, non è troppo ad ovest, come molte altre gallerie, e questo sicuramente ha influito sulla sua decisione; insomma... ecco perché adesso siamo qui!". Dando un'occhiata alla check list, gli artisti seguiti sono una ventina, tra cui William Wegman, Nam June Paik, Robert Barry e Douglas Huebler. Anche Piero Consagra. "È l'artista italiano che abbiamo esposto, e lui costituisce l'unico piccolo collegamento che abbiamo con l'arte italiana. Devo dire che non conosco quasi per niente i giovani artisti italiani, purtroppo. Ma è tutta colpa mia". Accanto ai nomi altisonanti ve ne sono altri di giovani che sono alle prime personali. "Noi lavoriamo con entrambe le tipologie. Lavoriamo con una varietà di artisti, da Julia Jacquette a Virgil Marti, che non hanno ancora esposto nei musei, sono agli inizi, e anche con Rob Wynne, di cui abbiamo allestito due esposizioni. È interessante notare come molte persone che da noi hanno acquistato opere di artisti affermati, poi abbiano comprato anche lavori degli artisti più giovani. Possiamo dire che lo fanno seguendo un percorso artistico coerente".
Howard Read meticoloso e asettico definisce il programma della Cheim&Read (521 West, 23 Street), una galleria che vanta la solidità professionale dei due soci attivi nel mondo dell'arte dalla fine degli anni Settanta, con un fiore all'occhiello: l'esclusiva sull'opera di Robert Mapplethorpe, fino alla sua morte avvenuta nel 1989. Autoritratti con la polaroid di Mapplethorpe del 1972-1974 inediti, sono appesi alle pareti bianchissime della galleria, e sono lavori straordinari che documentano le prime esperienze dell'artista con lo strumento fotografico. Mapplethorpe non si considerava un fotografo, i suoi ritratti fotografici gli servivano unicamente per le opere pittoriche che realizzava in quel periodo. Lui diceva che non gli piaceva la fotografia. Gli piaceva l'oggetto. È famosa la frase: "Amo le fotografie quando si tengono in mano". Ma che incidenza culturale ha una mostra di opere storiche di questo artista nel contesto attuale? "Noi siamo convinti che abbia un significato storico nel confronto con l'arte di oggi. Con questa mostra proponiamo una rilettura dei lavori di Mapplethorpe abbinata a un testo del 1989 di Richard Marshall, il quale mette a confronto opere realizzate nello stesso periodo da Acconci, Nauman e Burden, fino a individuare delle ascendenze nelle performance e nei video dei primi anni Novanta di Matthew Barney". Sembra che sia passato così tanto tempo, ma è solo dai primi anni ottanta che negli Stati Uniti la fotografia viene riconosciuta come forma d'arte a tutti gli effetti. "La fotografia potrebbe acquisire un tale riconoscimento ripercorrendone la storia", continua Read, che ha come background l'attività di fotografo, "penso che il passato della fotografia la porti a conquistare un posto di primo piano nelle gallerie. Analizzando il mercato dell'arte, le foto vendono più dei dipinti. Ci sono fotografie stampate in tiratura limitata che arrivano a un prezzo di $100.000/200.000/250.000. Ottime valutazioni. Succede raramente, ma credo che capiti anche perché il mercato trova la fotografia più accessibile, molto più facile da capire; probabilmente è considerata più semplice da comprendere rispetto alle opere pittoriche e scultoree contrassegnate da una sorta di ermetismo e di chiusura. Alcuni degli artisti più conosciuti oggigiorno hanno raggiunto una considerevole notorietà grazie alla fotografia: Jack Pierson costituisce un buon esempio di artista poliedrico come pittore, scultore, che oltre a creare con i colori e i materiali, crea anche con la fotografia; anzi è conosciuto principalmente come fotografo e ha cominciato la sua carriera artistica in questa veste. Penso che oggi sia riconosciuta la multimedialità creativa".
Chi meglio di Jeff Koons può incarnare la figura del'artista poliedrico? Quest'anno Koons ha deciso di sfidare il pubblico arricchendo il repertorio ormai ventennale con altri linguaggi espressivi e altri stili. Pot Rack è l'olio su tela di grandi dimensioni esposto alla collettiva inaugurale - riepilogativa dei 40 anni di attività - del nuovo spazio a Chelsea di Ileana Sonnabend (536 West, 22 Street). Dando un occhiata alla piantina della galleria e agli elenchi fotocopiati delle opere esposte, collocate nelle varie sale in ordine alfabetico, si apprende che questa nuova opera di Koons, dai colori piatti e zuccherosi, molto camp, è l'unica opera al momento a essere stata venduta per la cifra di $250.000. Nella stessa sala Steinbach e Bickerton presentano opere dei primi anni Novanta con valori che si aggirano sui $30.000/45.000, mentre i lavori di Warhol, Rosenquist e Arman degli anni Sessanta non sono in vendita. Non sono in vendita neppure le opere della stanza F, lavori storici di Rauschenberg, Nauman, Merz, Anselmo, e altre più recenti di Morris, Kounellis e Zorio. Una bella serie composta da ventisette immagini di Blast Furnace Typology (1999) dei Becher, con un valore di $108.000, conferma invece quanto detto da Howard Read a proposito delle ottime quotazioni della fotografia. La Stefan Stux Gallery (529 West, 20 Street), celebra i suoi vent'anni di attività con una collettiva che mette in luce alcuni artisti, passati e presenti, che hanno compiuto i primi passi con i fondatori Linda e Stefan Stux: Mike and Doug Starn, Serrano, Muniz, Timpson, Yamanaka, Hubble e Geerlinks. Un gruppo di artisti accomunati dal linguaggio fotografico sondato nelle sue più articolate possibilità espressive e ritenuto dagli Stux il medium dominante sul finire del XX secolo. Tra le proposte inedite si segnalano le grandi immagini della olandese Margi Geerlinks, sorta di manipolazioni digitali che esplorano i temi della creazione e ricreazione di corpi adulti, cuciti e ricostruiti da se stessi, come bambini da amare. Un'altra olandese, questa volta una pittrice di Rotterdam, Vanessa Jane Phaff, alla sua prima newyorchese presso la galleria I-20, situata all'ultimo piano dello stesso building. La Phaff è stata inclusa recentemente nella rassegna Examing Pictures, curata da F.Bonami e J.Nesbitt alla Whitechapel Art Gallery di Londra e al MoCA di Chicago. Aggirandoci nella grande sala della I-20 veniamo provocati dalle figure in vestitino azzurro e grembiulino, i protagonisti del mondo immaginario dell'artista. Questi adolescenti, quasi tutte ragazze, si trovano in un beato e pericoloso stato di noncuranza civettuola, ombrosi o grottescamente crudeli, in uno stato rilevante di nuova consapevolezza che non è qualcosa che si ricorda quanto piuttosto che si intuisce. Paul Judelson, il direttore della galleria aperta nel 1997 ci accompagna sul terrazzo a cui si accede direttamente con una scaletta di metallo, e da lì si gode una bella vista sullo Hudson river. Intanto Judelson ha alle spalle una decina d'anni come art dealer che ha svolto in proprio prima di aprire lo spazio diretto insieme a Gil Presti e Duane Hanson jr. In quei dieci anni ha fatto di tutto. Ha organizzato nel 1989 una collettiva di undici artisti sovietici provenienti da Leningrado, ora San Pietroburgo. Tra questi vi erano Timur Novikoy, Yevgeny Ufet e Sergei Bugaev Afrika che hanno rappresentato il Padiglione Russo all'ultima Biennale di Venezia. Judelson ha realizzato il suo primo progetto a Chelsea nel 1991, quando lui e Afrika salvarono dalla distruzione l'ultima statua di Lenin durante il fallito colpo di stato nel luglio di quell'anno. Le quattro tonnellate della statua furono trasportate a N.Y. e mostrate in una installazione permanente per tre anni al pianterreno di un magazzino situato nelle vicinanze dell'attuale galleria. I progetti internazionali, a galleria ormai aperta, sono stati: la performance di Spencer Tunick a Vienna nell'ottobre '99 e le installazioni multimediali di Peter Sarkisian al Museo Picasso di Antibes. "È una programmazione internazionale la nostra", dice Judelson, "lavoriamo con cinque artisti di Los Angeles, un numero analogo di artisti di N.Y., un'artista di Santa Fe, due olandesi, due russi di San Pietroburgo, un artista estone". Tutti rigorosamente agli esordi. "Noi preferiamo presentare artisti vergini, generalmente molto giovani, talvolta alla loro prima esperienza espositiva, oppure alla prima esposizione a N.Y.". La collocazione a Chelsea è senz'altro un altro fattore importante per questa galleria unitamente a un programma di tipo multimediale e internazionale. "Tre anni fa, quando aprii lo spazio avevo molti visitatori, ma ora che anche altre gallerie hanno aperto a Chelsea, i miei acquirenti, spesso russi, possono andare un po' ovunque, in diversi spazi espositivi. Qui a N.Y. tutto ruota intorno alla programmazione delle gallerie ed è molto importante sia ciò che si programma, sia i lavori esposti e sia i singoli artisti presentati: sono questi gli aspetti più rilevanti". Qualche piano più sotto si trova John Weber, storica galleria che segnò la vita artistica newyorchese negli anni '70 a Soho. Memorabile in tal senso fu la performance di Joseph Beuys, I Like America and America Likes Me, in cui l'artista tedesco era avvolto in una coperta di feltro con in pugno un bastone e un coyote che si aggirava per lo spazio. Quelli erano gli anni in cui Jeffrey Deitch era l'assistente di Weber, il quale ci riceve con un aria da urban cowboy invecchiato ma disponibile, sincero e attento. In questo suo nuovo spazio, una personale di Lucio Pozzi si è appena conclusa e una collettiva è in allestimento dal titolo Political Art - A Survey con lavori di Boetti, Burgin, Gaines, Haacke, Holzer, Jones, Kruger, Lombardi, Moffat, Pozzi, Reinhardt, Rios, Saà, Schneeman, Tjapaltjarri e Zorio. Nomi conosciuti e seguiti dagli esordi e altri proposti per la prima volta come nel caso dell'aborigeno Tjapaltjarri che dipinge particolari paesaggi per protesta contro la distruzione della natura. La vena corrosiva e critica non attraversa solo come un filo rosso la collettiva, ma anima anche Weber che dichiara: " Le ragioni per le quali galleristi e artisti se ne vanno da Soho sono soprattutto di carattere economico, e anche estetico. Troppa gente per le strade in cui circolano delle bruttissime automobili; bisogna evitare di andare a Soho in macchina, ci si perde facilmente in quella zona... L'altra ragione è che non ci potevamo più permettere lo spazio. I costi degli affitti avevano raggiunto cifre di $12.000/14.000 al mese, che sono cifre incredibili e con i prezzi in continua ascesa, gli affitti pluriennali potevano costare anche milioni di dollari. E poi di Soho mi ero stufato, ci sono stato troppi anni, mentre Chelsea è un quartiere nuovo, ricco di energie. Qui non c'è niente, ci si può arrivare solo in taxi, ma si possono avere tante galleria da vedere e adesso ce ne sono centocinquanta in questa zona, che va dalla dodicesima alla ventisettesima strada". Da cosa è data l'energia che proviene da Chelsea? "Da uno strano miscuglio di operai e artisti. Ci sono molte industrie e si crea una sedimentazione sociale particolare. C'è sempre molto movimento per strada, non ci sono boutique che ti possano togliere la concentrazione: è un'area immensa. Puoi solo sporgerti e passare il tempo ad annoiarti guardando il fiume scorrere". Il suo futuro è dunque qui? "No, non sarà qui. In questo building c'è posto solamente per ventidue spazi espositivi. Prima, a Soho, la galleria era molto grande. Noi abbiamo bisogno di un posto più grande, quindi non ci starò tutta la vita". Quale la programmazione? "Ho pensato agli artisti più diversi, da quelli seguiti da anni alle nuove leve. Mi piace esporre opere dei giovani. Espongo anche artisti europei perché non ho mai pensato che l'arte avesse delle frontiere; secondo me rappresenta una sorta di linguaggio universale. Sto progettando di esporre molti artisti provenienti da fuori America". Quali? "L'artista spagnola che vive a Londra Angela De La Cruz, due artiste portoghesi, Rosa Almeida e Joana Rosa, un italiano Massimo Antonacci". Gli artisti con cui Weber lavora da più tempo sono Haacke, Burgin e Gastini. "Gastini mi piace molto. Non è famoso perché i suoi lavori non piacciono a Germano Celant e quest'ultimo lo esclude dalle mostre e non lo cita nei libri che scrive. È un peccato che un critico abbia tutta questa voce in capitolo". Qual è il peso della critica nel sistema dell'arte americano? "Negli Stati Uniti i critici non sono molto importanti. Penso che in Italia siano più autorevoli perché controllano il mondo dell'arte. Lo controllano troppo. I critici italiani hanno un potere incredibile. Sono loro al comando e pretendono di avere il predominio, mentre negli Stati Uniti la situazione è strutturata in un altro modo: al centro di tutto c'è l'artista, poi il gallerista. Spetta al gallerista decidere se esporre o no un artista e solo dopo questo passaggio entra in scena il critico. Poi viene la gente, arrivano i visitatori, ma la prima scelta è quella del gallerista".
N.Y. allora come la Roma imperiale. Se la storia insegna qualcosa, l'egemonia politica ed economia americana è destinata a perdurare per almeno duemila anni. Secolo più, secolo meno.
Ivana Mulatero


