L'edicola digitale delle riviste italiane di arte e cultura contemporanea
Juliet Anno 20 Numero 109 settembre 2002
Documenta11: una lunga estate umida
M. Bortolotti, R. Vidali, E. Zanichelli
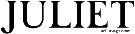
Art magazine
Adrian Paci
Maria Vinella
n. 173 giugno-luglio 2015
Case chiuse, corpi aperti
Roberto Borghi
n. 172 aprile-maggio 2015
Yang Xinguang e la materia
Sara Bortoletto
n. 171 febbraio-marzo 2015
Eugenio Re Rebaudengo
Giulia Bortoluzzi
n. 170 dicembre-gennaio 2015
Biennale Architecture
Gabriele Pitacco Marco Gnesda
n. 169 ottobre-novembre 2014
Biennale Marrakech
Emanuele Magri
n. 168 giugno-luglio 2014



Il progetto politico di Documenta 11 appare evidente. Ciò che il curatore prova a mettere in discussione è la concezione occidentale dell'opera d'arte, secondo lui esportata e imposta, in modo più o meno esplicito, dai processi di globalizzazione. Quello che egli ha in mente non è una concezione generica dell'opera, riconducibile al corso della tradizione dell'Occidente, ma la concezione che si è imposta nella Modernità del secolo scorso.
Scrive Okwui Enwezor in catalogo (Platform 5: Exhibition, Cantz Ed.):
"Oggi, l'avanguardia è così completamente disciplinata e addomesticata all'interno dello schema dell'Impero che un'intera e diversa serie di modelli regolatori e di resistenza deve essere trovata per controbilanciare il tentativo totalizzante dell'Impero. [ ...] Nella situazione della post-colonialità ci vengono continuamente offerti contro-modelli attraverso i quali i rimossi -coloro che sono stati posti ai margini dal piacere della piena partecipazione alla globalità- foggiano nuovi mondi producendo culture sperimentali. Con il termine culture sperimentali vorrei qui definire un insieme di pratiche con cui le culture che escono dall'imperialismo e dal colonialismo, dalla schiavitù e dal vincolo contrattuale dell'apprendistato [ indenture], compongono un collage di realtà mediante i frammenti di spazio collassato".
In questi termini, egli prova a tracciare una concezione dell'opera che si pone al di fuori dell'arte occidentale, confortato dal lavoro di artisti che operano in varie parti del mondo. Il suo è il tentativo di riconoscere e rendere evidente il legame che s'instaura in alcuni luoghi del pianeta tra le opere d'arte e la dimensione quotidiana degli stili di vita, in un processo di scambio continuo che non delinea una nuova concezione teorica dell'opera (almeno non si trova traccia di questo nel saggio in catalogo), ma che afferma la presenza di una realtà artistica che egli semplicemente riconosce, conferendole dignità di esistenza e cercando di spostare su di essa l'attenzione del mondo dell'arte. Tale arte costituisce una presenza che vive ai margini dei processi di globalizzazione che hanno già incorporato l'arte occidentale formata sul modello dell'avanguardia. Di lì scaturisce la critica all'arte dell'avanguardia, divenuta sempre più auto-referenziale e di cui sopravvive un modello culturale privo di effettivo riferimento alla sostanza delle opere che si collegano alla vita contemporanea.
Ciò che in questo modo egli viene affermando è l'idea di un realismo delle opere d'arte che si esprime nella loro capacità di collegarsi a un contesto indipendentemente da ogni cornice teorica. Questo legame diventa l'espressione di un'arte che rifiuta ogni punto di vista antropologico (o antropocentrico), per orientarsi verso una condizione di "comunità che vive ai margini". La comunità esprime, infatti, una maggiore senso democratico per il suo strutturarsi secondo proprie necessità interne e secondo le esigenze del territorio in cui vive. Mentre l'arte trae forza ed evidenza dalla sua capacità di porsi come espressione delle relazioni costruite dalle comunità.
(...)
Maurizio Bortolotti
(...)
"A CONSTITUVE MAP OF CONTEMPORARY KNOWLEDGE CIRCUITS: ART, THEORY, SCIENCE, CULTURE, ECOLOGY..." Documenta 11 è stata globale, multidisciplinare, creola, ideologica, radicale, filosofica, ma non bella. È stata anche impeccabile (senza un filino fuori posto), garbata (con cataloghi utili e interessanti), perfetta (nella sequenza della regia degli allestimenti), ma non bella. È stata anche spettacolare, ma non bella, nel senso che non cattura, non affascina, non coinvolge, dato che mr Okwui non ha voluto solleticare il nostro piacere, ma gettare frecce al nostro intelletto. La bellezza appartiene a un sistema conchiuso e mr Okwui ha invece voluto lavorare in quella terra sconfinata dove l'utopia incontra il desiderio di evasione di ogni disgraziato (affermano i dati ONU che ben 700.000 persone, ogni anno, cercano nella fuga e nello sradicamento una vita migliore, finendo spesso vittime dela violenza). In questo modo la mostra ci ha indicato molto bene ciò che le cose non dovrebbero essere, non sempre altrettanto bene quello che sono. Qualche tabella schematica, che aiutasse a chiudere il cerchio dei 116 artisti invitati, sarebbe stata bene accetta. Non che questo avrebbe potuto cambiare il futuro dei derelitti, dei naufraghi, dei diseredati, ma ne avrebbe contestualizzato in modo più pertinente la marginalità.
"SPECTACULAR DIFFERENCE PROCEEDS NOT SIMPLY FROM THE DIFFICULT-TO-SUSTAIN NOTION OF ART'S ETERNAL AUTONOMY FROM ALLA DOMAINS OF SOCIO-POLITICAL LIFE". All'ombra di Guy Debord, abbiamo trovato ore su ore di filmati (schermi piccoli e grandi, installazioni, impianti computerizzati) di altissimo livello qualitativo/contenutistico, quanto impossibili da visionare nella loro interezza nel tempo che ragionevolmente si dedica a una mostra. Suggerimento: che la battaglia futura sia per un network europeo (una specie di Documenta permanente) che trasmetta questi e altri video alternativi o di denuncia: a casa, sul sofà, con il telecomando in mano diventerebbe tutto di più facile (e democratica) assimilazione (i pochi penalizzati, a causa della complessità della loro installazione, come Eija-Liisa Ahtila, portino un po' di pazienza per favorire i molti che non perderebbero nulla).
(...)
"DOCUMENTA 11 WAS CONCEIVED NOT AS AN EXHIBITION BUT AS A CONSTELLATION OF PUBLIC SPHERES". Ne consegue l'impianto informazionale e di denuncia di tutta l'architettura espositiva. Ebbene, perché cercare una competizione impossibile? Un fotoreportage, un filmato CNN o un qualsiasi numero di Colors sono più informazionali, completi, attuali e propositivi dell'insieme delle opere esposte a Documenta 11.
Allora, senza arrivare allo sproposito di M.Fuksas (secondo cui l'aspetto più encomiabile di questa edizione di Documenta è l'aver recuperato a spazio espositivo la Binding-Brauerei), diciamo però che avremmo preferito una mostra con qualche rischio in più e qualche castello ideologico in meno. Comunque, grazie alla sua utopia di fondo che la attraversa in lungo e in largo, questa Documenta rimane una mostra degna del massimo rispetto e della più grande attenzione.
R.Vidali
(...)
A Kassel si respira decisamente aria nuova. La quinta piattaforma dell'undicesima Documenta fa parlare e discutere tutta l'estate. Non solo gli ospiti. Piove il giorno della preview. Piove all'inaugurazione. Sul concetto di Unwetter (perturbazione) gli "artarbeiters" (studenti del seminario "Ideas Lab", coordinato da Sarat Maharaj, cocuratore di Documenta 11, professore di storia dell'arte al Goldsmith College, e docente alla Humboldt di Berlino per due semestri) improvvisano un picnic discorsivo sul prato umido di fronte all'Orangerie, stimolati dall'epistemologia etica che ormai è diventata la parola d'ordine).
Piove anche il secondo week-end di luglio, in occasione del workshop dei Raqs Media Collective da Nuova Delhi. Paradigmatico per le sperimentazioni di détournement del quotidiano - ricerca alternativa, quasi sovversiva rispetto ai consueti canali della spettacolarizzazione dell'opera d'arte vigente in Occidente - come nel caso di buona parte di artisti che lavorano in collettivi (tra i più interessanti: Huit Facettes, Black Audio Film Collective, The Atlas Group), l'esperienza maturata dai Raqs Media Collective (Jeebesh Bagchi, Monica Narula e Shuddhabrata Sengupta) vanta negli ultimi anni di un ulteriore canale divulgativo in collaborazione con esperti internazionali del settore, Sarai (www.sarai.net, la prima iniziativa votata a cultura urbana, media e vita quotidiana nell'Asia del Sud). Il workshop si svolge nel corso di due giorni presso il VIP-lounge della documenta-Halle sotto il titolo "Signs in the Shadow of the Laws of Space", e cerca di individuare possibilità di chiusura e apertura nello spazio urbano e nella pratica dei "Digital Commons". Tra i diversi interventi in occasione del workshop, interessanti quello sulla cultura della copia (del Prof. Ravi Sundaram, collaboratore di Sarai) e su legge e creatività, tenuto dall'avvocato Lawrence Liang (attivo a Bangalore) a proposito dei diritti della proprietà intellettuale nell'era dei collettivi e del free software, ovvero: come proteggere un'idea di questi tempi.
Proprio nella documenta-Halle, anche se dapprincipio l'impressione ricavata dall'iperdose di documentazione più che snervare dà l'impressione di un documentiamo-tutto-per-non-cambiar-niente, dopo una seconda visita, ed un'osservazione più attenta le opere e il progetto curatoriale prendono forma. Pascale Marthine Tayou (*1967, Kamerun) con "Game Station" procura un tono risolutamente divertito alla ambita globalizzazione da tecnologia quotidiana: si arriva a una costruzione di legno che ricorda le saune svedesi tramite una voluta di cemento illuminata a neon di diversi colori, passando per un'anticamera del caos quotidiano: una serie di televisori trasmettono tra distorsioni e frequenze disturbate scene dalle strade africane, al soffitto sono appese una serie di cuffie di diverse dimensioni irraggiungibili dal pubblico.
Senza dubbio questa è la Documenta del secolo, se non altro perché si tratta della prima. Il curatore di origini nigeriane residente a New York Okwui Enwezor (*1963) poeta, critico d'arte e curatore, nomina per la prima volta nella storia della quinquennale un consistente team curatoriale (Sarat Maharaj, Carlos Basualdo, Ute Meta Bauer, Mark Nash, Susanne Ghez, Octavio Zaya). Così Okwui Enwezor parla di dinamica discorsiva iniziata già quattro anni fa con la preparazione delle Plattform che ora, con l'esposizione, si può dir conclusa. La quinta delle piattaforme si prospetta densa e dotata di una base consistente dopo le quattro precedenti (1:"Democrazia come processo irrealizzato"; 2: "Esperimenti con la verità"; 3: "Creolità e creolizzazione"; 4: "Sotto Belagerung: quattro città africane - Freetown, Johannesburg, Kinshasa, Lagos", tenutesi rispettivamente a Berlino/Vienna, Nuova Delhi, Santa Lucia, Lagos).
Enwezor parla nel suo intervento nel catalogo di discussione analitica a proposito di arte contemporanea, visual culture e rispettive dinamiche di messinscena. Parla di spostamento di limiti disciplinari e culturali in concomitanza con ulteriori ordini di rappresentazione, spazzando così in uno statement le diatribe 'Visual Culture versus Storia dell'Arte' che attualmente animano gli atenei à la page. Non è insomma un caso che il catalogo della quinta Plattform (l'esposizione stessa) si apra con documentazioni fotografiche che spaziano dalla guerra civile in Algeria al G8 alle studentesse palestinesi manifestanti nella striscia di Gaza. Ai Postcolonial Studies il merito di aver aperto il varco della cultura sperimentale, al di là di quanto codificato e determinato dal modello imposto dalla globalizzazione da Empire. E allora, viva la molteplicità, il grande merito di questa esposizione. Georges Adéagbo (*1942 Benin, dove vive) colleziona appende mescola installa oggetti trovati della cultura occidentale ed africana in una sorta di viaggio immaginario. Egli stesso sottolinea come non si tratti tanto di un intento estetico quanto di una personale passione.
(...)
Elena Zanichelli


