L'edicola digitale delle riviste italiane di arte e cultura contemporanea
Juliet Anno Numero 89 ott-nov 98
MARIO MAFFI
a cura di Elena Carlini e Pietro Valle
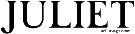
Art magazine
Adrian Paci
Maria Vinella
n. 173 giugno-luglio 2015
Case chiuse, corpi aperti
Roberto Borghi
n. 172 aprile-maggio 2015
Yang Xinguang e la materia
Sara Bortoletto
n. 171 febbraio-marzo 2015
Eugenio Re Rebaudengo
Giulia Bortoluzzi
n. 170 dicembre-gennaio 2015
Biennale Architecture
Gabriele Pitacco Marco Gnesda
n. 169 ottobre-novembre 2014
Biennale Marrakech
Emanuele Magri
n. 168 giugno-luglio 2014

Mario Maffi è esploratore degli universi urbani e letterari delle città d'America, in particolare di quei quartieri abitati da etnie diverse che costituiscono forse la dimensione più vera dell'identità del nuovo mondo. Attraverso una ricerca paziente, Maffi ci fa conoscere una letteratura che esprime la vitalità dei ghetti e le voci di autori che erano state per troppo tempo tenute nel silenzio.
"Il mio interesse nei confronti di New York è nato a metà degli anni '70 quando stavo lavorando al mio terzo libro La Giungla e il Grattacielo che analizzava il rapporto tra letteratura ed evoluzione della società americana a cavallo tra ottocento e novecento. Cominciai a leggere delle autobiografie di immigrati e a studiare indagini fotografiche come How the Other Half Lives di Jacob Riis. Da queste letture e da una serie di incontri avvenuti durante delle visite a New York, nacque il progetto di indagine su un quartiere, il Lower East Side, a cui lavorai dal 1983 al 1992 quando uscì il libro Il Mosaico della Città. L'arrivo a New York avvenne a poco a poco, focalizzando gradatamente i miei interessi su un quartiere visto come un laboratorio della cultura del '900 e una lente di ingrandimento per comprendere l'America.
"Di solito si sente dire che New York è la meno americana tra le città statunitensi. Io non penso che sia così. Può darsi che questo sia vero per quel che riguarda l'aspetto visivo ma, almeno nel campo della letteratura, New York è stata il centro della scoperta della nuova America urbana, il magnete dello sviluppo di una nuova letteratura diversa da quella dell'ottocento e orientata già verso il nostro secolo. Mi riferisco a Stephen Crane, a William Dean Howells e a tutti quei romanzi di fine secolo che sono, secondo me, stupefacenti perché segnano il primo incontro con la civiltà metropolitana, un impatto di occhi non abituati alla realtà urbana e che presentano una vitalità e una capacità di cogliere certi aspetti della città assolutamente straordinarie. Attraverso il novecento c'è poi tutto il discorso sul modernismo letterario sia in poesia che in narrativa, da Dos Passos a Henry Roth, e poi di tutte le letterature legate alle comunità, quella ebraico-americana, quella italoamericana, quella afroamericana: insomma c'è il progressivo espandersi di un universo metropolitano con episodi e momenti che si incrociano e si superano fino alla contemporaneità della New York multietnica che reinventa addirittura la lingua incrociando l'inglese con gli idiomi delle varie comunità. Per certi versi si può dunque dire che in America ci sono vari paesaggi letterari ma che New York è l'unico luogo che li include tutti. New York è stata il magnete, la cartina di tornasole e anche il buco nero entro cui tutto precipitava, soprattutto tra ottocento e novecento. Per esempio: si dice che New York è la realtà urbana per eccellenza, ma non è un caso che quando Buffalo Bill smette di fare il cacciatore di bisonti e organizza il suo circo, va proprio a New York e in particolare a Coney Island a mettere in scena il suo Wild West Show, nel luogo per eccellenza dove si coniuga spettacolo popolare e tecnologia. New York rappresenta dunque in quegli anni a cavallo del secolo e poi per tutto il novecento, il palcoscenico dove mettere in scena l'America, non solo quella urbana ma anche quella dell'interno, della frontiera. A livello della lingua parlata c'è tutta una serie di questioni legate allo slang newyorchese che sorgono da questo impatto tra small town e realtà metropolitana. Nascono una serie di soluzioni linguistiche derivate dal tentativo di dire, di descrivere le dimensioni della città.
"Grazie all'interazione di diverse comunità, quartieri come il Lower East Side avevano prodotto delle forme di cultura estremamente vitali sin da quando erano diventati centri d'immigrazione alla fine del secolo scorso; c'era dunque un percorso precedente che da qualche parte doveva necessariamente condurre. Quando ho cominciato a lavorare sul campo ho capito che questa tradizione continuava nell'oggi con le nuove comunità d'immigrazione arrivate soprattutto dall'Asia e dai Caraibi. Ho cercato di incontrare personalmente buona parte di questi autori attivi a New York, sia asiatico-americani che portoricani e da lì è nata poi un'interazione che è sfociata in vere e proprie collaborazioni con letture pubbliche ed edizioni scritte. Ho sempre avuto un forte interesse nel conoscere questi scrittori nel loro luogo di vita, di creazione, di esperienza. Volevo capire qualcosa di più su di loro anche perché la loro letteratura, per quanto pubblicata nella forma tradizionale dei libri stampati, ha una dimensione orale, parlata che richiede inevitabilmente la presenza fisica dell'autore per cui il contatto personale era un passaggio obbligato. Io non riesco a lavorare solamente sui testi o negli archivi: ho bisogno di una conoscenza diretta, di un dialogo con chi scrive. L'esperienza narrata nella letteratura e poesia del Lower East Side è sintomatica perché descrive una condizione di sradicamento, di abbandono e di sfruttamento veramente drammatica. Nello stesso tempo, l'altra faccia della disperazione urbana è una straordinaria resistenza quotidiana alle forze dello sradicamento che si esprime nella reinvenzione degli spazi, nella ridefinizione della propria vita all'interno della metropoli, nel dare voce a istanze collettive di fronte a forze che tendono alla frammentazione, all'isolamento, all'individualismo. Questo sforzo è forse il motore che mi ha spinto a conoscere a esplorare questo quartiere e queste comunità. La visione comune che si ha dell'America e di New York oscilla tra gli estremi delle immagini patinate dei depliant turistici e il sensazionalismo dei crimini e della violenza. Il mio tentativo è sempre stato quello di descrivere il territorio che c'è in mezzo tra questi due estremi, un territorio incredibilmente fertile ma anche difficile perché cerca quotidianamente di resistere e non può essere romanticizzato. È un po' il discorso dei giardini del Lower East Side che sono la materializzazione simbolica di quello che cerco di dire. Questi giardini sono costruiti negli isolati lasciati liberi dalle demolizioni con gli oggetti trovati per strada e rispondono alla volontà di voler costruire qualcosa di vivibile in due metri quadrati che non rimangano fatiscenti ma diventino un centro di aggregazione. È questo territorio di mezzo che ho cercato di esplorare sia in termini sociali che letterari.
"La cultura orale, la comunicazione diretta, così presenti nel contesto urbano ad alta densità, sono forme di trasmissione di identità presenti anche nelle culture rurali d'immigrazione in particolare nel sud degli Stati Uniti, in spazi molto più dilatati ma dove il legame con il gruppo etnico è fortissimo. Penso che ci sia un rapporto profondo tra questi due contesti perché, per esempio, nei portoricani a New York, le forme letterarie e di comunicazione che emergono dalla loro esperienza, il canto, il teatro o anche le modalità di aggregazione spontanee come il trovarsi agli angoli delle strade, rimandano a delle esperienze precedenti, contadine che derivano da una situazione rurale come quella portoricana che per molti versi è simile a quella del sud. Ci sono dei denominatori comuni anche se certamente nella città il tempo, la durata, è differente. Diverso è anche il tempo degli immigrati rispetto a quello della città: essi cercano di resistere all'accelerazione imposta dalla vita urbana. Non lo possono fare completamente perché l'accelerazione è legata alla possibilità e al ritmo del lavoro. Ho notato tuttavia come i tempi sono molto allungati nel ghetto: c'è il tempo dell'abbandono, dell'attesa, della disoccupazione, del non aver nulla da fare, oppure c'è il tempo frenetico del correre per sopravvivere. Vi è una continua dialettica tra un rallentamento forzato, un rallentamento ereditato dalla tradizione contadina e un'accelerazione imposta dalla sopravvivenza. C'è poi una resistenza a quest'accelerazione forzata che si lega alla tradizione del movimento operaio, al tentativo di non venire completamente assorbiti dal ritmo della macchina e al mantenere un qualche brandello di identità rallentando un ritmo imposto dall'esterno. Questo mi sembra un aspetto interessante di queste comunità. C'è una memoria rurale, c'è una memoria collettiva che è anche memoria del passato del quartiere di immigrazione, questo soprattutto nel Lower East Side. È una memoria di organizzazione, di affermazione sindacale; c'è insomma un'identità forte del quartiere presente nei murales dipinti nelle strade, nella stessa poesia del quartiere, nel modo in cui il luogo ricorda se stesso. è un qualcosa che magari non filtra in tutti allo stesso modo ma funge da cemento collettivo e lascia delle tracce molto forti.
"Buona parte delle forme espressive delle comunità immigrate si colloca in un orientamento di stampo realista. Il realismo è stato il primo filone dell'arte americana a svilupparsi in maniera autonoma e proprio i quartieri di emigrazione hanno alimentato questa scuola. Per esempio la scuola dei bidoni della spazzatura, la Ashcan School di John Sloan è nata proprio dalla scoperta di questi quartieri che rappresentavano un enorme potenziale umano di ispirazione alla rappresentazione. Poi con la seconda guerra mondiale c'è stata la divaricazione: il mercato dell'arte scoprì l'espressionismo astratto e il filone più realista venne marginalizzato. Quest'ultimo tuttavia continuò sotterraneo e parallelo alle avanguardie praticamente fino ad oggi. Molti artisti contemporanei delle comunità immigrate si collocano in un filone di stampo realista. Penso a un pittore cinese-americano che si chiama Martin Wong, o a un disegnatore che si chiama Eric Drooker, uno straordinario illustratore che ha creato dei romanzi senza parole che rimandano ai grandi pittori dell'espressionismo centro-europeo dell'inizio secolo. Lo stesso impianto di tipo realista vale per i pittori di murales che raccontano le storie del quartiere attraverso immagini. Anche nella letteratura c'è questa dimensione di riscoperta del passato dei quartieri, di legame stretto con la fisicità della città. Per esempio un autore che io amo moltissimo è Jerome Charyn che ha scritto una serie di racconti polizieschi molto belli in cui è molto presente questa stratificazione di immigrazioni e culture diverse. Ciò è presente poi in tutti gli autori Portoricani, anche in quelli, come Pedro Pieri che sembrano essere più visionari. In loro c'è una presenza forte della fisicità della città, anche nella lingua, molto legata ai gerghi e ai ritmi della strada, quasi quest'ultima fosse una condizione inevitabile, una seconda natura da cui non ci si può distaccare.
"La natura ha avuto un ruolo molto contraddittorio nella cultura americana. La wilderness, questa parola intraducibile che significa letteralmente "luogo selvaggio", non è certo la natura conciliante dei romantici inglesi o centroeuropei. C'è un rapporto contrastato con la natura perché essa rappresenta, almeno per la cultura bianca, l'ignoto, gli indiani, quella parte non riconducibile al proprio senso dell'ordine. Da quando la città appare con forza sullo scenario americano, vengono proiettati su di essa tutta una serie di elementi che appartengono all'esperienza e alla visione della natura per cui si parla di city wilderness o di giungla, come nell'omonimo romanzo di Upton Sinclair. Anche il discorso sui percorsi all'interno della città, mediato dalla cultura europea (Walter Benjamin parlava di perdersi nella città come perdersi in una foresta) rende vivo il senso di un territorio che deve essere esplorato. Si parla di paths, di sentieri. Anche Central Park fa in modo che il "sotto" della città affiori con le rocce di scisto. Ci sono sempre questi doppi significati, questo senso di un percorso più naturale che si contrappone all'ordine della maglia ortogonale di strade e della compressione razionale entro cui è forzata la città. Ho scoperto una frase molto interessante di O'Henry, uno scrittore di inizio secolo, il quale diceva che nella natura ci si muove con movimenti circolari dove si ritorna sempre al luogo di partenza. In una città come New York, organizzata secondo una griglia, è più difficile tornare al punto di partenza, ci si muove su percorsi lineari, si è proiettati oltre. Di fronte a questa dispersione, la metropoli si organizza per parti, quasi per villaggi marcati da specifiche zone d'ingresso e vie d'accesso. È un modo di costruirsi una centralità ed è una differenziazione legata al passato perché questi villaggi hanno tutti un'identità storica alle spalle. In una città che si dice vivere sempre al presente, i quartieri hanno un lunghissimo passato segnato da forti trasformazioni urbanistiche e sociali che è possibile esplorare. Nella geografia mentale degli abitanti, il quartiere rappresenta un mondo interno conosciuto con sistemi interpretativi ed esperienziali che si contrappone a un esterno diverso. Questo tema ritorna in una serie di autobiografie di immigrati di varie etnie che presentano proprio questa dinamica tra interno ed esterno, tra grande città e villaggio all'interno della città.
"La questione del legame delle comunità urbane d'immigrazione con il paese d'origine è invece più sfumato di quanto si possa credere. Per i portoricani di New York c'è certamente il ricordo dell'isola da cui provengono ma essa diventa in fondo un'entità quasi astratta: Portorico fa ormai parte degli Stati Uniti. Queste persone vogliono essere riconosciute come portoricani a New York e non come isolani. Il ritorno alle origini è forse mai possibile? C'è un retaggio legato al luogo d'origine ma il mare in cui bisogna nuotare oggigiorno è quello americano. Con le nuove generazioni si elidono poi i rapporti tradizionali legati alla famiglia e alla comunità che erano stati importati dal paese di origine e mantenuti dalle prime generazioni. Ci sono tutta una serie di storie legate al rapporto di un'etnia con il paese d'origine come quella dei Cinesi che, alla fine dell'ottocento, videro vietata dal governo federale l'immigrazione delle donne per cui si formò la cosiddetta "società degli scapoli". C'è il caso dei Giapponesi residenti in America, reclusi nei campi di concentramento durante la seconda guerra mondiale. Ci sono tantissimi problemi specifici che segnano fortemente la vita di una comunità e tuttavia le nuove generazioni sentono molto meno la gerarchia di ruoli legata alla cultura d'origine che è stata poi sbriciolata dalla vita in America e questo è un po' il tratto comune a tutte le comunità d'immigrazione.
"Sicuramente il mito americano ha condizionato moltissimo tutti coloro che arrivavano nel nuovo continente. Attraverso tutta la storia degli immigrati c'è questa continua dialettica tra mito e realtà con strati più o meno consistenti (dovuti alle comunità o al periodo) di immigrati che accedono all'americanizzazione e riescono a scalare un successo più o meno effimero. Poi c'è sempre l'elemento della disillusione. Nella letteratura degli immigrati vi è un continuo riferimento alla figura di quello che "è riuscito" ma paga il prezzo del successo con un senso di abbandono e di isolamento. Si parte da una collettività che può essere etnica o di classe e si arriva ad essere individui ma si perde qualcosa lungo il percorso. Questo è chiarissimo in tutta la letteratura ebraica, asiatica e anche italiana. Si ricorda con nostalgia quando si viveva nel quartiere immigrato e c'era un senso di comunità e di supporto collettivo, le porte erano sempre aperte. Poi c'è invece la rat race, la corsa dei topi dove ciascuno deve badare a sé stesso. Questo modello è ricorrente in tutta la letteratura degli immigrati. Il discorso di New York è poi potentemente basato sull'idea che a New York si può avere successo e l'immagine prevalente, o meglio quella imposta dai media, è un'immagine che sto cercando di smitizzare nel nuovo libro per mostrare invece tutte le diverse facce con cui la città si esprime.
"Negli ultimi 10-15 la molteplicità etnica sembra essere stata riconosciuta anche da una certa cultura ufficiale. La questione mi sembra viziata perché ha assunto un profilo esagerato in quanto fenomeno di moda legato a contesti specifici come l'università o certi giornali che ne hanno amplificato l'eco. A me non sembra che sia cambiato molto nella vita di ogni giorno delle comunità d'immigrazione e questo sia dal punto di vista economico (anzi, esse vivono probabilmente peggio visti gli sviluppi di questi ultimi 15 anni) che da quello del peso che gli autori di queste etnie hanno nel panorama culturale americano. È vero che grosse case editrici hanno cominciato a pubblicarli però tutto ciò non ha cambiato la vita degli scrittori che conosco. Certo è più facile farsi sentire ma, vista l'importanza della cultura orale in queste comunità, non è la pubblicazione l'aspetto fondamentale. Essendoci una maggiore attenzione da parte dei media, giovani autori vengono ogni tanto pescati dal ghetto e resi famosi. Tuttavia questo avviene spesso casualmente e non ha apportato un cambiamento significativo nella situazione generale dei gruppi sociali emarginati. C'è anzi la percezione di un certo colonialismo culturale, dell'impossessarsi da parte dei media della loro storia. Mi ricordo che le prime volte che mi muovevo nel Lower East Side, incontravo una notevole diffidenza che giudicai perfettamente legittima. Tutti pensano che vai lì a curiosare per poi fare il tuo trampolino di lancio usando le esperienze altrui. Solo vincendo questa diffidenza, uno riesce a entrare in contatto con le persone delle comunità".
Oltre che di numerosi saggi e articoli, Mario Maffi è autore de La Cultura Underground (1972), uno studio sulla cultura giovanile negli anni '60; Le Origini della Sinistra Extraparlamentare (1975), un'analisi delle matrici storiche dei movimenti politici giovanili; La Giungla e il Grattacielo. Gli Scrittori e il Sogno Americano, 1865-1920 (1981), che esamina la produzione letteraria americana tra Guerra Civile e Prima Guerra Mondiale in collegamento con le problematiche sociali del periodo; Nel Mosaico della Città. Differenze Etniche e Nuove Culture in un Quartiere di New York (1992), una ricostruzione della complessa storia culturale del Lower East Side, quartiere storico d'immigrazione, pubblicata anche in Olanda e negli Stati Uniti; New York. L'Isola delle Colline (1995), un "libro di viaggio" strettamente legato al precedente e ancora ispirato dall'esperienza di ricerca nel Lower East Side. Insieme a Guido Fink, Franco Minganti e Bianca Tarozzi, Maffi è anche autore della Storia della Letteratura Americana (1991). Ha curato l'edizione italiana delle opere di svariati autori statunitensi e, più recentemente, due antologie di scrittori asiaticoamericani (Voci dal Silenzio. Scrittori ai Margini d'America ), e messicoamericani e portoricani (Voci di Frontiera. Scritture dei Latinos negli Stati Uniti). Ha da poco terminato un libro intitolato Sotto le Torri di Manhattan. Maffi insegna letteratura americana all'Università Statale di Milano e fa parte della redazione di Ácoma. Rivista Internazionale di Studi Nordamericani.


