L'edicola digitale delle riviste italiane di arte e cultura contemporanea
Juliet Anno Numero 89 ott-nov 98
INCUBO N. IX
Bernhard Rüdiger
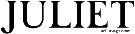
Art magazine
Adrian Paci
Maria Vinella
n. 173 giugno-luglio 2015
Case chiuse, corpi aperti
Roberto Borghi
n. 172 aprile-maggio 2015
Yang Xinguang e la materia
Sara Bortoletto
n. 171 febbraio-marzo 2015
Eugenio Re Rebaudengo
Giulia Bortoluzzi
n. 170 dicembre-gennaio 2015
Biennale Architecture
Gabriele Pitacco Marco Gnesda
n. 169 ottobre-novembre 2014
Biennale Marrakech
Emanuele Magri
n. 168 giugno-luglio 2014

Apre una stanza chiusa. Su grandi ruote dentate sta rigida, seduta con i pugni serrati, lo sguardo iracondo, una bambina piccolissima. È immobile da un tempo infinito. Grasso ed escrementi incrostati hanno rinchiuso il corpicino in una massa dura.
Falciato si domanda come abbia potuto dimenticare. Guarda i piccolissimi pugni rigidi dai calli scuri, serrati da una forza inverosimile. Un risucchio intenso quanto immobile serra un ciuccio contro le labbra livide.
Angoscia e vergogna per aver dimenticato e impensabile sofferenza di questo piccolo essere così violento nella sua immobilità. Lo afferra per staccarlo dalla massa di croste; ma libera la bambina è disgiunta e come dissossata. Nelle sue mani è carne bianca, inerme, incapace d'ogni reazione.
La lava e la lava a lungo e infine la bambine gli è seduta davanti, lo stesso sguardo iracondo e i pugni serrati. Le stacca il ciuccio dalle labbra ma subito la bambina asfissia. Cerca di rianimarla, la chiama e preso dal panico le rinfila il ciuccio. La bambina si riprende. Non è logico. L'interno della bocca non è cavo, ma pieno di una massa grassa e nera, resta solo lo spazio per il ciuccio. Non si capacita e si accorge che da tutte le fessure cadono delle pietruzze scure, pezzi rammolliti di grasso nero come petrolio; dalle orecchie, dal naso, poi anche dalla bocca: lo raccoglie, sopra e sotto spuntano le radici bianche dei piccolissimi denti rimasti incastrati.
(Si sveglia. Terrore; pensa: non si può dimenticare il proprio territori ).
Sono passati sei mesi da questo incubo (n. IX, perché il nono ad avermi aiutato a pensare altrimenti) e mi sveglio ancora affetto da immagini angosciose. Ma non vi è ormai più nulla da vedere. Solo forme astratte e nere, sagomate, tagliate, incalzano. Ogni mio sogno è astratto da qualche tempo.
Gli escrementi solidi e neri della bambina dimenticata nell'ultimo incubo, hanno riempito tutto il mio campo di visione. Colpevole li ho raccolti, perché il territorio è necessità d'ogni opera, orizzonte solido e oscuro, luogo d'azione e di terrore.
Come ho potuto per così tanto tempo non riconoscere l'autonomia del territorio in cui si iscrive l'opera? Come ho potuto accettare questo luogo comune secondo cui l'opera si iscrive semplicemente nella realtà!
Ogni opera ha una cornice, perché ogni opera richiede a chi la guarda di avvicinarsi, di compiere i gesti necessari affinché il rito del vedere (e poi l'eucarestia della visione) si possa compiere. Ma proprio quel porsi nella realtà che una volta era garanzia di autentica esperienza, non è diventata oggi (17 aprile 1998) un'evidenza che offusca la visione e impedisce ogni avvicinamento?
Il reale ha incarnato per più o meno un secolo l'idea che l'esperienza, anche se molteplice e complessa o addirittura contraddittoria, è vera perché reazione simpatica e sensibile ai fenomeni dell'esistente. Questo immergersi, non più proiettivo e risultato della volontà (come potevano pensarlo Kasper David Friedrich o Hölderlin o anche Rousseau), è diventato un vero e proprio sentire il mondo, un guardare nelle viscere dell'esistenza chiudendo gli occhi per amplificarne tutte le nostre sensazioni.
"Nello stato d'animo plastico la sensazione è veste materiale dello spirito.
E con ciò finalmente l'artista creando non guarda, non osserva, non misura, non pesa; egli sente, e le sensazioni che lo avvolgono gli dettano le forme e i colori che susciteranno le emozioni che lo hanno fatto agire plasticamente.
Usciamo dalla pittura? ... Non lo so. Purtroppo la mente umana opera tra due linee d'orizzonte ugualmente infinite: l'assoluto e il relativo, e tra queste la nostra opera segna la linea spezzata e dolorosa della possibilità" (Umberto Boccioni "Pittura e scultura futuriste" a cura di Zeno Birolli, ed. SE, Milano 1997).
Potremmo noi oggi parlare alla stessa maniera dell'esperienza del reale? Non intendiamo invece dicendo 'realtà', la sintesi che dà rilievo a un carattere tipizzante, che così riassume caratterizzando invece di fare esperienza sentendo? Quando si dice reale si intende soprattutto il luogo comune che meglio caratterizza una situazione e proprio questo luogo comune ci tiene a distanza di sicurezza da quelle esperienze che potrebbero in maniera così pericolosa ridar vitalità a un rapporto critico col mondo.
Ridurre l'opera a fenomeno o a personale problema di gusto, perché semplicemente uno dei caratteri possibili della realtà, equivale a negare l'intelligenza e la sensibilità percettiva dell'uomo. Privilegiando ciò che caratterizza, ci riferiamo sempre di più alle avanguardie del nostro secolo, e sempre con maggior veemenza ne rivendichiamo la nostra discendenza giustificando così i nostri comportamenti. Sembra rassicurarci l'idea che una società "moderna" ha bisogno di noi, perché avrebbe bisogno di un continuo sconfinamento. Ma riprendere forme e comportamenti senza rivederne le idee che li hanno prodotti non è altro che un mancato atto di responsabilità. Avere dimenticato che ogni opera si pone rispetto a un territorio è la più grave colpa di questa mia generazione, perché questo impedisce la produzione di un qualsiasi linguaggio. Usare parole come luoghi comuni, che vuol dire pretendere di formulare frasi senza conoscere una grammatica alcuna è pretenzioso e diventa un peso inutile per ogni società.
Ritrovare la necessità dell'opera rispetto a una società vuol dire creare il territorio dell'opera, ritrovare la nicchia bianca e astratta rispetto alla quale l'opera risalta, vuol dire inventare un proprio museo, che altro non è se non il rito che permette di sopportare dei contenuti pericolosi e veicolare il terrore che ne risulta.
Il territorio dell'opera è l'orizzonte da cui gli elementi del linguaggio si distaccano e prendono senso perché si organizzano rispetto a un fondo formando una grammatica. Non si può semplicemente presupporre l'esistenza di un'orizzonte, non vi è niente di più fisico e di di più vero del luogo.
La solitudine non è forse stata mai così assoluta per l'artista. Mi ritrovo a compiere un lavoro sproporzionato costruendo di opera in opera dei luoghi dove posare il piede al prossimo passo. Sogno solo forme nere e astratte perché non riesco più neanche a immaginare di trovare un giorno il luogo; quell'orizzonte finalmente collettivo che ci permette di distinguere il vuoto, l'abisso, il nulla, che si trova dietro, dalle forme che prendono senso davanti.
Solitario vagare in un oceano informe in cui la sola volontà mi fa guardare avanti lungo la linea del mio naso. Mi arresto a discorrere con qualche spirito ormai stanco; Malevitch, Boccioni, Eisenstein, Schwitters, si intrattengono animati ma con cortese distanza. E anche io dal lato mio non mi permetterei mai di farmi scorgere a pensare che quella loro idea che tutto è natura, dallo spirito all'ala lucente di un'aereoplano, è forse sorpassata e anche un tanto ingenua. E poi in nome di quale società potrei parlare? Dunque taccio perché consapevole che il vantaggio mi è dato solo dal tempo che procede inesorabile e che in questi ultimi ottanta anni ha reso sempre più relativo il concetto di realtà. Proprio il tempo ha preso di contropiede quell'arte che si vuole un po' troppo figlia del proprio tempo, traendola nella tanto rivendicata realtà. Le ha tolto quel territorio oscuro e profondo da cui solo può sorgere la forza dell'azione.
I miei sogni sono neri ma certamente futuri.


